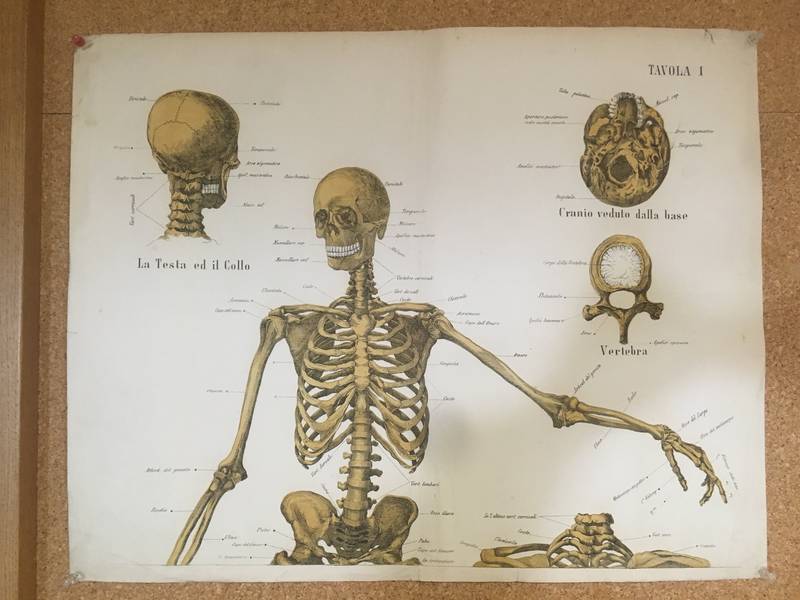Avevamo perso la rotta, la bussola, l’orizzonte del tempo.
Intorno a noi solo mare. Calmo. Nessuna tempesta. Poco vento sulle vele della nostra nave. Nessun confine di separazione dal cielo.
Il mare guerreggiava stanco, contro sottili lame di sole e l’umido scudo dell’alba. La tempesta era fuggita a Ovest, alle spalle di un mondo oscuro. Il vento soffiava singhiozzi smorzati, come un neonato che sta per addormentarsi dopo un pianto dirotto o come un uomo ferito nell’attimo sospeso tra la vita e la morte.
Così avviene, quando la disperazione che si dibatte, alla ricerca di una via d’uscita, si arrende alla mancanza di forze.
L’odore del sale e quello della pioggia ristagnavano sul legno del pontile, a poppa, che percorrevo a passi incerti. Le assi cedevano quel tanto che basta da farmi temere di precipitare, da un momento all’altro, giù nella stiva. O all’inferno.
Forse era il mio peso il problema. Mettendo sulla bilancia la mia anima da una parte e il mio corpo dall’altra, mi resi conto dell’inconsistenza di ciò che avevo dentro. E mai come in quel momento ebbi la sensazione dell’inutilità di buona parte della mia carne e dei miei muscoli sulle ossa.
Ero coperto di abiti intrisi di umido e salsedine. Le maniche larghe della camicia chiara pungevano la pelle delle mie braccia, procurandomi piccoli brividi. Il gilet di concia fresca era rigido come un’armatura. I pantaloni e gli stivali erano ormai un tutt’uno, così pesante da rendere ogni passo una piccola tortura.
Nulla appariva grave, comunque. Tutto sembrava assumere il rango di lieve e persistente fastidio. Anche il più inutile dei pensieri, come quello che mi stava ora tormentando.
Mi accorsi con la coda dell’occhio di avere ancora un mozzicone tra le labbra. La consapevolezza lo mutò in un oggetto estraneo, insopportabile. Così come il fumo che sputai in un soffio denso, rabbioso. Lo osservai scomparire nell’aria rarefatta e provai un senso di sollievo.
Era evidente che qualcosa era appena accaduto. E che qualcosa sarebbe potuta accadere presto. Mi trovavo, perciò, in quel limbo di inconsapevolezza che, in genere, dura solo pochi istanti. Ma che, per qualche misteriosa ragione, non sembrava volermi abbandonare.
Ero consapevole, eravamo consapevoli, di un’unica apparente verità: l’evidenza può essere parecchio ingannevole, più di ciò che sembra e non è.
Quindi, ci guardavamo. Ci guardavamo e ci riguardavamo, noi dell’equipaggio. Non eravamo molti. Riuscivamo a riconoscerci. Ci compiacevamo del fatto di essere vivi e di non essere soli. Ma non sapevamo chi eravamo e cosa facevamo lì, in quel tratto sperduto di un Oceano ignoto.
Non ero solo.
«Capitano Adam, ho trovato una bandiera nuova di zecca, giù sotto coperta.»
Mi voltai lentamente e mi soffermai a fissare la luce negli occhi scuri, come brace appena spenta, del nostromo Aldebaran.
Un unico ciuffo di capelli grigi, essiccati dal sale, gli copriva la parte destra del volto sotto la bandana incolore. Probabilmente, un tempo sarebbe stata gialla, o addirittura arancione. Ma adesso era talmente sporca e usurata dal sole, e dal tempo, da formare una calotta compatta, insieme ai pochi capelli rimasti.
Aldebaran teneva tra le mani un grande pezzo di stoffa nero e liso, con delle chiazze bianche al centro. Quella che per lui era una bandiera nuova, ai miei occhi era un misero straccio.
Mi sentii subito confortato dal fatto di aver riconosciuto uno dei miei uomini. Di ricordarmi il suo nome e le sue fattezze. Di non sentire estraneo il suono della sua voce, che penetrava l’aria umida del mattino come la lama di una sega su un’asse di legno fradicio.
D’altro canto, realizzai di aver sentito pronunciare il mio nome come se lo stessi ascoltando per la prima volta.
L’origine dei nomi, invece, non mi sconvolse più di tanto. Così come il loro senso di continuità all’inizio di un alfabeto. Guardai il cielo, pensando alle stelle, alla notte che non ricordavo. Ci passai su con un pensiero distratto. Per nulla analitico.
Era come se tutto si stesse formando intorno a me. Dalla a alla zeta. Dallo zero all’infinito. Secondo un ordine sequenziale, un percorso lineare, ancora privo di alfabeti, di parole, di punti di riferimento, di cifre, di somme e di sottrazioni. Di moltiplicazioni e di divisioni. Tutto ciò che, in fondo, caratterizza la vita degli uomini che si incontrano su questa terra: si uniscono, si dividono, aumentano di numero o diminuiscono in piccoli o grandi gruppi.
Così, al termine di quel ragionamento, mi parve assolutamente naturale che io fossi Adam. E il mio nostromo Aldebaran.
Il marinaio mi sorrise, mostrando una dentatura priva di una struttura logica. Anche le sopracciglia grigio fumo, che accompagnavano le rughe della fronte in un’onda profonda e ricca di passato, si inarcarono ammiccanti.
Con un rapido movimento delle braccia, stese la bandiera tenendola per gli angoli superiori e me la mostrò orgoglioso. Quelle chiazze bianche, disegnate sulla stoffa nera, tratteggiavano i contorni vaghi di caratteri di una lingua sconosciuta. Probabilmente, si trattava di una lingua orientale. Almeno così sosteneva la mia mente, ricostruendo il modello di un’immagine che portavo dentro.
Al centro del drappo, c’era anche una chiazza rossa. Sembrava sangue rappreso, pensai. Ma, al bivio tra cercare di comprenderne l’origine o dimenticare anche quel dettaglio, scelsi di dimenticare.
Ero il capitano Adam. Ero il capitano di quella nave. Era una nave clandestina, senza identità, perduta nell’Oceano.
Cercai nella memoria un’immagine di me, ma faticai a trovarne una. Provai allora a trovare un riflesso del mio volto nel medaglione d’oro che portavo al collo. Una reliquia che pareva ricondurmi al ricordo di una mamma che poteva avermelo donato.
Pensavo di avere circa trent’anni, forse trentatré. Anche se il valore e il contenuto di tutto quel tempo passato in vita mi era completamente sconosciuto.
Avevo una barba ispida. La pelle secca e scura, come le ciocche di capelli che riuscivo a vedermi scendere dal capo. Ero alto più del marinaio che avevo incontrato. Mi sentivo forte nel mio corpo. E mi convinsi di avere gli occhi chiari dello stesso colore del mare che mi circondava e che sentivo come parte della mia stessa anima.
Stavo, passo dopo passo, provando a ricostruire il mio presente. Galleggiavo ancora in un passato ignoto.
Così, trascorsi alcuni secondi a guardarmi intorno e a osservare la struttura e le condizioni dello scafo.
Dalla posizione in cui mi trovavo, mi sembrava di governare un veliero molto grande, in buone condizioni. L’albero su cui si stava ora arrampicando Aldebaran per issare la nuova bandiera era quello più vicino a me. E io mi trovavo distante parecchi piedi dal centro della nave.
Poi ce n’erano un altro paio. Uno da una parte e uno dall’altra. Con le vele di tela grezza, pesante. Vele che, senza vento, sembravano palpebre socchiuse che stavano per arrendersi alla stanchezza. Pendevano dai pennoni, dondolando, consapevoli dell’impossibilità di trascinare lo scafo verso una meta qualunque.
Mi voltai, scosso da un verso gutturale di una lingua strana che proveniva dalle mie spalle. L’uomo che era in alto, a poppa, mi sorrise. Subito riconobbi, nelle sue fattezze essenziali e ossute, un altro marinaio del mio equipaggio: il timoniere Canopus.
Canopus non era delle nostre parti. Questo credevo di saperlo. Lo tradivano le linee spigolose del volto, che parlavano da sole una lingua straniera. Ma ora mi appariva solamente estraneo.
Nonostante ciò, gli feci un cenno di conforto. Volevo rassicurarlo che tutto era ormai in equilibrio, nonostante il rollio che minava la mia capacità di controllo.
Decisi di scendere verso prua. E, per fare questo, mi toccò di superare gli sguardi di alcuni marinai della mia ciurma.
Li passai in rassegna, ricordando anche i loro nomi.
Sargas, un marinaio zoppo e privo di una parte della faccia sul lato destro, strappata da un colpo di sciabola o da chissà che cosa. Indossava un mantello scuro sopra gli abiti, perché sembrava tremare e soffrire il freddo anche quando era esposto al calore violento del sole.
Tabit, il cuoco della nave sempre alla ricerca di vivande prelibate e di rhum pregiato in cambusa, per placare la fame e la sete di chi non avrebbe esitato a gettarlo in mare per qualsiasi sgarro.
Dabih, un marinaio del sud, dalla pelle di brace e dai capelli nero pece, capace di sgozzare anche sua madre, se fosse stato necessario, o anche solo utile.
Due di loro sembravano spaventati. Uno, addirittura, terrorizzato. Distolsi lo sguardo dagli occhi dilatati di Dabih, considerando impossibile scoprire segni di paura in un uomo che appariva privo di scrupoli.
In cima alle scale guardai il cielo azzurro, limpido. Non mostrava neanche un’insignificante velatura.
Il sole era ormai abbastanza alto e caldo da confortare la vista e le membra. Il mondo sembrava essersi messo al posto giusto, nelle vaghe mappe che avevo disegnate in mente.
Scesi di un gradino. Poi di un altro.
Un refolo di vento mi colpì come uno schiaffo. Le mie narici furono invase da un olezzo insopportabile, di marcio e putrido. Un suono strisciante, prodotto da un movimento viscido, trascinò la mia attenzione e i miei occhi verso il basso, in fondo alle scale. Dove non avevo ancora guardato.
Il ponte era interamente ricoperto da un grumo compatto di bestie. Forse di topi. Quella compattezza brulicante, che credevo frutto di un’illusione, si sciolse rapidamente in mille e più contrazioni. Flussi e reflussi di animali. Di code, di esseri prima pelosi e poi translucidi che sembravano riversarsi giù in mare e poi risalire.
D’istinto cercai di ritornare indietro, verso l’alto, inciampando sul gradino alle mie spalle e rischiando di cadere giù.
Il pensiero di poter essere inghiottito da quella massa informe, figlia di una biologia ignota, mi diede la forza disperata di aggrapparmi a qualcosa.
Così, mi sembrò di restare sospeso alcuni istanti nel vuoto. Mentre i topi, davanti ai miei occhi, si trasformavano in pesci.
Non potevo credere a ciò che stava accadendo.
Pesci di ogni fattezza e dimensione si dibattevano ora sul pontile. Alcuni precipitavano giù in acqua, ritrovando il loro ambiente naturale. Altri ristagnavano morenti, soffocati dall’aria, come se una rete li avesse improvvisamente imprigionati e sbattuti lì sulla mia nave. Altri ancora apparivano dal nulla, risalendo forse da una sponda del veliero.
Mi voltai per trovare lo sguardo dei miei uomini. Per capire se non stessi sognando quel folle e disgustoso spettacolo che avevo sotto agli occhi e a pochi passi dai miei piedi.
Sargas, Tabit e Dabih non c’erano più. Canopus si era portato al timone e aveva lo sguardo fisso verso l’orizzonte. Aldebaran pareva una stella incolore nel cielo: era arrivato quasi in cima all’albero più alto del veliero e stava issando la bandiera.
Io ero da solo, senza alcun conforto, davanti all’orrore. Mentre gli odori si confondevano con i suoni, penetrando nei miei sensi e nella mia mente. Si dilatavano e si trasformavano in un disgusto che rendeva difficile riportare lo sguardo verso il basso.
Ci riuscii solamente quando ebbi la certezza che tutto era finito. La certezza mi nasceva da una convinzione interiore. Mi sentivo nuovamente sereno, in pace con me stesso.
Mi ero detto che anche la più feroce delle verità nasconde un’illusione. L’illusione che nulla finisce davvero.
Non c’erano più bestie. Né topi, né pesci.
Così, con circospezione, riprovai a scendere verso il basso. Prima un gradino, poi un altro.
A un primo fugace sguardo, però, non ritrovai il ponte sgombro come l’avevo immaginato. Una massa informe, sotto di me, sembrava ora immobile, compatta.
Provai a guardare con più attenzione e fui colpito su tutto il corpo da un’onda infinita di dolore e di disgusto.
Il ponte della nave era adesso ricolmo di cadaveri di uomini.
Ero sospeso, paralizzato, di fronte all’orrore. Forse aspettavo di svegliarmi da un istante all’altro. Di svegliarmi in un luogo diverso da quello, in un letto normale. Di svegliarmi e ricordare quello che ero e quello che sono adesso.
Chiusi gli occhi per alcuni istanti e mi lasciai andare dentro una vertigine a spirale. Tentavo di fuggire dentro l’incoscienza per poi riemergere e ritrovarmi fuori da quell’inferno.
Tornai, invece, a guardare il cielo di prima. Sempre limpido e ubriaco di sole. Tornai a vedere lo scempio di umanità che avevo ai miei piedi.
Alcuni corpi erano addirittura privi di forma. Arti, membra e viscere si mescolavano tra loro e seguivano il movimento delle onde lente. Incrociai gli occhi di terrore di due o tre teste che rotolavano mostrando un profilo o l’altro. Avevano la pelle scura e inciso in ogni tratto, in ogni spasimo ultimo, definitivo, tutti i segni dell’orrore.
Altri corpi erano intatti. Sembravano quasi dormire, quegli uomini che erano stati guerrieri, se non fosse stato per il colore livido della pelle. Un grigio di fondo, sporcato da larghe macchie gialle. Gialle e regolari nella loro perfetta circolarità.
Che cosa era accaduto? Chi aveva fatto strage di quegli uomini dilaniati? Quale maledizione, quale malattia avevano colpito questi altri?
Il mio veliero sembrava essere appena uscito da una battaglia e da una pestilenza feroci. Due disastri che parevano aver colpito i miei uomini in contemporanea e con la medesima forza devastante. Senza che nessuno di loro manifestasse, scolpito nei tratti paralizzati della rigidità della morte, un minimo singulto di difesa, o di resistenza.
Noi, però, eravamo vivi.
Alle mie spalle c’era adesso la mia ciurma. Guardavano con me quello spettacolo di morte mutilata, putrida. Pregavano in silenzio non si sa quale dio. La preghiera era un lamento, in realtà. Una cantilena che si sciolse ben presto in un mormorio sbiadito.
Nessuno di noi ricordava nulla. Nessuno sapeva quello che era successo nelle ore precedenti. Era trascorsa una notte. Una notte in cui non c’erano sogni da ricordare e neanche incubi. Perché l’incubo vero lo stavamo vivendo, o sognando, adesso.
Iniziammo a toccarci, poi ad abbracciarci, per ritrovare certezza del nostro essere concreto. Poi ci contavamo e ci chiamavamo per nome. Li contai tutti, li riconobbi tutti.
Oltre a me, su quel veliero, c’erano undici uomini. E nessun altro in vita.
C’era Aldebaran, il nostromo. C’erano Canopus, il timoniere, Sargas, Tabit e Dabih. E poi contai altri sei marinai.
C’era Enif, una figura esile, quasi trasparente. Il corpo fragile reggeva a stento un volto da faina, su cui si innestava un naso da maiale. A fare da cornice a quella sproporzione, sulle narici carnose si innestavano due lenti tonde. I ferri sottili e dorati che le tenevano insieme, sembravano conficcarsi nei pori larghi, tra la pelle squamata dal sole.
C’era Wezen, un uomo enorme, con la carne debordante dagli abiti curati, tanto eleganti da essere fuori luogo e fuori tempo. Aveva la pelle nero pece che contrastava con il bianco impeccabile della camicia, e un orecchino d’oro a cerchio che pendeva dal lobo sinistro.
C’era Nekkar, un tipo di campagna che sembrava lì per caso e nulla pareva avere del marinaio. Uno che amava gli animali tanto da raccontare storie bucoliche che servivano a tenere sveglie le vedette nella notte. Aveva uno sguardo fisso, anche durante le sue narrazioni. E spesso lo si vedeva con un piccolo gattino, arrivato chissà da dove, tra le braccia forti e possenti.
C’era Fomalhaut che, al contrario, sembrava nato in mare. Era lui che recuperava in un baleno qualsiasi cosa fosse sfuggita al nostro controllo e caduta in acqua. Era capace di tuffarsi dalla parte più alta della poppa e di risalire in pochi attimi aggrappandosi a una cima che qualcuno gli lanciava a caso, senza curarsi molto di dove sarebbe caduta.
C’era poi Gianfar, che non mangiava quasi nulla di solido ma si riempiva la pancia di qualsiasi liquido gli capitasse a tiro. Tanto che, sin dalle prime ore del mattino, puzzava di rhum persino sottovento. Quando non beveva, la sua bocca era perennemente impegnata a succhiare fumo da una pipa di canna, così sottile che sembrava doversi rompere a ogni soffio.
C’era infine Alcor, un tipo codardo e di nessun aiuto per la ciurma, che si nascondeva dietro agli altri per fuggire pure l’ombra di se stesso. Anche i suoi connotati fisici sfuggivano a tutti noi, proprio perché era quasi invisibile in ogni occasione di pericolo o di tranquilla navigazione.
Eravamo rimasti in dodici. Tutti sapevamo tutto, l’uno dell’altro, di ciò che connotava il nostro aspetto, il nostro carattere, i nostri comportamenti. Ma non sapevamo niente del nostro passato. Nessuno, inoltre, sapeva nulla sugli uomini che giacevano dilaniati sulla nostra nave. Li consideravamo nostri compagni, ma avrebbero potuto essere anche dei nemici.
Non avevamo passato, se non quello che segnava la nostra pelle e che ricordavamo di noi stessi e del resto della ciurma. Con ogni probabilità, rischiavamo di non avere alcun futuro.
Presto, infatti, una nuova consapevolezza si diffuse tra di noi: eravamo pochi per governare quella nave. Eravamo pochissimi per la quantità di viveri che trovammo in cambusa. Tabit disse che occorreva razionare il cibo e l’acqua. E che non ce ne sarebbe stato a sufficienza per più di dieci giorni.
«E rhum? È rimasto del rhum? O almeno della birra?», si preoccupò di domandare Gianfar.
Tabit elencò pazientemente il cibo e le bevande su cui potevamo contare, in quantità e in barili. Poca carne salata. Alcuni resti di gallette mangiate dai vermi. Birra e rhum in buona quantità. Aldebaran, nel frattempo, annotava tutto sul libro di bordo che non conteneva altre pagine scritte oltre quella che stava riempiendo.
Sargas si grattò la parte sana del viso con la mano tremante, prima di sentenziare: «Non abbiamo alcuna speranza di sopravvivere. Faremo una brutta fine. Proprio una brutta fine.»
Fomalhaut, che probabilmente credeva di cavarsela semplicemente nuotando sino alla meta più vicina, gli diede uno spintone facendolo cadere ai piedi di Alcor, che si era nascosto dietro un cumulo di funi aggrovigliate.
«Calma, bisogna stare calmi», intervenne Aldebaran mettendosi in mezzo tra Fomalhaut e Sargas, che si era rialzato e avvicinato con piglio minaccioso all’altro marinaio. «Ci salveremo. In qualche modo, in qualunque modo, ci salveremo. Se moriremo, sarà comunque una fortuna. Morire è nulla, quando vivere diventa spaventoso.»
All’improvviso, si alzò un vento minaccioso che prolungò in un’eco straziante le ultime parole del nostromo.
Il cielo era ancora sereno. Ma l’imbarcazione incominciò a danzare sul pelo dell’acqua e le vele a indicare un nuovo cammino su una rotta ignota.
Il puzzo di carne putrida e di morte si propagò in pochi attimi, costringendoci a ricordare ciò che avevamo scoperto poco prima.
«Gettateli in mare», ordinai. Era la prima volta che provavo a esercitare un potere nei confronti della ciurma. Mi toccò soppesare, dunque, la reazione dei miei uomini. E, per fortuna, da parte di nessuno ci fu una reazione di malcontento. Persino Alcor si era subito unito agli altri ed era diventato l’ombra di Nekkar.
«Non possiamo fare altrimenti», aggiunse sottovoce Aldebaran, che era proprio accanto a me. Poi sputò per terra e digrignò i denti lasciandosi sfuggire un lamento soffocato.
«Fate attenzione a non toccare i cadaveri contaminati e lavorate di buon accordo. Non saranno tollerati litigi e risse. Chiunque sarà di ostacolo alla nostra salvezza, farà una fine ben peggiore di questi poveracci», aggiunsi.
Ero addolorato anch’io. Ma sapevo che prolungare ancora il momento di liberarci definitivamente dei nostri compagni avrebbe potuto essere letale. Anche per noi.
Così, prese avvio l’opera di purificazione della nave. I corpi venivano raccolti in teli, issati con corde spesse e così trasportati fuori bordo. Lentamente abbandonavano il ponte e scomparivano tra le onde, che ora si sollevavano abbastanza da rendere ogni nostro movimento più difficoltoso.
Mi ero trasferito sul ponte più in alto, a poppa. Osservavo l’orizzonte dietro di me e la scia di morte che ci stavamo lasciando alle spalle.
Pensavo che avremmo potuto dimenticare anche questo. Così come avevamo dimenticato tutto il resto. E speravo che domani ci saremmo potuti svegliare senza memoria, così come era accaduto stamattina.
Ogni giorno sarebbe stato non solo un nuovo giorno, ma una nuova vita. Attendendo di trovare un approdo.
«Nulla finisce davvero», mi disse Enif.
Si era avvicinato a me e sembrava essere riuscito a leggermi nel pensiero. Ed era l’unico pensiero compiuto che continuava a tormentarmi dal risveglio.
Guardai oltre il suo naso porcino, dietro le lenti sporche dei suoi occhiali. Nel profondo vuoto delle sue pupille cercai un conforto. Lui sembrò capire la debolezza del suo capitano. Avrebbe potuto approfittarsene, ma era abbastanza intelligente da sapere che potevamo salvarci solo restando uniti, insieme. Solo così avremmo potuto raggiungere una meta, la terra.
La terra era la nostra meta. Perché continuare a vagare nel mare infinito sarebbe stata solo l’agonia prima della fine.
La terra c’era. Doveva esserci. Esisteva da qualche parte un mondo, o almeno un porto. E presto, molto presto, l’avremmo trovato.
Diedi un incarico insignificante a Enif, solo per farlo allontanare. Avevo bisogno di maggiori certezze, di nuovi punti di riferimento. Quindi chiamai Aldebaran e gli chiesi di portarmi delle mappe. Dovevano essercene senz’altro, da qualche parte, nei miei alloggi.
Infatti, il nostromo tornò poco dopo, tenendo sotto braccio un paio di grandi pergamene ingiallite.
Srotolai la prima, ponendomi in favore della luce del sole. Su quella pergamena erano disegnati accuratamente un insieme di animali. C’era un elefante. C’era una tigre. Ma anche un toro, degli uccelli maestosi, un gallo e un piccolo cane. Ognuno di loro sembrava un’isola in un mare immenso. Ogni animale, infatti, non aveva contatti con gli altri. Ogni animale era un piccolo mondo separato dal resto del mondo.
Aldebaran non disse nulla. E non sembrò neanche meravigliato dal contenuto della prima mappa. La riprese. La arrotolò e mi diede la seconda. Quando la aprii, per poco una folata di vento non me la strappò via. Quello che una mano esperta, precisa, accurata aveva disegnato era un insieme di cose immaginate, o immaginarie. C’erano delle piccole navicelle volanti. C’erano altre navi con delle ali. D’istinto, mi venne di chiamarle “aeroplani”, associando l’immagine davanti a me a qualcosa che custodivo nella memoria. C’erano oggetti di un mondo che non conoscevo, o forse, semplicemente non ricordavo. Erano semplici rappresentazioni, senza significato nel mio presente.
Chiesi ad Aldebaran di portare via le mappe. Restai per un certo tempo a meditare e ad ascoltare il suono degli schiaffi delle onde sullo scafo, che si alternò a lungo con il tonfo ritmato dei corpi che cadevano in acqua.
Pensai a lungo, componendo ragionamenti sul nulla. Pensavo, per esempio, quanto il futuro possa essere determinato dal passato. Siamo e saremo davvero il risultato di quello che siamo stati? Cosa possiamo fare per cambiare il corso casuale delle cose? Possiamo scegliere i simboli, le percezioni che vogliamo per aggiungere pezzi concreti di realtà?
Senza passato, anche il nostro libero arbitrio non aveva fondamenta su cui costruire qualsiasi decisione. Potevamo immaginarlo. Potevamo pensare di ricomporre pazientemente tutte le immagini che emergevano dai nostri scavi interiori.
Ma avremmo avuto il tempo di farlo? Che spazio e che tempo ci avrebbe potuto concedere il nostro destino?
C’era un brusio ora nella mia mente. Un insieme di voci che forse provenivano dal mio passato ignoto. Socchiusi gli occhi per ascoltare meglio quelle voci. Ma non riuscivo a decifrare nulla di ciò che tendeva a ossessionarmi.
Poi, all’improvviso, vinse il silenzio.
Un silenzio irreale si propagò sino a soffocare i nostri respiri, come una mano che stringe la gola per strangolare, senza lasciare possibilità di reazione.
Tutti guardavamo verso il ponte ormai sgombro.
Erano rimasti solo Nekkar e Wezen che, grazie alla loro incomparabile forza fisica, avevano portato a termine gran parte di quel lavoro macabro. Ma non erano soli.
Noi guardavamo verso di loro. Loro guardavano verso di noi.
Quell’attimo sospeso durò un tempo indefinito, finché non vedemmo apparire alle loro spalle due figure bianche. Bianche e nude. Un uomo e una donna.
Ci avvicinammo tutti, in silenzio. Eravamo attratti dalla vista di quei due corpi eterei, quasi trasparenti.
«Li abbiamo trovati noi», disse Wezen toccandosi l’orecchino tondo sul lobo.
«Sono sbucati dal nulla, improvvisamente, quando stavamo terminando il lavoro. Erano nascosti sotto i cadaveri. Erano abbracciati. Sembravano morti. Poi hanno incominciato a muoversi. Hanno aperto gli occhi e si sono alzati in piedi», raccontò incredulo Nekkar.
Superando il senso di disorientamento dovuto a quella improvvisa apparizione, pensai che i due ragazzi avrebbero potuto darci qualche spiegazione su ciò che era successo e sulla catastrofe che aveva colpito la nostra nave.
Erano vivi, come noi. Quindi, incominciai a interrogarli.
«Come vi chiamate?»
«Schedir», rispose lui fissandomi. Il suo sguardo era limpido, aperto. La sua voce aveva un suono melodico.
«Pleione», disse lei.
Apparentemente, mi sembrò di ascoltare una musica prolungata. Poi mi resi conto che l’uomo e la donna parlavano con la stessa voce.
«Cosa è accaduto? Perché eravate nascosti in mezzo ai cadaveri? Chi li ha fatti a pezzi? E chi voleva farvi del male?», domandai.
Schedir e Pleione mi guardarono a lungo, quasi non capissero quello che stavo chiedendo loro. Forse non capivano la nostra lingua.
Stavo per ripetere le domande, quando incominciarono a intonare all’unisono una melodia fatta di parole ignote. Si presero per mano e presero a danzare, con movimenti lenti e sinuosi.
Loro danzavano, sul ponte di prua del nostro veliero. Danzavano e cantavano in una lingua sconosciuta. I loro corpi sembravano indivisi. Un’unica forma, un’unità che nasceva da due esseri perfettamente compatibili e armonici.
Noi li guardavamo, sconfitti ed estasiati. Estasiati da quello spettacolo che pareva rubato da un paradiso. Sconfitti dal non riuscire a comprendere perché ci eravamo svegliati in quell’inferno.
Guardavo i loro corpi nudi e in loro vedevo la mia anima. Erano corpi candidi, bianchissimi, privi di pudore e di vergogna.
Osservandoli meglio, però, mi accorsi di un piccolo segno di discontinuità: sulla pelle di Schedir, appena sul lato sinistro dello sterno, c’era la linea di una cicatrice. Un lieve solco, ancora più bianco del bianco, segnato da contorni rosacei.
Cosa poteva voler significare quel segno? Un unico segno su quel corpo, un unico segno nella mia anima?
D’istinto, la mia mano, le mie dita si insinuarono sotto il gilet e dentro la camicia. Al tatto, ebbi l’esatta percezione dell’esistenza dello stesso solco sul mio sterno, sempre sul lato destro.
Non avevo bisogno di guardarlo, perché lo vedevo lo stesso. Il solco che stavo attraversando con le dita si trovava dentro al mio sguardo ora perso all’orizzonte, verso Occidente.
Quella terra di confine dove si fondono due mondi ignoti, dove mare e cielo si toccavano di continuo ormai da ore senza alcuna discontinuità, si colorò di scuro.
Forse la notte stava per tornare.
Un urlo improvviso spezzò il canto e la danza di Pleione e Schedir.
«Terra!»
Ci voltammo tutti verso Canopus, che era tornato al timone.
Aveva imparato la nostra lingua. Apparteneva a lui quella voce che risuonava ora in echi continui nelle nostre orecchie.
Poi tornammo a guardare a Ovest, l’orizzonte più lontano.
Non era la notte.
Era l’approdo.
In copertina: William Turner, The Shipwreck, 1805 © Tate