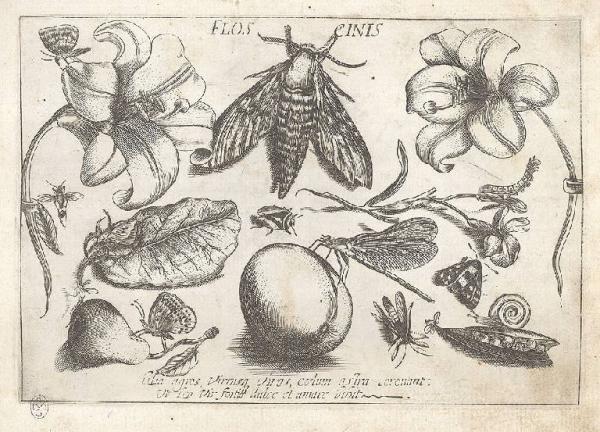[di Archibaldo Wolff; trad. it. di Dario Abrescia]
Il tragitto dalla sinagoga a casa era breve, ma questo non aveva impedito alla pioggia battente sulla Breestraat di infradiciargli mantello e cappello. Si lasciò alle spalle la nebbia spessa che sembrava levarsi dal canale e si immerse in quella rarefatta che il paiolo sul fuoco dispensava nella cucina. Il calore improvviso e i pensieri che gli affollavano la mente gli offuscarono gli occhi; fu solo un attimo.
Hanna era china sul grande tavolo a tagliare le verdure per la zuppa. Il rumore della porta che si apriva e la lama di gelo che si era insinuata nella stanza l’avevano fatta per un attimo drizzare e voltare.
Il ragazzo, forzando la propria natura – il cibo non gli era mai interessato molto – si avvicinò al tavolo e chiese alla donna cosa stesse preparando per pranzo. Hanna rispose con voce solenne e allegra, senza sospendere l’amministrazione del rito della preparazione del pasto principale. Lui fece per lasciare la cucina, ma sulla soglia si fermò. Tornò indietro e si sistemò dall’altra parte del tavolo, davanti alla donna. Aveva lo sguardo basso, come se stesse pensando a qualcosa, raccogliendo le idee. Poi lo rialzò, fissandola; i suoi occhi erano scuri e lucenti.
«Tu credi in Dio, Hanna?»,
«Signorino… come sarebbe a dire?».
«Ti ho chiesto se credi in Dio, se pensi che esista».
«Certo, sì, credo fermamente nell’esistenza di nostro signore Iddio. E in quella della Vergine Maria, di Gesù Cristo, dei santi…».
«Fermiamoci a Dio, Hanna».
La donna aveva posato il coltello sul tagliere, si era asciugata le mani al grembiule e ora le teneva appoggiate sui fianchi. Il giovane le si era fatto più vicino, quasi accanto.
«Secondo te dov’è che vive Dio? Dov’è che si trova?».
«Dio è nel cielo. In paradiso. Non so. Il pastore Colerus dice che ci guarda senza sosta, ci controlla. E protegge i giusti».
«Con tutto il rispetto per il nostro pastore e per voi gentili, Hanna, qui sei tra ebrei, sefarditi. Ma non è questo il punto. Il tuo Dio, il mio, non è in nessun luogo, e in tutti. Dio è il mondo e il mondo è in Dio. Quel paiolo è Dio, Hanna».
«La pentola? È anche là dentro nostro Signore… ma che dite?!».
«Pensaci. Dio è ovunque e ovunque è Dio stesso. È sostanza di tutto. Tutto è Lui e tutto è necessariamente perfetto. Tutto è già scritto. Non c’è margine per cambiare le cose. Qualsiasi cosa».
«Mi state facendo paura signorino. Volete che vada via? Questo mi state dicendo? Ho forse mancato di rispetto a voi e a vostro padre? In tanti anni…».
«No, Hanna, noi vogliamo che tu resti. Io, per esempio, ti voglio un bene dell’anima. Sei tu che mi hai cresciuto. Piuttosto, so che sei tu che stai pensando di andare, di lasciarci».
«No! Che dite?».
«So che la figlia di tua sorella, a Utrecht, è morta. E ha lasciato una bambina. Ti vorrebbe accanto a lei adesso, per crescerla. Proprio come hai fatto dieci anni fa con me, Hanna, quando mia madre ha chiuso gli occhi».
«Sì. Ma io non ho mai pensato di lasciare voi e il signor Michael. Vi prego di credermi. Come potrei? E come fareste senza di me? Come?».
«È proprio questo il punto. Non è importante quello che vogliamo noi o quello che vuoi tu. Il disegno di Dio è già chiaro, già definito. Tu farai quello che è giusto e che già Dio ha dettato».
«Non credo di aver capito».
«Non opporre resistenza. Lasciati guidare da Dio e dalla ragione, Hanna, semplicemente questo ti sto dicendo. Tu nel tuo cuore sai cosa è giusto; cosa potrebbe aver mai scelto Dio per te se non il destino migliore possibile?».
«Perché mi dite e mi fate tutto questo? Qual è il senso?».
«Sono un chiacchierone, lo sai, Hanna».
«Sì, è vero, lo so».
Il ragazzo raccolse da un cesto una mela, rossa come le guance accalorate della serva. Si avvicinò a lei e l’abbracciò forte, come si abbraccia una madre, come si abbraccia qualcuno che si sta salutando. Uscì dalla cucina.
Quel pomeriggio nella stanza ingombra di mobili e di articoli da vendere trovò suo padre. Con una scrittura minuziosa e compiaciuta il vecchio riduceva all’ordine uno dei suoi registri. Il ragazzo intuiva che la grafia del padre serviva soprattutto ad alimentare la nostalgia e ad affermare se stesso di fronte a tutti gli altri. L’uomo sollevò la testa dal libro e incrociò lo sguardo del figlio.
«Partirà domattina».
Il figlio tacque.
«Hanna, intendo», continuò.
«Le ho parlato stamane come mi avevi chiesto, padre».
«Sì. E l’hai convinta evidentemente. Ha deciso, va dalla sorella a Utrecht. Non sapevo avesse una sorella».
«Non sai tante cose. Non sei Dio».
«Per questa volta non ti risponderò, figlio mio. Voglio solo ringraziarti. Mi hai tolto un fardello gravoso, devo riconoscertelo. Mi sentivo come se le mura di Gerico dovessero crollarmi addosso. Hanna è con noi da tanti anni, da quando siamo arrivati ad Amsterdam, e licenziarla e dirle che questa casa ha bisogno di due braccia più giovani avrebbe pesato sulla mia anima per giorni o mesi».
«Non devi ringraziarmi padre. Era tutto scritto. Il mondo è perfetto. Siamo noi a non esserlo».
«Era tutto scritto… Al rabbino non piace come dici quello che dici».
«Non piace neppure a te. Ma forse solo perché non piace al rabbino».
«Non ho voglia di discutere adesso. È una bella giornata dopotutto».
Michael Spinoza chiuse il registro e si alzò dalla scrivania.
«Sto andando in sinagoga adesso. Vuoi accompagnami, Baruch?»
«Perdonami, ma oggi ho già dato, padre. E per me non è una bella giornata. Dopotutto».
Archibaldo Wolff
Nasce a Montevideo, condividendo la data, 21 dicembre 1921, con lo scrittore Augusto Monterroso, ai cui racconti sarà dichiaratamente ispirato uno scorcio della sua produzione. Il padre, un piccolo industriale tessile tedesco caduto in disgrazia e riparato in Uruguay due anni prima della sua nascita, lo avvia allo sport (calcio, polo, vela) e al commercio; la madre, un’attrice teatrale di origini scozzesi, alla letteratura. Viaggia e scrive moltissimo, senza però pubblicare mai nulla. Muore annegato, in circostanze mai chiarite, nel 1978 a Punta del Este dove si era ritirato e dirigeva un’estancia e un locale notturno.
Le opere di Wolff (scritte in una lingua ibrida, un misto di castigliano, guaranì e inglese) sono ancora in fase di ordinamento. Il destino è il suo primo racconto tradotto in italiano.
Dario Abrescia
Giornalista, formatore, ludologo, negli ultimi vent’anni ha curato diverse centinaia di libri (racconti, romanzi storici, fantasy, horror, fantascienza, riduzioni dal cinema, fumetti, narrativa per ragazzi) in qualità di traduttore, editor, revisore di traduzioni per Mondadori, Editrice Nord GEMS, Planeta-De Agostini.
*****
In copertina: Jan Vermeer, Giovane donna con una brocca d’acqua, 1660-1662, Metropolitan Museum of Art, New York.