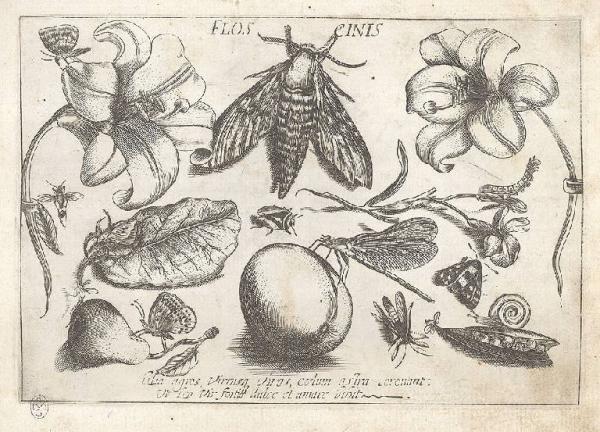Uno due tre. Uno due tre. I tacchi sul pavimento. Le porte scorrono a destra e a sinistra. Se ne vanno ondeggiando. Dietro di lei. In fondo c’è una finestra, ma ancora è solo un cerchio di luce. Le porte dell’ascensore si chiudono con un tintinnio elettrico. Lei si aggiusta la frangia e stringe la borsetta. Ne ha visti tanti di corridoi del genere, lei. Molte non sanno neanche come si cammina in un corridoio. Lei invece lo sa. È per questo che la pagano più delle altre. È importante saper mettere un tacco dietro l’altro senza fare troppo rumore. Il rumore può essere interpretato come un segno di agitazione e questo non deve accadere. Il rumore deve essere sfruttato: non troppo arrogante o remissivo, ma dignitosamente consapevole della propria sensualità. È necessario convincersi di essere sensuali per produrre un rumore idoneo. Il segreto sta nel coordinare i muscoli abbandonandosi al tic-tac delle gambe. Le tue gambe sono come una sveglia che non deve mai suonare. Deve solo fare rumore. Sempre lo stesso rumore. Se il tuo cervello non sceglie i tempi giusti, darai l’impressione che uno dei tuoi tacchi sia sul punto di spezzarsi, o magari tutti e due. Allora qualsiasi rumore perderà significato, non avrà più l’autorità di comunicare un messaggio erotico. Nei tacchi confluisce il potere del corpo e, passo dopo passo, nel ritmo del rumore, si trasmette al suolo. Uno due tre. Uno due tre. Scansiona con la coda dell’occhio i numeri sulle porte chiuse che sorpassa: 19 20 21. La finestra comincia a squadrarsi, ma la luce non aumenta. Aumentano i numeri, ma a lei sembrano tutti uguali. Forse sommati tutti insieme avrebbero un senso, diventerebbero un’unica cifra amorfa e il mondo sarebbe meno uguale e più pulito… i tacchi si bloccano. Silenzio, le porte si fermano. Deviando il mento dal proprio asse si è accorta di avere un’atroce macchiolina ellittica sulla tetta sinistra. Bere il caffè prima del lavoro è un rischio che poche hanno l’ardire di correre. Lei è stata superba. Si guarda attorno, leggermente. Qualcuno potrebbe aprire una delle porte. Potrebbe essere troppo tardi. Potrebbe essere il momento sbagliato. Si avvicina alla bocca il medio della mano destra, solleva il mento, fissa una crepa del soffitto tamburellando il dito sul labbro inferiore, rotea gli occhi senza voltarsi, abbassa la testa e strofina il punto critico, tenendo tesa la stoffa con l’altra mano. Niente panico. Alza la testa e nel rimettere la mano al suo posto si asciuga il polpastrello sulla coscia spiando l’orologio. Sono passati dodici secondi. Il mento è tornato nel proprio asse. Si morde il labbro superiore. Le è andata bene. Ha ancora ventiquattro secondi per raggiungere la 36. Uno due tre. Uno due tre. Le porte ricominciano a scorrere, e con loro i numeri. 25 26 27. La finestra ormai è una finestra e la luce gioca a stropicciarsi sugli zigomi di lei. La pelle scura è resa brillante da un sottilissimo fuoco bianco. Deve strizzare le palpebre per distinguere le cifre. 33 34 35. I tacchi ruotano di novanta gradi affiancandosi sulla stessa retta; il capo s’inclina di diciotto gradi per valorizzare la frangia. La luce adesso investe anche i polpacci e il collo. Le vene si sono gonfiate come le radici di un albero che succhia dalla terra. Al di là del vetro s’intravedono foglie sovraesposte alla luce accecante di un giardino. Non è detto che siano meno vere di una serie di numeri. Respiro trattenuto. Non bisogna sudare. Il braccio si alza, il polso si piega. Tre colpi. Allusivi ma non troppo insistenti, per non infastidire il cliente. Uno due tre. Bocca socchiusa, pupille ridotte allo zero. Nessuna risposta. Aspetta tre minuti e quaranta, poi ci riprova. Uno due tre. Niente. Le hanno detto di farsi trovare lì alle due e quarantotto spaccate; ora sono quasi le due e cinquantaquattro e sembra che in questa stanza non ci sia un’anima. Lei non si muove. Lei è paziente e non chiude le labbra. La porta potrebbe aprirsi adesso e nessuno deve coglierla impreparata. Non sa quale volto possa avere il cliente e non le interessa. Avere preferenze è un concetto perturbante, non deve essere neanche sfiorato. Tutti sono uguali come i numeri che ti osservano attaccati alle porte. Cambia la disposizione delle cifre come cambia la disposizione dei letti nelle camere, ma è solo il trucco di un prestigiatore scadente per far apparire le cose diverse. I numeri lo sanno che sono tutti uguali, e anche le camere. È chi cammina nei corridoi a imporsi la loro diversità. I clienti non sono diversi. I clienti sono numeri e uno vale l’altro. Sono foglie bruciate dal sole di un sistema logico funzionale. Lei è l’algoritmo che accoglie in sé il pieno degli altri, quella calce che entra nel respiro spalmandosi su tutte le cellule attraverso il sangue. Pesanti. I piedi, le gambe, le braccia, le mani: gli strumenti del potere fisico fanno cilecca, si trascinano a fatica, mentre la mente precipita in uno stato di soffocante alienazione. Per non ascoltare la vita che penetra nelle orecchie tutte le mattine come un ronzio inestinguibile, quando al risveglio si riconoscono le proprie lenzuola; per non ascoltare il battito solidificato del nostro cuore, bisogna esiliarlo o sottomettersi a lui definitivamente. O ci liberiamo sistematicamente della calce o lasciamo che essa ci trasformi in una statua. Una statua caricata a molla. Lei ha scelto di indossare i tacchi. Si identifica nel rumore che producono i suoi passi: perché è idoneo, perché lei sa come si usano i tacchi. Quei tacchi che l’hanno portata davanti alla 36, di cui ora si mette a contare le venature: stabilisce di bussare una volta ogni dodici. Un urlo soffiato e schifosamente tenero proviene da dentro. L’urlo di una bambina, forse. Una preghiera embrionale, remotamente sommersa da una torre infinita di cuscini. È un rumore non idoneo. Eccessivamente non idoneo. La voglia di fuggire la pervade, ma i tacchi le si sono paralizzati. Abbandonare il posto sarebbe poco professionale. I tacchi lo sanno. Lei lo sa. Per lei è importante far cessare quel rumore non idoneo. Farlo fuori. Ma la porta è chiusa e non può essere sfondata. Il conteggio delle venature non serve a niente: i minuti passano, la maniglia resta immobile, l’urlo persiste. Tutta la speranza di lei si colloca nel buco oscuro della chiave. Apre la borsetta e ne cava fuori lo specchietto per il trucco. Rapida occhiata di qua e di là, non si sa mai: il corridoio è deserto, l’ascensore non ha mai tintinnato una seconda volta, le foglie non si muovono più. Il giardino pare essersi fermato. Lei avvicina lo specchietto al buco, calcola l’angolo d’incidenza del raggio di luce e altri dati non trascurabili, e il gioco è fatto. Il rumore non idoneo è stato eliminato, per il momento. Si è zittito tutto d’un colpo, come se stesse aspettando quel segnale luminoso. La maniglia trema un po’; un punto blu scintilla nell’ombra: la porta si è aperta di un rettangolo nero affusolatissimo, da cui potrebbe passare solo quel punto blu. Mi hanno detto di venire per il colloquio, dice lei. Il punto gira descrivendo una minuscola circonferenza. Entri, là fuori rischia di squagliarsi, dice lui. Il rettangolo si dilata fino a scomparire, il punto blu si duplica: col suo gemello si rivelano essere gli occhi di un signore sui quarantaquattro anni, magro ma robusto, con folti capelli arancioni e gialli, in abito ma senza cravatta. La camicia riabbottonata in fretta. I bottoni non corrispondono alle asole cui si sarebbero dovuti agganciare, facendo intravedere in prossimità del colletto uno sghembo triangolo di peluria arricciata. Le finestre hanno le tapparelle rigorosamente abbassate. C’è un caminetto con pezzi di qualcosa che brucia. Ma fa più fresco. Anzi, è quasi umido, come se le pareti stillassero rugiada. Lei si è seduta all’angolo sinistro del letto matrimoniale. Alle sue spalle c’è una torre di cuscini. Gradisce un Martini? No, grazie: preferisco di no. Lui si versa un Martini doppio e lo tracanna sbrodolando. Lei si alza, e con disinvolta solerzia tampona dolcemente le guance del cliente con un batuffolo di fard. Lui le afferra il polso con una mano, l’altra si apre, il bicchiere cade. Rumore di vetro rotto. Non idoneo. La guarda con le sue minuscole circonferenze blu. Con la mano aperta le afferra la lunga frangia, ribaltandola. Umidità sulle pareti e al centro della stanza. Lei si sforza di trasfondere nella lingua la forza che alberga nei tacchi. Le lingue si sondano in un duello muscolare che lei è costretta a perdere per non umiliare il cliente, il quale non si rende conto della cortesia dell’interlocutrice, e infierisce, aggredendo le gengive con i denti. Lei non smette di registrare i minuti che passano. Uno due tre. Uno due tre. Ma il cliente l’ha già sbattuta sul letto e si sta slacciando famelicamente i pantaloni. Il bacio continua e le gengive ormai prudono e sanno di ferro. Lei percepisce qualcosa di bollente in fondo alla pancia. Uno due tre. Uno due tre. Sconfitta. Inevitabile sconfitta. Ha gradito il colloquio? fa lui. Risata accompagnata da eruzione di saliva. Abbiamo ancora sette minuti e trentuno secondi, fa lei, disegnandogli un naso da clown con il rossetto. Ha ancora le scarpe addosso. Cosa c’è sotto la torre di cuscini? Cosa? La torre di cuscini: cos’era quel grido, prima? Ma che ti prende? Non senti quel rumore, quella cosa sotto che urla? La bocca del clown si allarga in un ghigno bavoso. Sicura di non volere un altro Martini? No, grazie: preferisco di no. Si sfila i tacchi, li impugna uno per mano. Gli è sopra: inginocchiata lo include tra le cosce aperte. Lui pare essersi fermato. I tacchi si alzano e si abbassano sul volto del cliente seguendo un’alternanza precisa. I punti blu smettono di girare e insieme al riso vanno affievolendosi. Rugiada rossa sulle pareti. Uno due tre. Uno due tre.