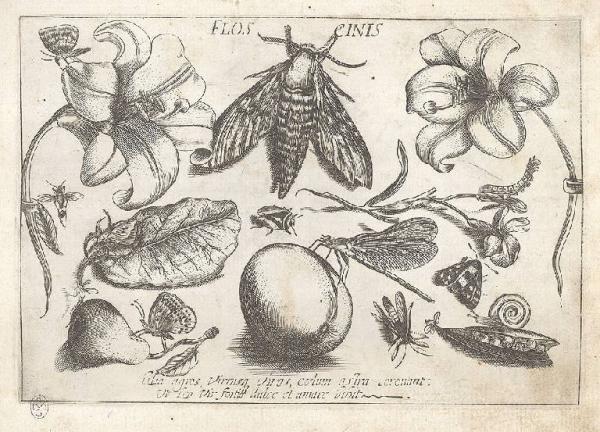1.
Un uomo calvo, glabro e pallido, con una tuta bianca chiusa da bottoni neri è in piedi e fissa un muro bianco. Le sue pupille saettano come se stesse seguendo uno scontro tra asteroidi e comete, come se stesse assistendo a una battaglia tra navi spaziali, alla morte simultanea di stelle, alla nascita di pianeti dopo interminabili big bang. Ma è lì, in piedi, posizione perfettamente eretta, mani intrecciate dietro la schiena, in una stanza disadorna e senza finestre, che fissa un muro bianco.
Alle sue spalle, ansimante, arriva una giovane, senza capelli, stessa tuta bianca, ma con una cerniera dorata al posto dei bottoni.
La donna vorrebbe subito parlare, ma l’uomo, rimanendo di spalle, la blocca con un cenno della mano. Si gira lentamente e la guarda fisso negli occhi.
Gli occhi dell’uomo sono crateri colmi di lava ribollente, un brodo prebiotico dal quale schizzano lapilli di intuizioni e idee. Al contrario, gli occhi della donna sono bui, due bare pregne di liquido colante. Occorre proteggersi da entrambi gli sguardi. Da quello dell’uomo, da chi ha dato forma all’ineffabile, da chi emancipa la belva e la confina in un giardino edenico ma senza donarle i sensi per godere della fioritura, né l’olfatto, né la vista; da quello della donna, da chi ti avvolge e ti mantiene crisalide artificialmente, ti stritola fino a soffocarti, da chi perpetua una condizione disanimata senza trascendenza. Entrambi aspirano a un ordine nel caos: chi lo vuole governare e chi vuole sottomettersi a esso, assecondandolo.
Un rumore assordante di sirena li ridesta. La stanza trema, qualcosa percuote il soffitto e le pareti, l’uomo non sembra più così impassibile, a guardar bene si direbbe preoccupato. La stanza ha come delle interferenze, cambia colore e aspetto, come un neon intermittente che elettrifica a morte le zanzare. Se ci trovassimo lì, la percezione sensoriale di quella sala e di noi stessi in quell’ambiente, verrebbe fulminata a morte proprio come una zanzara; l’hic et nunc è più morto della lingua latina. E di noi, senza percezione, cosa rimarrebbe? Un ammasso non del tutto biodegradabile di carne e arti bionici, trascinato dal vento e dalle onde, sbattuto violentemente contro scogli di poliuretano.
Ora la stanza non è più vuota, ci sono delle sedie, una scrivania, un tavolino con una zuppa fredda e una mela; un lampadario instabile permette di vedere a malapena una strana carta da parati che raffigura il Minotauro che cammina sul suolo lunare.
La donna domanda all’uomo:
«Cosa facciamo? Lasciamo che tutto finisca, un’altra volta?»
«È giunta l’ora di ricominciare. Ripartiremo dai sopravvissuti. Non dimenticare che sono al 20% ancora umani. Qualcosa abbiamo salvato».
«Sì, lo so, ma di questo passo, cosa rimarrà dell’uomo?» risponde la donna.
«Perché senti questo attaccamento puerile ed etnocentrico?»
«Non lo so, sono come noi…insomma sono esseri umani, come me, come Lei…».
L’uomo calvo preso da un impeto di rabbia si avvicina alla giovane e batte le mani una sola volta, a pochi centimetri dalla sua faccia. La giovane chiude gli occhi e il corpo crolla a terra, come disattivato.
L’uomo si china su di lei, fa scorrere la zip della tuta fino al pube e con un dito segna un rettangolo immaginario intorno al suo ombelico. Dopo pochi secondi dalla pancia della ragazza si apre un portale nero: c’è l’universo dentro. La forza d’attrazione è irresistibile tranne che per l’uomo; le sedie, la scrivania, la mela, il piatto con la zuppa, brandelli di carta da parati, vengono risucchiati dentro al vortice. La sirena continua a suonare, dai muri si aprono le prime crepe, il muso di un veicolo spaziale sfonda una parete. La stanza intanto è tornata asettica e disadorna, anche l’uomo si tuffa dentro il portale e una volta dentro chiude la zip.
Una squadra di militari fa irruzione nella camera ma non trova niente. Solo un manichino dall’aspetto vagamente femminile a terra.
«L’abbiamo perso per poco», dice il capo. «Ma penso di sapere dove sia andato», aggiunge.
«Ah guarda, ha smesso di realizzare cyborg-portale identici alla moglie. Se ne sarà fatto una ragione», nota un soldato.
«Oppure è finalmente pronto per un nuovo legame», ribatte sarcastico un suo commilitone.
Intanto l’uomo calvo è dentro un bar molto affollato di una grande città. Sta sorseggiando un caffè con estrema felicità, come se non ne bevesse da secoli. Sa che è stato un rischio, ma ne è valsa la pena. L’uomo ha ancora una piccola percentuale umana, circa il 2,8%; il padre ne aveva il 36%. L’unica cosa che gli è rimasta del padre è un codice informativo che documenta il giorno della sua morte. A volte, ultimamente sempre più spesso, inserisce la scheda in uno dei suoi slot e rivive l’ultimo giorno del genitore. Incredibile, pensa, come un essere con una percentuale così bassa di umanità possa produrre uno spettro così ampio di emozioni e sensazioni. Col 36% cosa mi succederebbe? Ne sarei sopraffatto. Come facevano secoli fa gli uomini? Forse è per questo motivo che la razza umana è durata così poco. O forse è vero il contrario.
Finito il caffè, si alza e va in bagno. Si osserva allo specchio, fa qualche smorfia, si stira le braccia, rotea il capo, si prende la testa tra le mani, tiene il respiro e dà uno strattone improvviso spezzandosi l’osso del collo. Cade a terra. Dopo qualche minuto entra la donna delle pulizie e vede l’uomo riverso sul pavimento. Fa per urlare, ma qualcosa la blocca. Sullo specchio vede una donna anziana, a letto, sua madre, lei le sta stringendo la mano, le asciuga la bocca dalla saliva con estrema tenerezza; a vedersi da fuori non si riconosce, i suoi gesti sono spontanei, naturali, si vergogna e scosta lo sguardo. Riprende ad armeggiare con lo straccio, si vede riflessa e si percepisce meccanica, fin troppo padrona del suo corpo, a tal punto dal non sapere che fare con le sue mani, con le sue gambe, sposta il secchio, strizza il mocio, una goccia d’acqua le schizza la fronte facendole recuperare lucidità: guarda a terra e l’uomo non c’è più.
Una squadra armata sfonda la porta:
«Signora dov’è andato? »
«Chi…non so…».
«Perché non ha aperto la porta?»
«Non lo so…non ero qui…», bofonchia la donna.
«La signora non può aiutarci, non sa più nulla. Lui è stato qui», sentenzia il capo.
2.
Alla fine del XX secolo, in un anfiteatro romano, due popstar, uomo e donna, si dimenano durante un duetto, si scambiano sguardi complici, di fronte a centomila persone in delirio.
La musica si interrompe improvvisamente, rimangono tutti immobili, di pietra. Una squadra armata perquisisce ognuno di loro e controlla i visi con uno scanner. Un agente scorge una figura correre, richiama l’attenzione dei soldati e fa cenno di seguirla. L’uomo, stanato, fugge facendosi strada tra le statue dei giovani sudati e felici, paralizzati in una smorfia sardonica, le spinge e quelle si rovesciano, frantumandosi in mille pezzi e ostacolando i militari.
L’uomo continua a correre, sa che se si volterà indietro suo figlio resterà pietrificato. Finalmente arriva alla pozzanghera vicino alla roulotte, non c’è tempo per celebrare la bellezza delle ninfe con un carme, prende la rincorsa e si tuffa schizzando d’acqua salmastra gli increduli inseguitori.
Riappare in una stanza d’ospedale, reparto pediatria, carta da parati celestina col minotauro spaziale. Suo figlio è lì, attaccato a dei tubi.
«Non posso salvarti, devi perdonarmi, starai così per sempre, come un’opera d’arte. Se staccassi questo macchinario che ti tiene in vita sarei considerato un blasfemo. Chiunque opponga il libero arbitrio contro le macchine è considerato un nemico da eliminare. I tuoi brevi ricordi saranno trasferiti su un dispositivo, esso sarà posto in una zattera sulla riva del fiume, incendiato e lasciato in balia della corrente, come vogliono i Dioscuri del deep web».
Uomini armati irrompono nella camera, si fiondano sull’uomo e lo immobilizzano. Gli schiacchiano la faccia sul pavimento, lui piange istericamente, poi ride.
L’uomo calvo sta assistendo alla scena per la millesima volta in una stanza disadorna, fissa il muro bianco e recita commosso:
«Multas per gentes et multa per aequora vectus
advenio has miseras, frater, ad inferias,
ut te postremo donarem munere mortis
et mutam nequiquam alloquerer cinerem,
quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum,
heu miser indigne frater adempte mihi!
Nunc tamen interea haec, prisco quae more parentum
tradita sunt tristi munere ad inferias,
accipe fraterno multum manantia fletu,
atque in perpetuum, frater, ave atque vale»[1].
«Catullo, carme 101, giusto?», sentenzia Lesbia, la donna robot.
«Sai proprio tutto, eh Lesbia?»
«Ecco, da queste mie lacrime potremmo ripartire», azzarda l’uomo.
«Per fare cosa? Combattere?» domanda Lesbia.
«Abbiamo identificato un buon numero di persone con un residuo d’umanità, potremmo organizzarci, mettere su una milizia…».
«Non credo sia una buona idea. La ringraziamo per averli rintracciati e schedati. Ora deve lasciar fare a noi, non si preoccupi».
«Cosa avete intenzione di fare?»
«La trovo molto debole, sta avendo molti cedimenti. Non capisco perché ultimamente abbia questo sentimento di nostalgia; è questo il termine, giusto? Non la vedo focalizzato sull’obiettivo. La cosiddetta cultura classica, la mitologia, la poesia, l’arte, religione, politica, il pop, tutta l’espressione artistica del genere umano è andata, ormai. Sembra se ne stia accorgendo solo ora. Vi siete illusi di avere qualcosa che vi unisse, di essere fratelli, di avere un immaginario collettivo, ma ve lo siete dati voi, il sogno è finito, tutto ormai è finito. Sirene, ninfe, divinità, libri, dipinti, non sono stati che ologrammi effimeri, con la stessa caducità di un’ape o dell’anima».
«L’unica nostra opera che rimarrà siete voi, dico bene?»
La donna si lascia andare a una smorfia che sembrerebbe un sorriso.
«Che le mie lacrime radioattive si solidifichino e divengano fossili! Del mio amore cosa rimarrà?» grida l’uomo.
«Suvvia, non si sforzi di essere lirico, è patetico» .
L’uomo si interrompe, ha notato qualcosa. Eccitato e sconvolto esclama:
«Guarda Lesbia, un’ape si è posata sul dorso della mia mano. Chissà da dove proviene…».
L’uomo barcolla, la vista si offusca.
«Sai, da bambino avevo un gatto. Quando lo vedevo dormire pensavo: arriverà un momento in cui la percentuale artificiale raggiunta non ci permetterà più di sognare. Quale sarà? Il 70, l’80%? All’epoca non potevo certo immaginare…».
La donna robot lo interrompe:
«Dobbiamo andare. Mi dica la frase, così posso procedere».
L’uomo guarda l’ape sulla sua mano, è titubante, non sembra convinto.
Lesbia la schiaccia con un gesto secco della mano.
L’uomo chiude gli occhi, sente a malapena dolore, è quasi felice di quell’ultima sensazione e pronuncia la frase con voce tremante:
«Quando il tuo occhio sarà chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce».
Detto questo, entrambi si disattivano.
Una stanza d’ospedale con la carta da parati celestina ora fluttua nello spazio profondo; è l’unica cosa chiara in quell’oscurità, più chiara delle stelle. Si sente un rumore, un ronzio elettrico, acuto. Ci sarà qualcuno che proverà a riprodurlo? Come fece l’uomo, tanto tempo fa, quando sentì il tuono e volle imitarlo percuotendo un masso con un osso.
[1] Di gente in gente, di mare in mare ho viaggiato,
o fratello, e giungo a questa cerimonia funeraria
per consegnarti il dono supremo di morte
e parlare invano con le tue ceneri mute,
poiché la sorte mi ha rapito te, proprio te,
o infelice fratello precocemente strappato al mio affetto.
E ora queste offerte, che io porgo, come comanda l’antico
rito degli avi, dono dolente per la cerimonia,
gradisci; sono madide di molto pianto fraterno;
e ti saluto per sempre, o fratello, addio.