Qualche giorno fa, dopo lunga attesa e vari piccioni viaggiatori – a noi piace l’idea che da qualche parte nel mondo meccanizzato i piccioni rechino ancora messaggi! – finalmente è arrivato un atteso commensale, si è seduto a tavola con noi, già cotti, e ci ha dato questo foglietto: D’eternità o d’avanguardia su F. Dostoevskij. Ci siamo guardati, io e Fharidi, e abbiamo esultato: “Finalmente!” Poi ci siamo accorti che non ricordavamo più il suo nome battesimale. – Eppure, un nome che importa? –
Ora, dice di chiamarsi The Light Carrier.
Fahridi e Quijano, eccoci. Mi unisco a voi dopo che avete riposto la palla: si può andare d’accordo su tutto, meno che sul calcio parrebbe, ed allora eccomi a parlare non per mettere d’accordo, non per confrontarci o per scontrarci. In effetti, non so nemmeno bene per cosa, ma so che ho un limite di caratteri ed un argomento di cui parlare. A porla così, è già un gran dire: qualcosa di cui parlare. Quel qualcosa è un monumento, persona fisica e cima spirituale, vetta con aria sottile, profumo d’incenso e zolfo, tanto zolfo, per ricordare l’amarezza anche dell’incenso. Va bene, allora: parliamo di Dostoevskij e facciamolo in ogni caso brevemente, e prospetticamente, in parte minima, focalizzando l’attenzione su quanto meno sfugga a chi scrive in questo momento, senza speranza preventiva di poter guardare in faccia la sua aria sottile.
Qualche giorno fa ebbi modo di confrontarmi con un amico circa l’articolo di Aldo Busi sulla morte di Lucio Dalla, a proposito delle accuse di incoerenza –parolaccia –, che Busi avrebbe rivolto a Dalla, e mi è venuto in mente Dostoevskij. In realtà non credo fosse mai uscito dai miei pensieri, dopo tutto mi sono rituffato a distanza di anni nella sua lettura, e, dopo i suoi capolavori mi sono ritrovato tra le mani il suo Diario di uno scrittore. Evento presentato di proposito come casuale, ma il caso e la vita, e la letteratura, vanno d’accordo solo compenetrati in qualche modo. No, non è un caso che io sia ritornato alla lettura di Dostoevskij, così come non è un caso che accenni a lui, scomodandone la statura per parlare anche di Busi e Dalla, perché se sono le persone a farela Letteratura, a fare l’Arte, essa non si riduce meramente a loro. L’arte trasfigura, chi? Loro, ovviamente. Ecco perché mi è tornato in mente Dostoevskij, ecco perché ho pensato all’idiozia di un artista che reprime le sue potenzialità creative cantando luoghi comuni e non spogliandosi di quelle viscere che trovano consistenza trasfigurate in versi. Ho ripensato alla figlia morta di Dostoevskij, e di rimando ai discorsi sui bambini di Miskin e sull’ingiustificabilità della loro sofferenza nella voce tragica di Ivan Karamazov, di nuovo agli epilettici Miskin e Smerdjakov e alla rivelazione del “male caduco” che tormentò lungamente lo scrittore, per poi finire col vizio del gioco e la gioventù vissuta in ambienti legati agli anarchici fourierani. Sì, tutto un gran parlare e trattare di estetica e teoria che nega quanto sia evidente e per nulla nascosto al genio, che con abilità da artigiano della parola sappia cesellare tutti i minuscoli e polverosi dettagli della propria esistenza in edifici incrollabili, lo stesso che rispondendo ai grandi critici dell’epoca in un giornale tra tanti, per alcuni bigotto, lavorando su se stesso tirava fuori tutte le contraddizioni, le iperboli e gli abissi di un uomo che solo per modestia, il Nostro chiamava semplicemente, russo. Non solo russo, appunto, ma, per fortuna russo. Lo “slavismo” di Dostoevskij non è ideologico o nazionalista: nessuno sciovinismo ma la constatazione che per lo scrittore essere russo aveva un qualcosa di provvidenziale.
Di nuovo un cenno alla biografia, in maniera comparata: allegorie che vengono in mente solo quando si sta alla tastiera, e prima impensate. Anche Manzoni –Alessandro, quello che si insegna nelle scuole… – ebbe un certo giorno della sua vita una “conversione”, descritta in maniera particolareggiata, scenica, orpellata quanto bastava per renderla giustificatrice della messa in opera di un testo motivato ideologicamente. Il sentimento del sacro legato al sentire minuto della povera gente diviene l’artifizio letterario del linguaggio de I promessi sposi, ed il lettore sa che il narratore non ha nulla a che spartire con quei poveracci che parlano come lui, che sono la sua caricatura, lo strumento narrativo di cui ha dovuto avvalersi per riportare i suoi concetti sulla terra. Dostoevskij non ha mai dovuto riportare nulla sulla terra, semmai il contrario, anche in forma letterale: nelle Memorie dal sottosuolo è la terra a parlare, è un “microbo”, un uomo che si repelle, che sa di non essere degno di calpestarla -la terra-, ad ergersi ad eroe, come solo un uomo può fare, da vinto, da contraddetto, da uomo appunto. Giorni fa leggevo, ritornando a Manzoni, un passaggio di Parente in cui, giustamente, sottolineava come Renzo e Lucia dopo il trionfo della Provvidenza perdessero ogni interesse agli occhi di qualsiasi lettore, ed anche di Manzoni a quel punto, che decise, opportunamente di porre termine alla vicenda. Io invece mi sono sempre chiesto che ne sarebbe stato di Alesa Karamazov alla fine del romanzo. Dopo la tragedia che aveva investito i fratelli e prima il padre, avrebbe potuto recuperare il suo ruolo di simbolo della fede incrollabile? L’umanità di Dostoevskij lascerebbe intendere di sì, Alesa è l’ultimo suo Cristo, l’ultima speranza nel cuore dell’uomo, definitivo appello alla ricerca di una innocenza data dalla gratuità dell’amore, di quella purezza morale che nei romanzi maggiori viene chiamata semplicemente “bellezza”.
Mentre in Occidente il pensiero si scopriva inevitabilmente e definitivamente ateo, con Nietzsche che stava per annunciarela Morte di Dio, un artista russo, estremamente colto e consapevole di quanto avveniva in Europa, dedito al gioco, condannato a morte e graziato solo sul patibolo, rovinato dai suoi vizi e tormentato da dolori nel suo fisico, diffidando e smentendo la cultura, vana scopritrice di non-luoghi, credeva nel cuore degli umili, e nel loro ingenuo sentire, nel popolo russo non ancora corrotto dal razionalismo europeo, conservatore e rivoluzionario perciò. Di fronte alle consolazioni socialiste e al disincanto positivista egli lodava il “bisogno della sofferenza, continuo ed insaziabile, dappertutto e in tutto” del suo popolo, non coinvolto, se non negli strati più elevati nelle vane diatribe ideologiche sulla politica e sulle arti, popolo bambino, espressione di quegli ancestrali tratti dell’esistenza ancora tutti da spiegare nella vita, da trasfigurare in fatti, opere e parole, che “rendono più umana la nostra anima con la loro semplice apparizione fra noi”. Egli rinveniva nel suo Alesa l’uomo non corrotto dal cinismo civile, l’uomo che è riuscito a rimanere bambino, che ha trovato in una innocenza da fanciulli forse l’ultima speranza di umanesimo possibile. E l’arte per l’arte allora? E l’arte comprensibile solo dagli artisti? E la metaletteratura? Ed il postmodernismo? E i Barthes di Barthes? Ghiacci gelidi sedimentatisi prima di giungere alle alte vette dove l’aria si fa sottile…
The Light Carrier


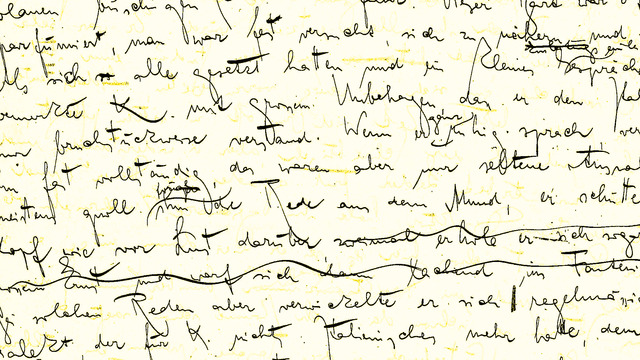


Che bello!
quanto zolfo qualcuno deve aver evocato un demonio :))
Caro visir, dev’essere un demonio russo. al tundra è grande, uno ci può trovare di tutto, se cerca bene
Boni, state Boni!!!
Minchia, ma io ho pure un blog su WordPress *_*
o meglio, eccolo (chiedo scusa per lo spam :-P , diciamo di “collaudo” ;-) )
bene!
Gran post, The light carrier (‘o rathumos’? – scusa la mezza etimologia :D). Ci fregiamo qui dentro di avere ospiti di lusso (gran visir Ibn Shaprut, sentiti pure chiamato in causa per un prossimamente)
C’è una cosa nel tuo testo che mi colpisce più di altre, cosa che, in un testo precedente, qui chez Crapula, parlando di “Amuleto” di Roberto Bolaño, avevo in qualche modo anch’io abbordato.
Quella distanza che tu dici del popolo russo da…(chiamiamole ora, per intenderci, “pippe mentali europee”: sono le 7 di sera, siamo quasi in prime time. Pure i bambini devono capire :D), ecco il richiamo che su di noi “europei delle pippe mentali” quella distanza produce è esotismo o nostalgia, in primo luogo, mi pare. Fino a che punto però questo aspetto è determinante ? (ovvero: il fatto di essere russo fa di Dostoevski uno scrittore migliore di, non so, Beckett o chi per lui?)
O detto ancora diversamente, le pippe mentali stesse, l’aver sotratto anche l’ultima speranza all’umanismo, non è necessariamente un punto a sfavore della letteratura europea. Al contrario. È una cosa di cui andare fieri per il mondo. Io mi ci riconosco, quantomeno (come nota a parte, credo che il discorso sul postmodernismo sia molto banalizzato oggi. e lo sarà probabilmente fin quando non sarà chiaro che i padri fondatori di questo buco aperto sono propri i cari Joyce, Beckett, Pirandello, Gombrowicz e compagnia – con in prima linea il caro baffone Ntzsch, come sempre. Ne abbiamo già discusso in altre sedi elettroniche e so bene che hai delle fondatissime opinioni al riguardo).
Detto questo, Dostoevski è stato il primo scrittore a darmi l’impressione che il romanzo non è una forma inferiore alla poesia.
Dostoevskij è un romanziere, ovvero un architetto della parola, quanto di più lontano dal poeta, che la parola sfida, che forza e si sforza di fare con essa un ibrido che forse non esiste, tra le sue intime emozioni e i concetti comprensibili agli altri homines sapientes sapientes. Prima di Joyce, pur col cervellotismo di Joyce fare questo era impensabile: il romanzo doveva raccontare. Punto. Eppure, Dostoevskij m’emoziona alla lettura, quasi fosse poesia, forse più della poesia. Di alcune poesie, per meglio dire. Com’è possibile tutto ciò? come è possibile che lo faccia un uomo che -esaspero il concetto- viveva ancor più anacronisticamente di Dante in un mondo che auspicava potesse essere come quello auspicato da Dante? Come posso solo io, occidentale del XXI secolo che non può credere e non crede più in nulla, men che meno in Dio e nell’amore universale tra gli uomini -ah, se Dostoevskij avesse conosciuto Stalin!-, adorare Dostoevskij? Nel pezzo parlo per lo più del Dostoevskij moralista, che è quello più facile ed immediato da cogliere. Ma c’è un aspetto a mio avviso “raccapricciante” del pensiero di quest’uomo, ovvero il fatto che egli sembri comprendere, assumere in sé stesso le obiezioni di due secoli, questo e lo scorso, e superarle di slancio, con una nonchalance che per quanto sofferta in ogni caso sbalordisce. Penso a me stesso, e a quello che posso pensare e non posso non pensare e mi rivedo in forma lirica in Ivan Karamazov e vedo quasi la compassione che Dostoevskij può avere per uno come me, un abitante di questo secolo, condannato appunto a poter pensare in un modo e non in un altro perché non starebbe seguendo la “Verità”. Penso a questo, e mi vengono in mente tutti i problemi di espistemologia sulla verità, sulla convergenza verso il concetto di accordo piuttosto che verso una definitorietà del dato o della teoria. Verso l’arbitrio insomma. E qui, ritorna lui, fiera implacabile, che disse che se Dio non esisteva tutto sarebbe stato permesso. Ed allora, a che pro il nichilismo? a che pro questo martirio del cuore in favore della ragione? questa esigenza di forma, di esclusione di certi contenuti ed atteggiamenti? Se Dio non esiste si può anche perseguire una certa felicità facendo finta che lui esista come fanno quei poveracci russi che per fortuna non si sono rincoglioniti leggendo i libri che io ho letto :-)
Come posso solo io, occidentale del XXI secolo
c’è l’intromissione di un “solo”
Non sembri affatto rincoglionito, devo dire. Al contrario.
Sono felice di aver “provocato” questa tua risposta. Qui cominciamo a giocare per davvero, usciamo dalla “russità” di Dostoevski per entrare nel cuore stesso di questioni che solo la letteratura più alta può esprimere e trasferire (qui, credo, la differenza di genere non sia più rilevante).
Lo slancio che dici sui secoli che lo seguono, e la nonchalance (o ancora meglio la strafottenzza al rischio e al dolore), sono di sicuro tra le cifre di grandezza del D.
E questo vale anche per noi, ora.
Quella rathumia, quella nonchalance e quella strafottenza sono ancora la chiave.
– “Dio non esiste!”
– “Finalmente!”
Questa condanna è probabilmente una liberazione. (Incipit Zarathustra?)
Incipit comoedia.
Se pensassimo ancora alla tragedia, ora, dantescamente (perché è Commedia solo un genere) saremmo fin troppo postumi, tali che anche lo scricchiolare delle nostra ossa – le parole – ci potrebbe sembrare canto.
Noi possiamo ancora trovare un altra voce, la nostra forse o la fiducia in una futura, ma bisogna abbandonarci, per quanto umili vogliamo essere. Ma si sa che l’umiltà non è propria di chi sfida, di chi lancia il dado, ma di chi il dado lo studia per arrivare a dire che ha sei facce.
L’equivoco, amici miei, non è se Dio è morto o meno, non più ora, ma quali conseguenze ha comportato questa morte. Se non ne ridiamo, almeno noi, sarebbe vano qualsiasi altro tentativo precedente.
(non so usare un linguaggio che non sia metaforico, colpa della poesia!)
“Solo un drink potrà salvarci” cit. ;-)
a proposito, non so voi ma a me wordpress m’indica che tutti i commenti sono stati scritti il 16 marzo (o il 17) alle 12:04. e mi dico – un drink a quell’ora?
WordPress si droga di brutto brutto brutto :-) sì, anche a me appare per ogni post la fatidica ora 12.04 :-D I Maya avevano dimenticato di indicare l’ora, WordPress ha completato il vaticinio ;-)
Per me non c’è bisogno del drink alle 12.04, ho la scorta del giorno prima.
:)
Quijano devi sempre fare lo sborone
sono le 12:04, ho già bevuto abbastanza (un cileno, non Bolaño, uno ancora vivo, mi ha insegnato che un padre di famiglia deve imparare a ubriacarsi il poemriggio) per dire, più precisamente, che avanguardia e eternità non necessariamente sono termini oppositivi.
Detto questo, voi che potete, bevete più tardi (alle 12:04?)
i termini si oppongono in quanto termini, parole, suoni, foanai sedimentate in non luoghi. Troppo vacue per farsi guerra: qui tutto convive. Juventini dall’inferno ;-)
fonai, pardon…. anzi, phonai: visto che si può correggere, correggiamo bene ;-)
e allora, se non si fa guerra, volemose bene
(volemose bene fino alla partita della juve, dico. per il resto, qua dentro sappiamo che proprio i phonai, eminentemente loro, si fanno la guerra)
Sono un cammello, più che altro, Fharidi. Un cammello infingardo! :)
Un animale del deserto, non ho mai dubitato di questo!
Nel deserto sono sempre le 12.04.
Polemòs patèr pantòn.
si, volemose bene!
allora è vero che gli dei parlano greco (nel deserto, non mica nella foresta nera)
Ho una domanda su questo slancio di Dostojevski e sulla sua russitá. Se ho capito bene, la russitá é secondaria o comunque non cosí determinante perché D. é un genio che col suo slancio riesce a conciliare la religiositá russa con l´innecessitá di Dio e, in questo modo, riesce a far ancora commuovere i poveri posteri nichilisti, che non possono piú credere in nulla, senza per questo scomodarli troppo dalle loro non credenze. Allora mi chiedo, l´umanismo di Solzhenitsyn, cos´é? un rinculo dostojeskiano(giusto per mantenerci nella metafora dello slancio)? O forse la russitá é un carattere provvidenziale affinché questo tipo di idee letterarie non ci risultino stucchevoli, false, passate (roba da Promessi Sposi, per intenderci)? Mi rendo conto che poi sorgerebbe il problema di spiegare cos´é la russitá – perché il miele dei russi non ci stucca, mentre agli altri non perdoniamo nessuna mielositá? – anche perché poi questa accezione della russitá non é presente in altri autori, pur altrettanto russissimi (tipo Bulgakov, Druzhnikov, Pelevin). Avvicinati a farci un pó di luce qui – resiteremo al fetore sulfureo -, o venereo Light Carrier…:D
Purtroppo non ho letto nulla di Solzhenitsyn, quindi su di lui non posso esprimermi. Per come la vedo io, la russità si potrebbe tradurre, almeno verso la fine del XIX secolo come la sensazione che la cultura popolare, ortodossa, sia irriducibile del tutto al razionalismo occidentale. C’è un passaggio del Diario in cui Dostoevskij ricorda le premure che gli recava quand’era piccolo un suo servo della gleba, ovvero uno che era tenuto a suo dire anche a disprezzarlo, o quanto meno ad essere schivo nei suoi confronti. Ecco, “razionalmente” Dostoevskij non riesce a trovare un motivo per il quale il servo fosse tenuto a volergli bene. Eppure gliene voleva. In questa capacità di amare disinteressatamente, egli vede -meglio, si persuade vi sia – un cristianesimo originario come purissimo umanesimo, la sensazione che l’uomo non rincoglionito da troppa cultura sia fondamentalmente buono. -E’ na strunzat, ma il Nostro ci credeva davvero.
Denudati, Light Carrier, cazzo! così ce piaci! :D