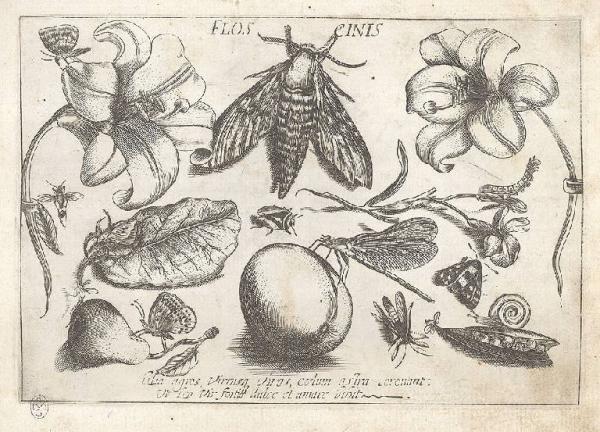Esisteva un tempo un piccolo feudo che riposava sotto il sole a un’ora appena di viaggio dalle bionde sabbie del Thar.
Si dà il caso che in quel feudo vivessero due uomini perfettamente identici quanto ad altezza, portamento, timbro vocale e colore delle iridi, tanto da poter essere scambiati l’uno per l’altro, malgrado non intercorresse tra di loro alcun vincolo di parentela ufficiale, atteso che del padre dell’uno si narravano le innumerevoli imprese amatorie fuori e dentro il palazzo reale, entro e oltre i confini feudali, con femmine di alto rango, donne libere, serve e schiave, mentre l’identità del padre dell’altro rimase sempre ignota.
Il primo dei due era il maharaja del luogo, figlio legittimo del maharaja padre e suo diretto successore, il secondo era un un umile domestico, a sua volta figlio di una cameriera agli ordini della maharani, la moglie del maharaja padre, e da questa allontanata da corte subito dopo il parto e relegata alle pulizie delle stalle finché non ne era sopraggiunta la morte per consunzione fisica.
All’interno del palazzo il domestico indistinguibile dal maharaja, per esplicita volontà del Suo Signore, attendeva alle mansioni più ignobili, senza che giammai gli fosse prospettata un’eventuale promozione.
Siccome quella loro somiglianza non era sfuggita ad alcun suddito e sin dall’inizio era stata motivo di scherno e di pettegolezzi, non appena erano stati entrambi colti dai rapidi mutamenti che accompagnano la pubertà, colui che all’epoca era ancora solo il pretendente al trono, poiché si stava facendo crescere sotto al naso un rigoglioso paio di baffi ricurvi all’insù, aveva imposto al proprio sosia di mantenersi imberbe, pena: la decapitazione. Confidava che la fuliggine e il grasso addensati tra le rughe rispetto a una pelle tenuta pulita e lucida dai saponi e dalle essenze, le vesti stracciate e lerce rispetto al bisso e alla porpora, la testa scoperta e arruffata rispetto a una fronte maestosamente inturbantata, un labbro spoglio rispetto ai superbi mustacchi che schiumavano il suo prolabio mostrassero l’infinita distanza che passa tra uno sguattero e un re, così da correggere ciò che la natura aveva trascurato.
Il maharaja era un sovrano dispotico fuori e dentro il palazzo, noto per i suoi capricci passeggeri, le aspre gabelle e le severe leggi che imponeva a sua discrezione al popolo inerme, la facilità a comminare pene capitali o punizioni esemplari al minimo sgarro. Soprusi e atti di rappresaglia erano all’ordine del giorno. Dal padre aveva ereditato l’inclinazione per le alcove, non già le sue arti seduttive: se posava gli occhi sulle grazie di una fanciulla la faceva rapire nottetempo dai suoi sgherri perché andasse a rinfoltire l’harem che l’ala orientale della sua vasta dimora ospitava. Talora si premurava di ripagare un’attempata coppia tramite una piccola pila di monete in cambio dell’acquisizione della loro figlia e, in caso di rifiuto, procedeva alla confisca.
Il domestico lo invidiava di nascosto, costretto ogni giorno a rammendare i ricchi drappeggi che rivestivano le ampie stanze, a lustrare i marmi che costituivano le pagode e i padiglioni nella cui frescura il Suo Signore andava a meriggiare, a tirare a lucido gli estesi pavimenti che con la luce radente parevano farsi liquidi, come miele di Kurinji, e intanto malediceva tra sé i lombi che avevano depositato lui in una serva e l’altro nel ventre della sposa del maharaja.
Talora, messo carponi con uno strofinaccio tra le mani, arrestava per un attimo il suo lavoro per specchiarsi in quella mosaica di piastrelle ambrate che andava incerando: e dire che era niente più di un fatuo paio di baffi a fare la differenza tra loro, meditava amaramente.
Una mattina, che con le sue prime luci ancora stentava a violare gli ultimi strascichi di tenebra, nel minuscolo stanzino in cui alloggiava il domestico si presentò il ciambellano di corte.
L’uomo, alzando a fatica le palpebre ancora pesanti, a scorgere ritto in piedi, accanto al basso uscio, quel visitatore inatteso, si rattrappì spaurito sopra il corto giaciglio di paglia. Il ciambellano lo tranquillizzò con un sorriso buono e un gesto che gli consigliava il silenzio. Si sedette sul pagliericcio accanto a lui per sussurrargli nel cavo dell’orecchio parole segrete.
Confessò che i sudditi si erano da tempo stancati delle continue angherie del maharaja e con loro cortigiani e notabili. Comunicò che urgeva un colpo di mano, ma senza sollevazioni, senza far scorrere sangue. Bastava una semplice crescita di peli.
Il piano era questo: lui, il domestico, avrebbe dovuto farsi crescere dei folti barbigi arricciati verso il cielo. Solo questo gli si chiedeva. Al momento buono, quando quel ciuffo pettinato sotto il naso fosse stato presentabile, il ciambellano e gli altri congiurati avrebbero pensato a sostituire a Sua Maestà il cencioso domestico, adeguatamente ripulito, confidando che le politiche di costui, se ben dirette, sarebbero state ben più ponderate di quelle del suo predecessore, senza che tuttavia un conclamato cambio al comando potesse turbare le folle e i consolidati rapporti con gli alleati esterni.
Il domestico accettò senza tentennamenti.
Per settimane fu rinchiuso in quell’angusto ripostiglio, nell’attesa che i nuovi baffi si allungassero della stessa misura di quelli sfoggiati dal maharaja. Nel frattempo ancelle orbe dalla nascita furono introdotte in quello che era divenuto il suo nascondiglio per far conoscere al suo corpo incrostato balsami e spugnature con acqua di rose.
A ogni alba il ciambellano giungeva nello stanzino del domestico per controllare lo sviluppo dell’ornamento del suo labbro superiore. Questa è l’ora in cui il baffo fiorisce, spiegava al sempliciotto.
I tuoi baffi sono quasi pronti, constatò soddisfatto il quarantesimo giorno.
Il giorno appresso recò un vasetto contenente cera d’api, affinché il domestico desse loro una forma.
Il giorno prima della data stabilita per fargli assumere la più alta carica del feudo, le stesse ancelle cieche che avevano provveduto a detergerlo a fondo gli consegnarono il turbante, la giubba di seta, il mantello dai colori sgargianti e la scimitarra con cui si sarebbe dovuto presentare in pubblico.
Venne il momento di debuttare nelle vesti di maharaja. Non sapeva quale fine avessero fatto fare a quello originale, quando sentì finalmente girare la chiave e aprire la porticina della stanza umida e semibuia. Sapeva solo che era giunto il momento per lui di godersi tutte le prebende riservate a un re, mentre con soddisfazione si lisciava i baffi, che finalmente gli era dato portare, lungo tutta la loro prolissità.
Apparì dal balcone del palazzo aggettato sulla piazza. Da lì benedisse una folla festante, promettendo migliorie e condoni. Fatto questo, si ritirò nelle stanze ombrose del palazzo per godere del consueto trattamento regale.
Si inebriò con boccali d’opale ricolmi di un corposo shiraz portato in dono da ambasciatori provenienti dall’ovest, si saziò con frattaglie di agnello cotte dentro un pentolino di rame, nel latte della sua stessa madre. Si sciacquò la bocca con il sapore zuccheroso del frutto del mango.
Infine, satollo e felice, pensò di condividere la sua insperata fortuna con altri miserabili pari a lui, emanando editti che graziavano i condannati a morte e svuotavano le carceri.
A conclusione di quella splendida giornata gli spettava il più dolce dei premi: raggiungere l’attuale maharani sul loro soffice letto nuziale.
Turiboli ed essenze floreali riempivano l’aria. Il domestico si svestì dei nuovi abiti e scivolò sotto le morbide coltri per avvinghiarsi alle forme piene e tonde della Sua Signora. Ma quando fu lì, il tempo di bisbigliarle un nonnulla per risvegliarla dall’apparente torpore e quella balzò in piedi come un grillo, aggrappandosi di getto alla maniglia della porta secondaria.
Questo è quel che meriti per tutti i tuoi tradimenti, gli urlò prima di girare la maniglia e far irrompere nella stanza un energumeno con una sciabola in pugno, che gli si avventò addosso incidendogli la gola da orecchio a orecchio senza lasciargli neppure il tempo di reagire.
Un attimo dopo l’accesso principale si aprì di schianto. Sulla porta apparvero il maharaja legittimo, affiancato dal ciambellano di corte e dal boia.
L’energumeno e la moglie furono colti di sorpresa. A un cenno del maharaja, che fino ad allora era rimasto nascosto nei sotterranei del palazzo, il boia li decapitò entrambi con un unico colpo di mannaia.
I loro corpi si afflosciarono sulla maiolica del pavimento, zampillando fiotti di sangue dai torsi decollati.
Intanto il domestico gorgogliava dalla gola squarciata, aggrovigliato alle lenzuola. Il ciambellano, notandolo ancora cosciente, ebbe l’accortezza di avvicinarglisi e sussurrargli quanto accaduto.
Già da tempo giravano voci su un complotto di palazzo. Quel che serviva era far venire allo scoperto i cospiratori senza però compromettere l’integrità fisica del maharaja. A ciò era tornato utile il suo impiego, spiegava al moribondo, ringraziandolo sentitamente.
Questi spese il suo ultimo fiato per domandare di venire perlomeno deposto nella tomba conservando i propri baffi, in cambio dei servizi resi pur inconsapevolmente al maharaja.
Troppo tardi: il boia, dietro ordine del sovrano, si stava già applicando a una completa rasatura condotta a punta di mannaia, in vista della sepoltura comune.