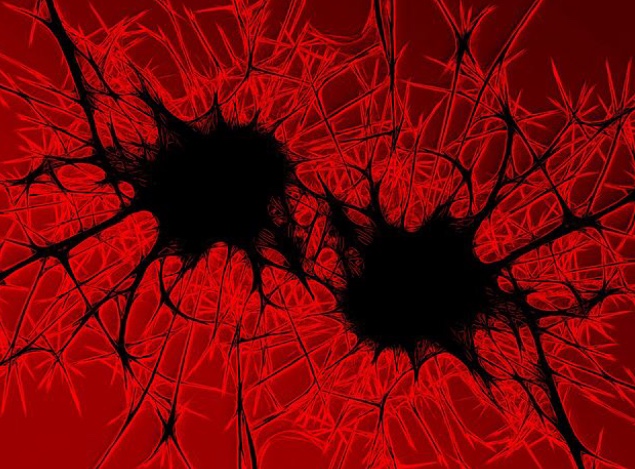In famiglia abbiamo un Natale leggendario, “il Natale che Mimmo cacò sul Presepe”. Tutti gli anni, puntuale come la ricrescita, si abbatte sul pranzo il momento in cui qualcuno, di solito quell’idiota di zio Gino, farfuglia con la bocca piena: «ma quando Mimmo cacò sul Presepe?» Mimmo avvampa. Tutti mi guardano, perché fu deciso – venti, cent’anni fa, non lo so – che sono quella che sa raccontare. Non mi faccio pregare perché tanto non mollano, se non li accontento puntano e pigolano «dì dì dì» fino a Pasqua.
Attacco: «correva il Natale del 1985 e la famiglia intera, come ogni anno, si era riunita in questa casa, in questa stanza, a questa tavola…» Mimmo quatto quatto se la squaglia. A me mi dispiace, ma primo lo so che fa il paraculo, secondo raccontare è giocoforza; la mamma mi accuserebbe di essere una stronza insensibile e io dovrei controbattere che è una bambola ammaestrata e Mimmo sarebbe ancora più dispiaciuto. È successo, certo che è successo, è successo più volte. Ci s’ha la famiglia che ci s’ha.
Insomma, la storiella finisce così:
«E allora il babbo gli fa: ‘Mimmo! Perché hai cacato sul Presepe?’ E Mimmo: ‘perché Gesù Bambino si è preso il bagno!’» e tutti ridono.
Vado a cercare Mimmo e lo trovo buttato sul letto che guarda la TV spenta. Lo sfido a FIFA, se accetta giochiamo, perdo venti a zero e torniamo in sala, sennò gli accendo lo stesso la Playstation e lo guardo mentre spara agli zombi mutanti. Poi torniamo in sala.
Quando ero adolescente il Natale era terribile, tra scenate, gaffe e polpettoni bruciati, ma invecchiando ci siamo dati una calmata e ormai è un coccodrillo sdentato: un po’ te la fai addosso, ma sai che non può più far male. Da quel 1985 sono morti nonna, babbo, zio Franco e il Che. Zia Paola pure non se la passa troppo bene, le hanno dato sei mesi di vita dieci anni fa e si vede.
Mimmo è maggiorenne. Non ne parliamo mai della storia del Natale. Tutte le cose che non sono ancora riuscita a dirgli, tutte le scorie. Quelle che ricordo solo io e non ho mai pensato di dire, quelle che tutti ricordano ma nessuno vuole dire, quelle più sfuggenti e più inquietanti, che nessuno ricorda, ma sembra che tutti ne siano posseduti e così le loro parole sono parole qualsiasi ma significano sempre lo stesso qualcosa che però è muto. Tutte le cose in regalo.
Mimmo ha diciott’anni ed è quello che un tempo si sarebbe chiamato un ragazzo ribelle, ora si dice testa di cazzo, ma è sempre la solita roba, l’ho sempre evitati come la morte gli “uomini” così – quel tipo di maschio Harrison Ford molle-ma-duro, chiagni e fotti, non so se mi spiego. Sanguisughe che s’insinuano facendo gli occhi dolci e poi ti agganciano, e non ti mollano più finché non ti hanno spolpata e ciao, vanno da un’altra. Trovano sempre – è incredibile! – qualcuno che li ama e questa è una tra le cose che me la fa prendere peggio col genere umano: le tecniche di basso livello funzionano sempre. S’è capito o lo devo ripetere? Lo dico semplicemente perché lo penso, non è che c’ho la bile alta o sono così cretina da credere di cambiare il mondo. Solo che, ecco, nel mio piccolo ho fatto di tutto per scansare pezzi di merda di quella specifica tipologia là.
Meno che lui, certo. Lui non ce l’ho mai fatta a non amarlo, con tutti i difetti che ha. Ma mica solo perché è il mio fratello piccolino. È perché mi fa pietà. Questo bisogno di cavarsela che ha, questa necessità di spuntarla alla fine comunque, vincere l’onda, quando insomma si sa che tutti prima o poi ci rimangono sotto, no? Mi scioglie il cuore. E lui ci marcia. Che poi è esattamente il meccanismo che odio negli altri. Come faccio a dirgli queste cose?
Nel 1985 già non ci stavo più dai miei. Nonno, che mi adorava, era morto durante l’estate e mi aveva salvato la vita lasciandomi una casa e un mucchio di BTP. Arrivammo in ritardo, io e il mio fidanzato, perché la sveglia era rotta e il Che invece di svegliarci aveva pensato bene di vomitare per tutte le stanze. Sulla soglia dissi «Nick, ti prego, cerca di essere carino e parlare. Parla, anche se non sai cosa dire, parla a caso». In cima alle scale ci accolse mio padre con un sedano in mano. Disse «è la cartina tornasole su chi ce l’ha più lungo». Erano i primi scompensi che gli causava il tumore al cervello, niente in confronto a quello che è venuto dopo. Poi, in sala, quella gente tutta assieme, tutti caramellosi, abbracci, baci sugli occhi e sugli orecchi.
C’erano Mimmo, nonna, zia Paola, zio Franco, cugina Riccarda, un’altra cugina e zio Gino. Sentii il campo energetico di mamma dalla cucina. Mi divincolai con la scusa di mettere il prosecco in frigo e la raggiunsi sibilando:
«Dov’è Andrea? Che cavolo ci fa tutta questa gente?»
«Quale gente? Sono i tuoi zii e le tue cugine.»
«Cavolo, c’è n’è una che non mi ricordo neanche come si chiama.»
«Non dire parolacce. Non credi che sia un problema tuo e non colpa di quella povera ragazza?»
«Cavolo, ha i brufoli anche sui capelli.»
«Non dire parolacce e abbassa la voce. Si chiama Mafalda.»
«Ci credo che è stravolta,» bisbigliai.
Mamma sogghignò. Era stanca. Anche a lei tutta quella gente rompeva le palle ma con me cascava dal pero perché dirlo non stava bene. Mi fece, caso strano, tenerezza e invece di assillarla l’aiutai coi calici e le bottiglie. Il suo maglione a cuoricini e fiocchi di neve mi sembrò meno insopportabile, più una difesa che un’asserzione.
«Babbo come sta?»
«Non lo sopporto più.»
Stavo per rispondere: come puoi parlare così? che modi sono? che moglie sei? Poi ricordai quello che avevo detto a Nick mentre mi facevo il bidè e lui si pettinava: «poverino, era mezzo grullo già prima.»
«Come non detto,» risposi.
«Infatti,» disse mamma.
Suonò il campanello. Dal salotto Mimmo squittì: «Andrea! Andrea! Andrea!» Mi affacciai cercando Nick con l’idea di mandarlo ad aprire, ma la nonna, installata sul suo seggio, l’aveva sequestrato, agganciandolo con la manina nodosa, e diceva «che bel giovanotto». Gli carezzava il braccio e sorrideva di un piacere genuino, del tutto diverso dalla solita simulazione, la cortesia ipocrita in cui era sempre stata maestra, così congenita nei suoi atteggiamenti che quando aveva messo la dentiera il riflesso opaco dei denti artificiali l’aveva resa più naturale. Nick mi guardò con l’occhio offuscato. Mimmo mi saltellava davanti agitando i pugni. Gli altri nel salotto tacevano inebetiti. Alle mie spalle c’era mamma.
«Com’è che nonna è tutta ringalluzzita?»
Il campanello suonò di nuovo.
«Piantala e spicciati ad aprire.»
Andrea era con una ragazza nera: «Ayaan». Mi baciò e mi strinse le spalle. «Sei bellissima. Andrea, perché non mi hai detto che tua sorella è bellissima?» Andrea le tolse il cappotto con devozione. Lei scosse la piramide di riccioli fini. Emozionata li accompagnai in salotto.
«Chi ha fatto entrare una puttana negra?» gridò nonna. Babbo, zio Franco e zio Gino scoppiarono a ridere. Io avvampai e mi coprii la faccia. Intervenne zia Paola, con la voce – già allora che il tumore non era stato ancora diagnosticato – bassa e abrasa: «mamma stai zitta,» poi sforzò un volume più alto: «Sandra guarda chi c’è!»
Mamma entrò coi flûte sul vassoio e fece la solita scena cretina: esclamò, accorse, abbracciò, baciò, pizzicò Ayaan sulla gota. Mentre promuoveva il brindisi strinsi d’istinto il gomito ad Ayaan. Nello stesso momento zia Paola le strinse l’altro gomito e gorgogliò: «mi dispiace profondamente, tu sei la benvenuta in famiglia, il colore della tua pelle non significa niente per noi.»
«Non si preoccupi, mi accontento che significhi qualcosa per me,» rispose Ayaan.
Ci sedemmo. Papà servì il prosecco canticchiando «chips chips du du du du du.» Mamma disse: «pensa che quando nonna portava Mimmo a passeggio, se capitava di incrociare un vucumprà, lo chiamava Bobo e gli dava mille lire, quando invece incontrava un bambino nero, lo chiamava Bobino e si metteva a piangere. Cioè. Di compassione.»
C’era nel mio fratellone – mi accorsi ora che lo potevo guardare meglio – qualcosa che sembrava un respiro corto. Forse era ingrassato, ma di più, era proprio a disagio. Non per l’accoglienza grossolana, purtroppo più che prevedibile, della famiglia: a giudicare dalla reazione tranquilla di Ayaan, ne dovevano aver parlato in precedenza, le doveva aver detto che la famiglia era una comitiva di cattofascisti rintronati, o roba simile. No, c’era qualcos’altro: si tocchicciava i capelli, guardava la tovaglia, cercava la mano di Ayaan, che con dolcezza lo scansava.
Mamma portò i crostini e si cominciò a mangiare. Interrompendo il silenzio cerimoniale, babbo puntò la forchetta, ammiccò e disse:
«Ora stanno più freschi, quei tedeschi.»
«Quelli chi babbo?»
«Quei due nel Volkswagen.»
«Il Mostro di Firenze,» chiosò zio Gino. Va detto a questo punto, zio Gino, non era lo zio di nessuno, e nemmeno si chiamava Gino: era stato un compagno di università di babbo, poi un amore finito male lo aveva distrutto. Per risparmiargli la pensione per indigenti e il reparto psichiatrico, la nostra famiglia lo aveva adottato, a pranzo e a cena e il pomeriggio del sabato e della domenica. Così era diventato “zio”. Non so perché “Gino”, dato che il suo vero nome era Ferdinando.
«Altra sponda. Altra sponda di certo.»
«Babbo…»
«Ho torto o ragione?»
«Che c’entra…»
«Il povero Vinci è scagionato, questo è poco ma sicuro,» disse zio Franco.
«Gira voce,» intervenne zio Gino, «che v’abbia le mani in pasta un rampollo dell’alta nobiltà.»
«A me risulta un lavoro strano. Un lavoro da bracciante cacciatore,» disse babbo.
«Com’è come non è, pare che lavorano in gruppo,» disse zio Franco.
«I ricchi si tirano sempre dietro i poveri per fare le peggio sozzerie,» commentò zia Paola. A un’occhiata di mamma, corsi in cucina, canticchiando «people on streets, people on streets,» a prendere i vassoi degli affettati.
«Prosciutto, finocchiona, salame, salsiccine, anzi, sal-ci-ccì-ne di cinghiale, quello è rigatino… e soprassata,» illustrò mamma.
«Non c’è la matrice?»
«Babbo…»
«Non lo dico per niente. Il Mostro ha fatto un lavorino raffinato, di bisturi e coltello.»
«Guido…»
«Non scherzo affatto! Ci vuole un professionista. Degli apparati genitali.» E fece l’occhiolino.
Riccarda e Mafalda diventarono tutte rosse per il ridere e nascosero la faccia nei tovaglioli.
«Ora basta Guido, ci sono i piccini.»
Ci voltammo all’unisono verso Mimmo, che però era lì tutto innocente che componeva triangoli e spirali sulla tovaglia con i noccioli delle olive. Accortosi che tutti lo guardavano, gridò «non sono stato io!» e si tuffò sotto il tavolo.
Lasagne. Rosbif.
«E tu Arianna, che fai?» chiese mamma sfoderando il sorriso da réclame.
Ayaan finì di masticare con calma e sorrise altrettanto: «niente.»
«Ah,» mamma sorrise di più.
«Nel senso: studio.»
«E la nonna in carriola,» disse nonna.
«Ah,» ripeté mamma e mostrò di ritenersi soddisfatta della risposta. Non zia Paola:
«E cosa studi?»
«Agraria.»
«Studia da contadina come Pacciani,» disse babbo.
«A tutti gli effetti,» disse zio Franco.
«Spaziale,» disse Riccarda. «C’è una amica di una mia amica che praticamente anche lei studia agraria e l’altro giorno mi ha detto che si è presa una fittonata per i fittoni. Hi. Fittonata. Fittoni. Hihi.»
Zia Paola ringhiò: «Perché, c’hai un’amica?»
«Insomma,» farfugliò Riccarda, «una sottospecie…»
Noi pensavamo che Riccarda era musona perché era baffuta e nessuno la voleva, in realtà era musona, ma anche baffuta, perché gli uomini non li voleva ma non lo poteva dire perché sennò zio Franco la ammazzava e poi si ammazzava. Le donne voleva. Mi confidò decenni più tardi che stava uscendo di testa per la voglia di abbracciare il corpo rovente di Giada, la migliore amica che amava da quando aveva sette anni, con cui poi, approfittando della morte improvvisa di quell’inutile di suo padre, fuggì in Spagna.
«Mi pareva,» concluse zia Franca, poi rivolgendosi ad Ayaan: «E di dove sei?»
«Somalia.»
«Uh, che bello,» disse mamma.
«Bello,» disse Ayaan. «Quando il governo non stermina il tuo clan.»
«Certo anche voi, con questa fisima atavica del clan…» disse zio Gino.
«È il mondo che va in malora,» disse zia Paola.
Profiteroles. Panettone. Pandoro. Panforte.
«Nonna, se riesci a disarpionare Nick un secondo, gli faccio vedere casa.»
«Che m’importa a me, sto mangiando,» bofonchiò nonna e per ribadire il concetto si cacciò in bocca un cavalluccio.
Casa era un villino primi Novecento di tre piani (seminterrato incluso), in un bel quartiere arioso vicino alla campagna. Ammodernata pochi anni prima senza rinunciare al mobilio anteguerra, era un’apologia della comodità senza riuscire a essere accogliente. Da bambina la chiamavo “la casa felpata”, e avevo ragione. Per il parquet alternato a moquette, gli infissi di legno che incorniciavano tappezzerie di tela rossa o carminio, le poltrone gonfie, e il modo di camminare dei suoi abitanti, prima di tutto dei nonni, ma che tutti abbiamo ereditato, silenzioso ed esitante. Da bambina credevo che la casa fosse abitata da presenze ulteriori, non proprio fantasmi, ma delle specie di animaletti composti di giocattoli e soprammobili, anche loro senza dubbio felpati, non esattamente gradevoli, ma caratteristici e comunque perfettamente familiari nella loro maniera di accodarsi invisibili alla gente con movimenti sincronizzati.
In quella fase, nel 1985, più che altro là dentro sentivo una colata di noia in cui si mischiava la paura assurda di essere costretta a tornare ad abitarci. Mi capitò in seguito, di riavvertire quelle presenze e sentire che fungevano da mediatori – attraverso la casa – tra la famiglia e il mondo reale. Nick non ce l’avevo mai portato nella casa felpata, perché credevo che tenere il fidanzato lontano dalla famiglia fosse un modo efficace per evitare che i problemi tra me e i miei inquinassero il rapporto tra me e lui. Avevo cambiato idea, alla fine, solo perché i miei genitori avevano smesso di insistere nell’invitarlo.
Gli mostrai il corridoio con le stampe di De Chirico e il salotto con il pezzo grosso, un tappeto di Boetti e i divani in ecopelle intorno alla televisione che il nonno aveva fortemente voluto e perciò non si erano potuti sostituire. Lì rinvenimmo il Presepe, nascosto in una cupola di stagnola sotto il tavolino del telefono, come per proteggere la Sacra Famiglia dalle onde elettromagnetiche. Raccolsi il neonato, dissi: «questo lo portiamo su, che devo farti vedere una cosa». Passammo dal corridoio secondario che era l’area preferita dei felpati, oltrepassando il “bagno piccolo” e le scale per la cantina. Il piano di sopra era silenzioso e più freddo, con gli studi, le biblioteche e le salette per la colazione in perfetto ordine, ma inutilizzati.
C’era camera dei miei, con la porta sempre chiusa, e in fondo la mia cameretta. Le foto appese alle pareti erano miniere di ricordi di cui non dissi niente, che non ne avevo voglia, e mi sembrava neanche Nick. C’era però una foto di cui volevo parlare, incorniciata sul comò, perché c’ero io neonata in culla che ridevo luminosa e allargavo le braccia nella stesso identico gesto del Gesù Bambino che avevo portato su per il confronto. Ma lui si stese sul lettino incellofanato e chiuse gli occhi. Lo guardai qualche secondo provando sentimenti inesprimibili, poi spensi la luce e scesi.
In salotto m’imbattei in Mimmo che balzava nervosamente qua e là stringendosi il pisello. Il Che gli saltava intorno scodinzolando.
«Mimmo cosa fai?»
«Niente.»
«Ti scappa la pipì?»
«No.»
«Sei sicuro?»
«Sì.»
Ancora due salti e si accucciò, in mezzo al tappeto.
«Ti scappa la cacca.»
«No.»
«Ti scappa la cacca.»
«Sì! Ma il bagno piccolo è occupato.»
«Vai nell’altro.»
«Ho paura dell’altro bagno.»
L’altro bagno in effetti era spaventoso: dovevi scendere le scale della cantina fino al pianerottolo d’angolo e poi infilarti in una lamella di corridoio sbieca e piena di ragni. Inoltre il bagno aveva una finestrina chiusa da una grata rugginosa che dava non si sa dove, perché in teoria la stanza era sotto terra. Ci sarebbe stato anche un terzo bagno al piano di sopra, quello dei nostri genitori, ma l’accesso ai figli era ultravietato.
«Vedrai che adesso si libera.»
«È un’ora che è occupato!»
«Va bene. Vado a controllare. Tu aspetta qui. Resisti.»
Stavo per bussare quando udii un sussurrio femminile: «dimmelo ancora…»
Turbata, mi chinai sul buco della serratura e spiai. Andrea arpionava il culo ad Ayaan e le avvicinava la bocca all’orecchio. Non potei sentire la sua risposta, borbottava come sempre, afferrai solo Ayaan ripetere «dimmelo ancora» e ridacchiare. Mi sentii morire. Mimmo mi tirò per la manica e chiese «chi c’è in bagno?»
«Zitto, vieni.»
Daccapo in salotto.
«Chi c’è in bagno?»
«Che t’importa? Aspetta solo altri cinque minuti.»
«Ma io non ce la faccio più,» si lagnò il poverino.
«Resisti, manca pochissimo.»
Mi guardai intorno alla ricerca di un gioco per distrarlo. Mi cadde l’occhio sul Presepe. Gli mostrai i pastori e i Magi sopra, la Beata Famiglia sotto.
«Perché non c’è Gesù Bambino?»
Stavo per dire “c’è l’ho qui,” ma mi resi conto che doveva essere rimasto in camera sul comò.
«Perché è in bagno a cacare, Mimmo.»
Credevo fosse chiaro che scherzavo, ma Mimmo fissò pensieroso il giaciglio vuoto.
«Allora non bisogna fargli fretta. Poverello, è come un orfano. Chissà come si sentiva, appena nato, al freddo e al gelo.»
Senti che ipocrita, pensai, non mi diventerà mica credente?
«Lia! Emilia! Apriamo i regali!» sbraitò mamma.
Lasciai Mimmo alle sue considerazioni. Trovai la famiglia che giocava a ramino, esclusa Mafalda che si guardava le mani. Provai a trovare la voglia di sedermi accanto a lei e chiederle qualcosa, che so, sulla scuola, ma non mi riuscì. Zio Franco dovette notare l’incertezza perché puntò la mano tesa contro la figlia e gridò:
«Non sa fare niente!»
«Ma no,» disse zio Gino, «vedrai che qualcosa sa fare, se ce la fanno gli altri…»
«No Gino, te lo dico io, non sa fare niente di niente.»
«Ma non è possibile, almeno una cosa la sanno fare tutti, eh?»
Ripeté «eh?» a ciascuno mostrando il dito indice puntato verso l’alto a indicare “una cosa”.
«Dai, gioca,» disse zia Paola, spense la sigaretta, tossì, aggiunse: «certo che sa fare qualcosa: sa smaniare sa.»
«Smania?» fece eco zio Gino e guardò Mafalda sconcertato.
Andrea e Ayaan irruppero ridendo incontrollabilmente.
«Non avete idea! Venite a vedere!»
«È successo di certo,» commentò zio Gino, «qualcosa di molto divertente.»
Il tavolino del telefono era stato spostato. Là dove si era posata la Stella Cometa, gravava un mucchio di cacca, così massiccio da sfondare il soffitto della grotta e inghiottire i suoi occupanti. Tutti pensammo: non può essere uscita da un bambino. Ma Mimmo era lì, a brache calate, raggiante.
«Mimmo!» gridò il babbo, «perché hai cacato sul Presepe?»
«Perché Gesù Bambino si è preso il bagno!»
Mi defilai. Non ne potevo più di famiglia, delle loro voci, di tutta la zavorra emotiva che si accumula quando la gente vive insieme per anni, volevo licenziarmi, andare in Sicilia, in Jugoslavia. Il Che, intuendo che si stava per andar via, mi si accodò. Svoltando nel corridoio secondario rischiai di scontrarmi con nonna che si affaticava pian pianino, felpata, in un silenzio che sembrava riassumere tutte le parole superflue del passato.