Ero a Roma con un preciso scopo, anche se spesso tendevo a dimenticarlo.
Quel sole caldo, i profumi della primavera e le piccole, stupide cose della vita mi spingevano a sprecare tempo e energie. Così non andava bene. Mi ripromisi di concentrarmi di più sulla mia impresa.
Giunsi qui a Roma il quattordici marzo, dopo una settimana di viaggio – circa seicento chilometri in autostop. Perché non presi il treno? Semplicemente non ci pensai.
Persi pure due notti a Firenze: girovagai per le piazze piene di gente, mi aggregai a questi e a quelli, consumai sostanze, mangiai e bevvi in compagnia, dormii e feci sogni strani quasi tutto il giorno dopo, ai giardini di Boboli. La seconda notte seguii una comitiva di un allampanato ascetico pazzo: tunica e ciondoli trovati nelle uova di pasqua, capelli ispidi striati di bianco, occhi spiritati, blaterava dell’esistenza di una panetteria notturna che distribuiva gratis un irrinunciabile strudel proletario. Doveva assolutamente trovarla, quella panetteria, e noi con lui. Fino alle prime luci dell’alba attraversammo la città in lungo e in largo, il gruppone che si sgranava e si rinfoltiva di adepti secondo la casualità indifferenziata del Caos. Niente da fare, lo strudel proletario non si trovò in tutta Firenze e venne giustamente ascritto alle strambe chimere del socialismo rivoluzionario del 1978. Uno dei terribili, famigerati anni di piombo.
Una volta a Roma, la prima notte la passai alla stazione Termini, il posto più sicuro, data la presenza di un’impressionante massa di disgraziati accampati in sacco a pelo. In quel marasma di umanità sarei senz’altro passato inosservato, nessuno avrebbe potuto trovarmi o impedirmi di fare quello che avrei dovuto fare. Intorno alle sei del mattino, con la piantina di Roma e un caffè in mano, studiai il percorso. Quel giorno avrei fatto solo una puntata esplorativa, un sopralluogo sul posto per preparare l’azione.
La Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini era piuttosto lontana: dovevo uscire dalla stazione, avanti dritto, poi via Nazionale, Piazza Venezia e il lunghissimo corso Vittorio Emanuele II, tutti nomi che richiamando un qualcosa di reazionario accrebbero in me la determinazione. Lasciai la mia roba all’ufficio bagagli e m’incamminai, solo con lo zainetto, la mappa e la grossa pietra che mi ero portato da casa, perché non si poteva mai sapere.
Trasalii guardandomi riflesso nella vetrina di un negozio. Non ero abituato a vedermi coi capelli corti. Un sacrificio grande ma necessario, con l’aria contestataria da capellone non sarei mai riuscito ad avvicinarmi all’obiettivo. Nonostante il percorso mi fosse abbastanza chiaro, dovetti consultare spesso la mappa. Troppe cose mi distraevano, mi disorientavano e mi facevano cambiare strada, attivandomi curiosità e passioni che non avevo considerato. Mai visti così tanti monumenti, immensi e grandiosi, spesso incastonati in palazzi contemporanei. Ogni strada, ogni piazza del centro serbava tonnellate di Storia grondanti sangue e gloria. E quante chiese… c’erano quasi più chiese che case. Un ventenne non può comprendere la malinconia del passato, io invece sì: capii perché Roma venisse chiamata la Città eterna mentre accarezzavo con entrambe le mani le grandi mura del Teatro di Marcello consumate dal tempo.
Arrivai in piazza dell’Oro, la chiesa si stagliava massiccia e marmorea, con una scalinata breve e arrotondata. Erano le nove circa, tardissimo, avrei dovuto essere lì almeno due ore prima, alle sette, per studiare bene la scena. C’era parecchia gente, troppa, che entrava e usciva, per non parlare del traffico nella vicina via Acciaioli. Non c’erano mendicanti davanti all’ingresso. Cominciai a pensare che forse, la mattina giusta, avrei potuto appostarmi lì fuori, con la mappa in mano, fingendomi un turista. Un turista già in giro all’alba? No, mica ero giapponese. Il selciato in porfido della piazza era in parte dissestato, sarebbe stato facilissimo prenderne due o tre cubetti da usare per l’azione. E io che mi ero portato l’arma da casa… Quello che avevo nello zainetto, però, era lo stesso pietrone che mi aveva accompagnato in tutte le ronde notturne di quartiere, contro gli attentati terroristici, la strategia della tensione, le famose bombe di Savona, solo quattro anni prima. Un ricordo pesante, per quello che valeva.
Entrai in chiesa e attraversai l’ampia navata, diretto ai gradini prima dell’altare. Un interno davvero ricco e maestoso. Lungo le navate laterali c’erano i confessionali; mica male quelli come nascondiglio, pensai. Guardandomi bene attorno, accesi un po’ di candele votive e non misi nessuna moneta nella cassetta delle offerte. Anzi, scrissi una breve frase su un bigliettino, lo feci a fatica perché spesso la vista mi si annebbiava, poi lo piegai e lo infilai nella fessura.
Meno Chiese Più Case.
Tanto per chiarire, per quel che serviva, ovviamente.
Mentre continuavo ad accendere candele gratis, il silenzio cessò di colpo quando l’impianto di amplificazione della chiesa cominciò a trasmettere una canzone:
Ma lasciarti non è possibile
No lasciarti non è possibile
Lasciarti non è possibile
No lasciarti non è possibile
…
Era Ancora tu di Lucio Battisti. Suonava strana, davvero, in una chiesa. Mi guardai attorno: le persone lì dentro, circa una trentina, non sembravano stupite. E io che mi ritenevo un anticonformista. Non mi piaceva granché Battisti, cioè le canzoni non erano male però era un mezzo fascio, lui, lo sapevano tutti.
Un uomo con impermeabile e occhiali scuri mi passò davanti, quasi mi scontrò, e si diresse al confessionale, entrando in uno dei due vani laterali, quelli dei peccatori, chiudendo dietro di sé la tendina. Dallo spazio centrale, invece, quello del confessore, la tendina venne invece scostata e spuntò una faccia che mi guardò fisso, prima di sparire nuovamente all’interno. Il tutto durò una manciata di secondi.
Rimasi interdetto, perché quella faccia la conoscevo, era proprio Lucio Battisti in persona ma poi pensai: figurati se… D’altronde non l’avevo mai visto dal vivo, solo in Tv o nelle copertine dei dischi.
E come stai? Domanda inutile
…
Uscii molto confuso. Discendendo la scalinata, notai due persone, anche loro con impermeabile e occhiali da sole. Facevano finta di discutere tra loro, mi osservavano con la coda dell’occhio. Cominciai ad accelerare il passo e mi infilai nella rete tortuosa del centro storico, da lì presi a correre. Mi fermai in un androne semibuio, rifiatai e controllai la mia posizione sulla mappa. Ero in via Giulia, vicino al palazzo che ospitava il Museo Criminologico. Sporsi la testa per vedere se gli impermeabili mi stavano seguendo: niente di sospetto. Attraversai velocemente la via e mi infilai nel museo, pagai il biglietto e mi avventurai nelle sale tra morti, delitti e torture.
Giunsi nel pomeriggio in stazione per ritirare il mio bagaglio. Indossavo una giacca di renna, un tempo elegante, e un paio i occhiali tipo ray-ban a specchio, roba presa mezz’ora prima in una bottega dell’usato. Seduto ai bordi del grande atrio per mangiare un panino, dagli altoparlanti della biglietteria, dopo l’ennesimo annuncio dei treni in partenza e in arrivo, partì la musica di intermezzo.
Ancora tu non mi sorprende lo sai
ancora tu ma non dovevamo vederci più?
Non potevano essere tutte coincidenze, quelle. Cominciai sul serio a preoccuparmi di essere controllato. Dovevo sparire dal centro, confondere le acque. Uscii e presi un bus al volo, senza neppure vedere che linea fosse. Entrando in carreggiata, il bus ne affiancò un altro, ancora fermo e stracolmo di gente. Vidi nuovamente lui, Lucio Battisti, che sorrideva a una donna elegante.
Nel bus, le persone cambiavano continuamente fisionomia, salivano, scendevano, parlavano di clima, guerre stellari e brigate rosse, nessuno mi degnava di uno sguardo. Bene, il tempo passava, cominciai a rilassarmi e a guardare il paesaggio dai finestrini, stupendomi della terribile estensione urbana delle periferie romane, milioni di metri quadri di tetti catramati, stesi a scaldarsi sotto il primo sole primaverile.
Passò il giorno e venne la sera, ormai ero abituato all’umanità locale e a quegli spazi anonimi dove si alternavano senza fine palazzi di cemento e parcheggi. Ero stanco, decisi di passare la notte dalle parti del capolinea del bus del momento. Arrivato nella zona della Camilluccia, un posto mica male, scesi in via Stresa. Ebbi subito conferma di trovarmi in un posto tranquillo, con palazzi ricchi di verde intorno, pochi bar e negozi. Mi fermai nello spazio esterno di un locale chiuso per lavori, il bar Olivetti, all’incrocio con un’altra via. Mangiai un sacchetto di patatine e bevvi due birre prese in stazione, progettando di andare a dormire lì intorno.
Nessuna traccia di aree verdi pubbliche; non era il caso di farsi vedere troppo in giro, decisi allora di scavalcare la bassa recinzione del condominio di fronte al bar, dove c’erano una bella macchia di verde e un grande salice piangente, proprio all’angolo dell’incrocio. La zona non era illuminata, il palazzo sembrava quasi abbandonato, mi sistemai sotto un grande cespuglio che mi nascondeva del tutto. La sera non era particolarmente fredda, il sacco a pelo bastava. Avevo bevuto parecchio, ero stanco e avevo un pacchetto di Camel quasi pieno.
Mi svegliai presto, intorno alle sei, ma preferii restare nel sacco e poltrire ancora, con il sottofondo dei soliti rumori dell’umanità che va al lavoro. Era il 16 marzo 1978, un giovedì, un giorno lavorativo come gli altri. Ascoltai rilassato, vicini e lontani: saluti, usci aperti e chiusi, luci accese e dopo spente, rumori di chiavi, passi calmi o affrettati, portiere aperte e chiuse, accensioni di motori, manovre e mezzi che partivano. Dopo le otto ritornò un certo silenzio, rotto solo da qualche auto di passaggio.
Intorno alle otto e quarantacinque arrivarono due persone a piedi, si fermarono all’incrocio, proprio a un passo da me, sotto la recinzione del giardino. Parlottavano concitati ma non compresi bene le parole. Mi sporsi appena dal cespuglio per guardare. In quel momento ne giunsero altri due. Tutti e quattro avevano una divisa militare, forse da finanzieri, e avevano delle borse sportive. Scrutarono la zona – la via era deserta – e andarono a sistemarsi dietro le siepi del Bar Olivetti. Mah. Ebbi l’istinto di scappare ma quei militari erano proprio di fronte a me, al di là della strada, e io avrei dovuto scavalcare la recinzione del giardino. Appallottolai il sacco a pelo, misi tutto nella sacca e restai sotto il cespuglio, ben nascosto, aspettando che andassero via. Sentii arrivare altra gente, una donna e un uomo che impartivano ordini. Si fermarono alcune auto, due, forse tre. Altre voci concitate e passi veloci. Non c’era nulla di normale in tutti quei movimenti e la scenografia intorno sembrava una ghost town dei film western, facciate di case posticce con niente e nessuno dietro.
Quasi le nove, un’altra auto, con andamento sostenuto, frenò di scatto allo stop dell’incrocio, dalla mia parte, e restò ferma lì, motore al minimo, finestrino aperto, autoradio accesa:
Disperazione gioia mia
sarò ancora tuo sperando che non sia follia
ma sia quel che sia
abbracciami amore mio
…
Il rumore di altre due macchine in arrivo si sovrappose al motore acceso di quella ferma allo stop. Alcuni secondi dopo iniziò il grande, tragico teatro della Morte.
Stridore di freni, un urto, un altro, motori fuori giri, urla e passi, e poi tutti quegli spari:
pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam.
Novantuno colpi in tutto, una cacofonia di raffiche, spari isolati o sovrapposti, grida, sprazzi di silenzio sospeso, rumori di lamiere schiantate e traforate. Alcune raffiche trapassarono con un sibilo – zio zio zio – il cespuglio dove ero rifugiato. Mi appiattii il più possibile a terra, la testa tra le mani, una nuvola di rami e foglie volavano per aria. Cessati i colpi, odore di bruciato e di benzina, passi concitati, portiera che si apre, una voce stentorea di uomo che urla Lasciatemi stare! Auto in movimento, frenate, una voce perentoria che ordina Dentro! e la portiera che si chiude, auto che sgommano, accelerano e si allontanano.
Poi silenzio, cala il sipario e fine della rappresentazione.
Alzai la testa dal cespuglio e mi sporsi per vedere sotto, l’incrocio: le auto erano abbandonate in mezzo alla strada e cinque uomini giacevano crivellati di colpi. Qualcuno stava arrivando a piedi. Il posto si riempì di persone, passanti, auto in arrivo, molti fantasmi cominciarono a sbucare fuori dalle quinte dei condomini. Mi avvicinai al palazzo, uno dei finestrini bassi delle cantine era aperto a vasistas, vi buttai dentro la mia sacca con tutto il poco che avevo: il sacco a pelo, qualche indumento, lo zainetto, il pietrone e pazienza per quella roba. Tenni solo i vestiti che avevo indosso, documenti, sigarette e soldi. Mi mescolai al gruppo di gente che si andava assembrando. Qualche curioso era già vicino alla scena del massacro. Notai un cadavere a terra, con le braccia spalancate, sembrava un cristo senza croce, inchiodato sull’asfalto. In lontananza si avvertiva un coro scomposto di sirene, stavano arrivando le forze dell’ordine e le ambulanze. Avevo appena il tempo di allontanarmi dalla bolgia e così m’incamminai verso sud, fino a via Balduina, dove presi un bus per il centro. Presi posto in fondo, la faccia incollata al finestrino, avevo sicuramente un’aria stravolta e cercai di mostrarla il meno possibile ai viaggiatori che man mano salivano.
Una volta in centro, mi bastò scendere e fermarmi in un bar per non sentire parlare altro che della strage di via Fani. Avevo nausea e mi sentivo mancare le forze. Non avevo mai assistito in prima persona alla Violenza e alla Morte.
Nella mia testa cresceva ogni sorta di male: terrore, tristezza, abbandono. Anche quella bestia maledetta stava crescendomi dentro la testa, presto mi avrebbe mangiato il cervello e mi avrebbe ucciso. Gli esami clinici erano chiari, talmente chiari che avevo deciso di fare quell’ultima cosa, la sola importante prima di diventare un malato terminale e poi morire. Punire colui che tutti noi vedevamo come il Male assoluto, il custode e il responsabile dei più grandi e terribili segreti del nostro Paese.
Forse non ce l’avrei fatta con una sola pietra.
Forse le guardie del corpo mi avrebbero ammazzato prima.
E forse sì, sarebbe stato meglio così, avrei solo accennato il gesto, aspettando la reazione.
Sì, meglio essere un Jan Palach che un Gavrilo Princip.
L’addio ad Andreotti nella Chiesa dove pregava ogni mattina. Esequie in forma privata per il senatore a vita nella sua San Giovanni dei Fiorentini a Roma, la Chiesa dove il senatore, finché ha potuto, andava a pregare sempre all’alba. Alle sette della mattina, infatti, era sempre lì, come racconta il parroco, poi iniziava la sua giornata.
(Agenzia Stampa, 8 Maggio 2013)



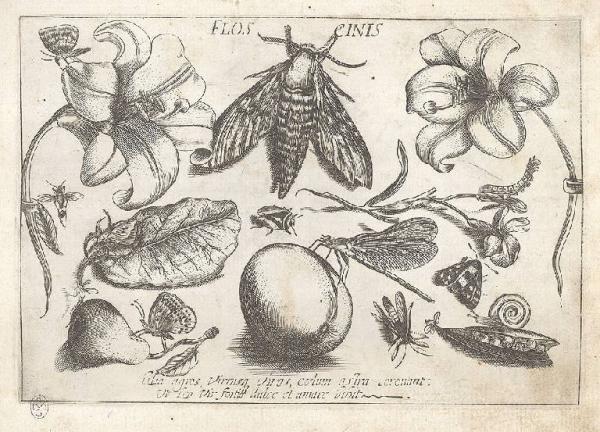
Chapeau.
Sherabientot grazie
Merci! Thanks! Grazie, davvero.