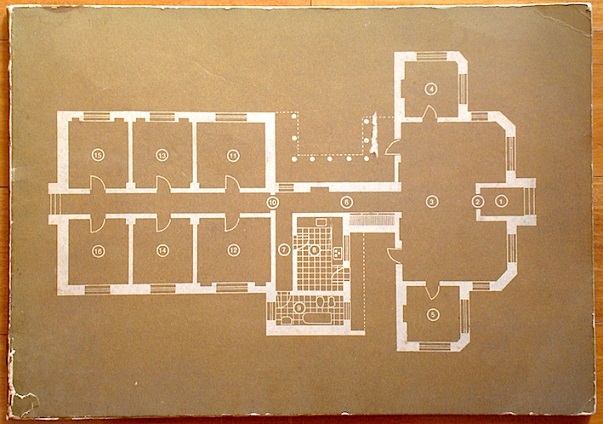
Quando incontrai Peppe Simonetti eravamo due ragazzi iscritti al terzo anno di università: Filosofia io, Lettere Classiche lui. Ci conoscemmo in uno degli spazi occupati della facoltà di Filosofia, lui all’epoca si era invaghito della mia collega Micol e stava cercando un contatto con lei. Ora, quello che non aveva Peppe era la bellezza, così gli fu difficilissimo entrare in confidenza con lei; quando ci riuscì, però, compensò la sua bruttezza con un carisma innato, quasi strabordante, a tratti fastidioso per chi – come me – doveva ritrovarsi a competere con lui per avere l’attenzione di una ragazza. Quasi che le sue doti intellettuali diventassero estetiche, si trasformassero in feromoni e tratti somatici, fino a renderlo irresistibile a chiunque avesse l’idea di parlare con lui.
La mia fortuna fu che mi venne presentato Peppe quando ormai il dado era tratto: aveva già conquistato Micol, in quella stessa aula occupata dove lo avrei incontrato la prima volta, e io – in fondo – non avevo mai nutrito alcun interesse per quella ragazza alta e bella, che mi era sempre sembrata francamente stupida. Sta di fatto, comunque, che mi sembrò immediatamente più interessante non appena conobbi Peppe. Il piacere cambia a seconda di quanto questo piacere è tale per gli altri. Chi lo ha deciso che essere bionde e alte sia una qualità estetica? Ma d’altro canto, anche se si decidesse che essere basse e more sia una qualità estetica, questo non muterebbe la mia domanda. E, ancora, se tutti fossimo ciechi, ci sarebbero altre qualità estetiche, e pure non cambierebbe nulla al nocciolo della questione. Così ricordo che pensai mentre spiavo con la coda dell’occhio Peppe e Micol strusciarsi contro i muri sudici dell’università: è l’estetica – davvero – una priorità? Il corpo è un aggettivo dell’estetica, non il fenomeno.
Fu un incontro, tra me e Peppe, di anime e profondità: parlai con lui intere notti del bisogno umano – antropologicamente connotato – di metafisica e teologia. Nonostante tutto, io ero un fervente bisognoso dell’altrove, dell’aldilà ontologico che mi faceva sperare che le mie velleità creative avessero un qualche senso causale, per salvarmi da quel vuoto metafisico che mi risucchiava non appena riflettevo a me come a una componente frammentata dell’unicum. Peppe invece mi parlava della sua convinzione del reale come coalescenza: era convinto che le parole e le cose fossero legate a doppio filo da un patto biunivoco, che il linguaggio parlasse delle cose stesse e che le cose stesse si lasciassero conoscere solo attraverso l’arma linguistica. Aveva letto Il mondo come volontà e rappresentazione e da allora gli piaceva dire: Il Mondo è la Rappresentazione della Volontà del Linguaggio. Non era interessato all’aldilà quanto all’aldiquà: non sentiva il bisogno di nessun dio se non quello che creava lui scrivendo. Se non era questo, la rappresentazione più alta di un bisogno antropologico di teologia, io non sapevo davvero cosa altro potesse essere. Glielo facevo presente tutte le sere, e lui tutte le volte rispondeva: Se il bisogno teologico è scrivere, allora Dio sono io. Forse lo era.
Cominciò una sana competizione, fatta di scambi reciproci. Io gli insegnavo come leggere Nietzsche, e lui mi consigliava tragedie greche, in particolare Eschilo: lo adorava, e io non seppi mai confessargli che – in cuor mio – avevo sempre avuto una predilezione per Euripide, la Medea in particolare; oppure cercava insistentemente di farmi leggere la Gerusalemme Liberata, supplizio al quale non ho mai voluto sottopormi. Lessi però, sotto suo consiglio, il Don Chisciotte e mi cambiò la vita. Quando mi propose il Faust di Goethe, provai un’estasi mistica molto simile a quella di cui parlavano i teologi del 1300 che stavo approfondendo in quegli anni.
Scriveva molto più di me, e aveva il coraggio di parlarne. Era generoso fino al fastidio: non appena intuiva che qualcuno potesse avere bisogno di un approfondimento, di un consiglio letterario o di una esegesi , lui subito si lanciava in lezioni improvvisate. La gente lo adorava, ma io presto iniziai con il detestare questo suo lato profetico: non appena notavo la sua voce aumentare di volume, il suo corpo farsi strada per ricavare il centro dell’attenzione, io fingevo un’urgenza impellente di fumare e me ne scappavo fuori. Non che a me certe spiegazioni non servissero, ma non sopportavo che fosse lui a impartirmele.
Quando cominciò a chiedermi di leggere gli scritti che tenevo segreti a tutti, in me si accese una miccia che non sapevo si potesse innescare. Io che avevo vissuto una vita ai limiti dell’anonimato, nascondendo a tutti – forse addirittura a me stesso – il lato prioritario del mio essere, ora che lasciavo che qualcuno potesse vederlo, il mio cervello reagì come se qualcuno m’avesse visto nudo. Ricordai la prima volta che avevo fatto l’amore, e il paragone mi parve calzante: una linea di pelle magra e smunta che si proietta verso un buco nero caldo e accogliente, nel dubbio più dirompente di tutti: piacerò? Così desideravo che Peppe apprezzasse i miei scritti, come se mi avesse visto il membro. Non sopportavo l’idea che scoprisse qualche deformazione alla prima occhiata, ma allo stesso tempo il desiderio – quasi ghiandolare – era così grande che forse ambivo a una sua critica, così che potesse continuare a leggere me, ancora e ancora. Scrivere era l’atto più intimo che io sapessi concepire per me stesso: un bosone inscindibile con la mia persona, che nessuno mai aveva avuto il sentore potesse esistere. Peppe aveva avuto intuizione di ciò, mi chiese per primo di poter leggere qualcosa di mio, e per me fu come se avesse avuto cognizione di me. Inutile dire che non gli piacque quasi nulla di ciò che gli proponevo.
Spesso ripensavo alla sua furia linguistica, a quella sua idea della coalescenza tra nomi e cose. Gli dicevo: come fai a dire che le parole sono le cose? Io non sono solo Ciccio, tu non sei solo Peppe. Una volta sola mi rispose: Ci sono due Peppe, due Ciccio: quelli che scrivono, e quelli scritti. Me lo disse con talmente tanta semplicità, sorridendo come si sorride al bambino che non sa cosa significhi la parola “barattolo”, che non gli chiesi mai più niente. Lasciai, da quel momento in poi, che potesse solo criticare ciò che scrivevo. Io, nel frattempo, diventavo migliore, scrivevo di più e con più cognizione, ma mai arrivai a superarlo.
Scriveva talmente tanto da dimenticarsi di ciò che scriveva. La sua era una iper-produzione testuale: come una crosta che gli dava sui nervi e che doveva necessariamente grattarsi via, anche a costo di scorticarsi a sangue, questo era per lui la scrittura. Infatti, non passò molto tempo prima che questa sua foga letteraria si ripercuotesse anche sul fisico: una magrezza inquietante, denti ingialliti dal tabacco e dall’incuria, unghie lunghe (che lui nascondeva dicendo che gli servivano per suonare la chitarra) e capelli sporchi. Non dormiva, o dormiva male: i suoi sogni erano tormentati da storie oniriche aldilà dell’onirico, perché avevano una trama e uno sviluppo. Era ossessionato dall’idea di dimenticare i suoi sogni, così si forzava – in modo ossimorico – di restare sveglio mentre sognava, così da poter alzarsi subito e filtrare con penna. Era tutto rappresentazione del mondo, anche i sogni, e così Peppe scordò di essere anche un uomo. Credo che ne fosse cosciente: sembrava volersi annientare.
Andammo a convivere in un appartamento nella zona universitaria della città dopo un anno circa di conoscenza. Decidemmo di smettere di fare i pendolari, vita che concedeva poco tempo per scrivere e approfondire le lettere e la filosofia, e di convivere per poter avere un confronto più serrato. In più, la nostra compagnia c’era sempre piaciuta. Quello che non mi piaceva di Peppe era il suo modo di vivere il sociale, ma presto avrei smesso di preoccuparmene, perché smise di uscire quasi del tutto, anche per andare all’università.
All’inizio della nostra convivenza Peppe aveva preso già uno stile di vita pericoloso, Micol era scomparsa dai radar della quotidianità da tempo immemore, e io per un periodo mi ero goduto questa sua solitudine, pensando egoisticamente che avremmo avuto più tempo per parlare. Mi sbagliavo: dopo pochi mesi, Peppe smise di parlare quasi del tutto, accanito dalla sua foga per le parole, che non gli lasciavano lo spazio per interloquire. Vedeva l’oralità come il deterioramento della Rappresentazione, l’approccio plebeo al mezzo più alto che il Mondo ci aveva messo a disposizione per interpretarlo. Se doveva chiedermi qualcosa, scriveva versi o piccole prose arzigogolate e le attaccava in giro per la casa, anche solo per chiedermi di comprare il pane. Questa cosa mi andò sui nervi molto presto. Io non avevo il suo genio, il che aveva già contribuito nel tempo a darmi una visione di me quasi da suo discepolo, ma questa contaminazione folle del suo genio nel quotidiano, mi fecero comprendere che io mai avrei potuto avere la potenza psicologica di assumere su di me, nella mia vita personale, tutti gli assiomi filosofici che avevo nella mente. Peppe aveva scavalcato il gradino della socialità e della sua accettabilità nel mondo, per approdare al mero pensiero sulla vita: io mi dedicavo a vivere la vita con la malinconia di chi pensa, lui invece pensava la vita e non aveva spazio per la malinconia del quotidiano.
Diventammo presto incompatibili, due facce di uno specchio, dove la sinistra è la destra e la destra è la sinistra. Non ci incontravamo più, anche perché era difficile incontrarlo, avrei dovuto salire nella sua mente.
Per stargli vicino, abbassatomi io stesso a un attaccamento morboso del quale mi vergognavo, avevo cominciato a leggere i suoi racconti quando lui era al bagno, unici momenti in cui non era nella stanza e non scriveva. Leggevo avido, mandavo ogni parola a memoria e ne assaporavo l’eleganza, l’abilità di delineare un’esistenza che lui non aveva mai vissuto. Mi imbarazzava rendermi conto di come la vita pensata fosse più produttiva della vita che accade.
Cominciai, quasi senza accorgermene, a trascrivere i racconti. Presto mi accorsi che quei racconti avevano tutti un filo conduttore; erano capitoli di un romanzo assurdo, una cornice che apriva infiniti possibili scenari, e lui li stava trascrivendo – quasi – tutti.
Pensai che sarebbe morto nel tentativo di concludere quell’opera, e mi convinsi che fosse un atto di saggezza quello di trascriverli e conservarli, nel caso fosse accaduto qualcosa a Peppe: in qualche modo presagivo un evento tragico alla fine dei giorni di Peppe, non sapevo quanto presto e per quale motivo, ma sentivo un odore di morte persistente.
Presto Peppe cominciò a puzzare di piscio, e tutta la casa si appestò con questo odore di ammoniaca. Io provavo a lavare la casa quasi tutti i giorni, sottraevo tempo allo studio e alla scrittura per poterlo fare, ma presto mi resi conto che quella puzza mi era entrata nel naso e non se ne voleva andare. Puzzi di piscio da far vomitare, gli dissi un giorno, esasperato da quell’odore e da quell’indecenza in casa: ormai avevo vergogna a invitare persone, anche se avevamo camere separate avevo l’impressione che l’odore permeasse addirittura il balcone della cucina e l’androne del portone. Ma guarda che sei tu, mica io, scrisse lui su un foglietto che aveva sulla scrivania, senza alzare la testa dal foglio più grande sul quale stava continuando a scrivere l’ennesimo dei capitoli, di cui sembrava dimenticarsi ogni volta che li concludeva.
Credo sia stato in quel momento che qualcosa nella mia testa è crollato ; lo presi per la spalla e lo girai violentemente, in modo che potesse guardarmi negli occhi. Cosa posso fare per te?, mi chiese parlando, come se non avessi fatto nulla. Quella cortesia, che mai gli avevo visto in volto in anni di amicizia, lo condannò definitivamente. Mi avventai sulla sua giugulare con i denti, sentii il mio ringhio come se non provenisse dalla mia bocca. Lui tentò una debole difesa, ma era talmente magro che potetti sollevarlo con una sola mano: mi ficcò le unghie sulla spalla, penso non per attaccarmi ma per aggrapparsi, e il dolore mi fece cadere a terra. Lo trascinai con me, e nella colluttazione colpimmo il portaombrelli all’ingresso della stanza di Peppe: ne presi uno, senza sapere perché, e gli spaccai il manico di legno sulla testa. Lui non gridò neanche, perse semplicemente i sensi, con qualche goccia di sangue che gli zampillava da un lato della testa. Quando mi resi conto di quello che avevo fatto, accadde qualcosa di strano: il mio corpo si abbassò al livello dell’esperienza, e la mia mente cominciò a guardarlo dall’alto, si straniò completamente dal mio dolore fisico ed emotivo. Il corpo agiva come un automa e io ricordo ogni scena come se fossi stato uno spettatore dal soffitto. Trascinai Peppe in camera sua: lo misi sulla sedia dove per più di un anno l’avevo visto poggiato con la schiena curva per scrivere, lo sistemai e lo legai mani e piedi. Poi presi una sedia dalla cucina, la trascinai di fronte al corpo svenuto e aspettai che Peppe si svegliasse. Furono venti minuti nei quali ebbi l’opportunità di studiare ogni mio lineamento: stavo invecchiando in quel momento stesso, dall’alto del soffitto potevo vedere i capelli ingrigirsi istantaneamente, le rughe formarsi ai lati degli occhi e i denti cadermi come cadono ai vecchi: la gengiva si era fatta biancastra e rosa, non sanguinava ma appariva malaticcia. Provai a sorridermi: il mio corpo alzò la testa al soffitto e spalancò la bocca in un ghigno, per mostrarmi il risultato: la mia mente voleva vomitare, ma il mio corpo continuava a ridere. In quel momento, provvidenzialmente, Peppe mi fece un ultimo regalo: si svegliò.
Mi guardava con gli occhi socchiusi per il dolore, ma aveva una strana coscienza degli avvenimenti, con il suo solito modo profetico di percepire la realtà. Cosa posso fare per te?, ripeté dopo qualche minuto di silenzio, in cui la mia mente cercava di dire al mio corpo cosa proferire, senza successo. Dammi un titolo, provai a dirgli, ma avevo perso i denti e il risultato fu un fischio strano della lingua, con conseguente schiocco pieno di saliva, che sembrò inondare la stanza. Mi vergognai, ma negli occhi di Peppe non c’era giudizio, anzi sembrò capire quel sibilo incomprensibile: Anatomia del Quotidiano, avevo pensato, ti piace?. Quella compassione fece scattare il mio corpo in piccole sincopi, tremavo a intermittenza: prima le palpebre, poi le mani ogni tanto facevano movimenti non voluti. Il mio corpo agì d’istinto: prese una statuetta di un premio letterario che Peppe aveva vinto da ragazzo, la studiò attentamente in ogni suo punto e si avvicinò di nuovo alla sedia. Mi guardò, il mio corpo, e mi sorrise di nuovo con il suo buco sdentato, prima di ficcare la statuetta nei testicoli di Peppe, schiacciandoli e facendolo tremare di dolore. Urlava come un bambino, piangeva e lo sentii implorare di morire. Perché ti devo uccidere?, chiese la mia bocca, quel suono stridulo e fischiato cominciava a diventare familiare. Peppe allora si concesse un ultimo sorriso, e sembrò tornare allo splendore di quando ci eravamo conosciuti: brutto e consapevole, carismatico anche nel dolore. Se mi uccidi, potrò concedermi il lusso di farti il peggiore degli affronti: dimenticare ogni cosa. Così disse, e al mio corpo evidentemente suonò come un’implorazione : prese la statuetta grondante dei liquidi del membro e gliela spaccò in testa, creando una pozza di sangue gigantesca.
Quando scesi dal soffitto, per tornare dentro le mie stanze fatte di carne e nervi e sangue, provai disperatamente a pulire casa. Pulii da cima a fondo, bagnando il pavimento di lacrime e continuando a pulire sempre le stesse zone. Finii una settimana dopo, solo quando mi ritenni soddisfatto e abbastanza calmo per uscire allo scoperto, anche se ero costretto a un silenzio pubblico, per via dell’improvvisa mancanza di denti.
Prima di uscire di casa, mi voltai a guardare l’appartamento. La casa era pulitissima, ma la faceva da padrona ancora quella puzza di piscio. Il mio corpo rise sguaiatamente e mostrò ancora le fauci, sussurrò: aveva ragione Peppe, eri tu.



