Mi sono lasciata crescere le unghie fino a farne lame. Tutte le mie colleghe me le invidiano.
Me le invidiavano.
Non ho mai pensato a difendermi. Ci fai l’abitudine ai calci in pancia e, se sei fortunata e non ti ammazzano, capisci anche che a reagire, il più delle volte, perdi.
E infatti.
È stata Mimma a consigliarmi di farmele crescere, perché di matti in giro ce ne sono, ha detto, di fattoni che arrivano in gruppo, che vogliono filmare, esibirsi in tutta la loro brutalità, dartele e andare via senza pagare; padri di famiglia infoiati dalla sbronza triste che nemmeno vorrebbero usare le mani, ma gli scappa lo stesso, come una specie di follia, anche se non c’entri proprio niente, e infatti poi chiedono scusa, piangono come ragazzini mentre tirano fuori dal portafogli banconote da cinque euro gualcite, messe via in una settimana di sacrifici, di nascosto dalla moglie, tanto che a un certo punto non capisci più se piangono perché ti hanno menato, o perché vogliono lo sconto; poi ci sono quelli che invece dovrebbero difenderti e che qui a Campo di Carne si muovono in branco. Passano la serata al bar di una stazione di servizio sulla Nettunense a giocare alle macchinette e a bere, di tanto in tanto vengono qui al cavalcavia per vedere come stai, dicono, fanno due inutili chiacchiere e prima di andare via ti prendono del cash, magari tutto quello che hai guadagnato nella giornata, nemmeno fossi un bancomat.
Quando mio figlio grande mi ha domandato come mai avessi le unghie così lunghe, io che le ho sempre tenute corte per non fare loro inavvertitamente del male, mentre li lavavo, mentre si giocava, quando facevo tutte le cose che ogni madre fa, gli ho risposto che a chiedermelo era stata la padrona del negozio di parrucchiere dove crede io lavori. Ho aggiunto qualche particolare nel rispondere alle sue domande di bambino curioso. Così per qualche minuto mi sono sentita una vera parrucchiera, ancora apprendista ma già in grado di passare la tinta. Ed è andata avanti così come in un sogno per alcune domeniche, quando anche il piccolo ha preso a voler sapere della signora, delle clienti, del baretto dove vado a pranzo con le colleghe, delle colleghe.
Mio marito invece lo sa dove lavoro, tanto lui sta in galera. Lo sanno anche sua sorella e il marito, mi ci portano loro, qui a Campo di Carne. Io non ho diritto nemmeno al cellulare, li conoscono i miei orari, sanno quando venirmi a prendere.
L’avessi avuto un cellulare…
Ma io non ho diritto a niente, io conosco soltanto la guerra: la casa famiglia, il tribunale, il tribunale, gli assistenti sociali, la famiglia in affido, il tribunale. L’obitorio.
Mimma ha una cicatrice che parte dal centro della fronte e arriva alla mascella, vicino al lobo dell’orecchio sinistro. Lei, scherzandoci su, dice che quello voleva prenderle lo scalpo, oltre a tutto il resto. Nasconde quel solco evidente con un caschetto liscio. Sostiene che comunque a molti clienti quella traccia di stupro piace, che c’è uno che paga soltanto per toccargliela.
Ha occhi grandi e comprensivi, truccati con cura. Il retrogusto amaro che la vita le ha lasciato lo manifesta di rado.
Soltanto una volta l’ho vista piangere, davanti al corpo ancora caldo di un cane randagio, morto proprio vicino ai copertoni che usiamo per sederci. Lo chiamava Marx, non Max come avevo capito io. Ogni giorno il fulvo a pelo raso sbucava dal cavalcavia e scodinzolava come un pazzo fino a lei. Quando Mimma non c’era, si accucciava per un po’ dalle nostre parti e poi andava via, triste che si stringeva il cuore perfino a me.
Mi dice sempre: reagisci, alza la testa, vivi ogni tanto. Io sorrido per un po’, soltanto per farla contenta.
È più vecchia di me di almeno vent’anni. Ha superato da poco i quaranta ma non sembra proprio. Lei ha studiato, si vede anche da come cammina. Quando si mette in testa di farmi svagare da certi pensieri, mi racconta della sua vita precedente, del negozio in centro, a Roma, una botteguccia in via dei Serpenti, dei gioielli che disegnava, delle feste, del marito morto in un incidente d’auto che le aveva lasciato soltanto buffi; dell’euro, della chiusura coatta, della morte dell’artigianato, dell’inutile ricerca del lavoro. Insomma mi parla delle solite cose che si dicono poco prima di maledire il giorno in cui si è nati. Ma lei invece ci ride sopra. Perché la vita va assaporata a ogni costo, dice.
Poi aggiunge che siamo compagne di sfiga e mi tende il mignolo per fare “flic e floc”, così io rido.
Lei è più libera di me, può scegliere. Ha qualche cliente fisso, professionisti che viaggiano tra Nettuno, Latina, Frosinone, uomini con cui passa più tempo a parlare che a fare.
Ma lei non è me. Perché io ho sempre una punta di sfiga in più di tutte le altre. Mi succedeva anche da bambina, tipo essere interrogata l’unico giorno in cui non avevo studiato, avere il ciclo durante le selezioni per i giochi della gioventù; o da ragazza, sul corso, il sabato pomeriggio, che tra tutte la suora sorprendeva proprio me con la sigaretta in bocca.
Sono una che s’innamora di quello sbagliato e che muore nel giorno sbagliato, quando in Tv c’è di meglio di cui parlare, e la notizia di uno stupro da parte di un africano serve a far propaganda, mentre quella dell’assassinio di una puttana, no. Pazienza se ha due figli.
A Mimma la faccia gliela tagliò un cliente, perciò dovevo farmi crescere le unghie, perché sono la nostra arma di difesa naturale, e se Dio ha deciso di mettercele in dotazione una ragione ci sarà.
Su Dio, la mia collega ha idee un po’ particolari. Non sono riuscita a seguirla in tutti i suoi discorsi, perché quando parte per la tangente, non puoi che stare ad ascoltare anche se ti perdi qualche passaggio ma, in sintesi, non mi è sembrata convinta della sua esistenza, che Dio abiti qui a Campo di Carne, almeno.
Per Natale di due anni fa mi regalò lo spray al peperoncino. Soltanto che ieri sera non ce l’ho fatta proprio a tirarlo fuori dalla borsetta, è stato un attimo e mi sono trovata tra calcinacci, vetri rotti e spazzatura, con quello già sopra che rideva e mi teneva per i polsi. Gli è bastata una mano sola a impedirmi di usare le unghie, trasfigurato in uno che ti vuole proprio ammazzare, che non ha dubbi, che è venuto a colpo sicuro a cercare te. Che come me hai più sfiga di tutte le altre.
E io che il magone me lo sentivo da ieri mattina, quando ho stretto i bambini tra le braccia come non dovessi rivederli più. Poi, a fine giornata, ancora la sensazione di non avere più un domani, di trovarmi al buio, o invisibile, di essere comunque meno importante, nella scala sociale del nostro Paese, dello scheletro d’albero che vedevo dall’altra parte della strada.
La sua auto è uscita dal cavalcavia pochi istanti dopo, un’ombra minacciosa che irrompeva sul tramonto più bello che avessi mai visto. Poi i calcinacci e tutto quello che si sa già, che succede sempre, che siamo abituati a leggere.
Però un paio di tagli profondi glieli ho lasciati. Basterà cercare sotto le mie unghie per trovarlo. Mimma me l’aveva detto: male che vada, quel porco almeno finisce in galera.
Sai che consolazione.
Qui a Campo di Carne c’è morta un sacco di gente, è perciò che di Dio non può esserci traccia, sempre secondo la tesi di Mimma. Sono caduti in battaglia soldati, a decine, soldati romani per la conquista dell’agro pontino e soldati italiani e alleati poi, durante la seconda guerra mondiale. Peccato che, di questo famoso sbarco ad Anzio, fosse la prima volta che ne sentivo parlare.
Quando gliel’ho confessato mi ha sorriso. Poi ha detto che la storia serve a ricordarci che non siamo le uniche vittime delle iniquità di questo mondo, che c’è stata gente, prima di noi, che è morta per niente. Questo almeno il senso del suo lungo discorso su confini e proprietà, e che sulla pelle di tutti noi ci sono donne e uomini, poche decine, che costruiscono imperi di nessuna utilità per chi muore in battaglia, per quelli che restano, per i figli dei soldati e delle puttane.
Gli hanno fatto il monumento ai soldati. E ora ci sto pure io a vagare tra i campi, solo che il mio nome non è scritto sulla lapide, neppure metteranno la mia foto con un mazzo di fiori come si fa per quelli morti in un incidente d’auto, anche se guidavano ubriachi. Forse, Mimma mi lascerà una rosa.
Mi diceva anche: urla. Se ti capita il matto, anche se sei su una via isolata, urla lo stesso, urla forte. Così quello s’innervosisce e perde tempo, tu riesci a liberare un braccio mentre lui si concentra con l’altra mano a tapparti la bocca, magari sei fortunata e gli dai una ginocchiata sulle palle. Rideva. Perché morsi e strilli fanno paura a tutti.
E scaccia via la paura, ti prego, diceva, mandala via la tremarella che non ti lascia ragionare, che ti immobilizza lingua e corde vocali. Oppure paralizzati del tutto, fagli credere che stai male; cedi, arrenditi, lasciati andare, pensa soltanto ai tuoi figli, a qualcosa di bello. Quelli godono proprio del tuo dolore, della saliva che ti cola dalla bocca, degli spasmi, intensa proiezione della loro malvagità, della loro testa nel caos, della spinta megalomane da coca, frustrazione, narcisismo. Vogliono tutta la resistenza che opponi e si nutrono del tuo pianto. Fingiti morta.
Fingiti, morta.
Sì, certo, e come fai con quell’armadio che ti sta sopra e ha pure un’arma che magari userà dopo, pensi mentre ansima e bestemmia a un centimetro dalla tua faccia, e suda. Pensi piuttosto che sarebbe meglio non farlo incazzare, non affrettare i tempi, cercare di calmare il respiro e far riaffiorare la saliva; trovare una soluzione, un sasso, magari, nei pressi. Così il tempo si dilata, quando sei lì sotto, in piena battaglia. E vedi un mondo che non conoscevi, popolato da scarti dell’umanità: un barattolo di pelati, una grossa biglia, la tazza di un cesso dozzinale che sbuca per metà dal terreno, sacchi della spazzatura come sagome di spettatori nella platea affollata della discarica abusiva, lacci di scarpa incrostati di terra, fossili di modernità e progresso.
Prostituta assassinata, scriveranno i giornali, e poi ci metteranno anche la foto. Scriveranno dove abitavo e il mio nome di battesimo, così che, quando i miei figli impareranno a leggere, sapranno tutta la verità e il più bel ricordo che avevano di me, in camice rosa a passare tinta sulle teste delle clienti in un negozio di coiffeur sul corso di Anzio, diventerà il loro peggiore incubo.
Si chiama diritto di cronaca, dice sempre Mimma, quando tra un cliente e l’altro leggiamo sul suo iPad certe notizie. Perché bisognava farlo, il mio nome, sì, evitando magari di scriverci accanto la qualifica. O professione non riconosciuta dallo Stato.
Nessuna donna è meno morta delle altre, meno stuprata, più meritevole di una fine così schifosa.
Potevano evitarla la mia qualifica. Perché quando tra sei mesi nessuno più, tranne i miei due angeli, si ricorderà di me, io su quel giornale ci sarò lo stesso e ci starò per sempre. E con tanto di foto. Con quella faccia triste poi.
Vorrei vedere voi partire alla mattina per Campo di Carne, non sapendo se rivedrete i vostri figli, così cuccioli, ancora troppo piccoli, che ogni volta ti senti rivoltare dentro ma continui a sorridere, a fare quello che devi purché loro mangino.
E certo, sì, se fai la puttana, prima o poi ti capita. Lo so, lo sento il bisbiglio, lo sento fin qui tra i campi. E lo sentono anche i soldati, che certo, anche loro in qualche modo dovevano aspettarselo, ma nemmeno loro, come me, avevano scelto liberamente di morire.
Manco avessi frequentato una scuola per puttane e mi ci fossi anche messa d’impegno, e poi avessi fatto colloqui di lavoro. E magari fosse così, come mi ha raccontato Mimma, che in certi posti civili guadagni bene e sei libera, che puoi dare tu stessa un prezzo al tuo corpo e decidere quando iniziare e quando smettere, metterti in regola, pagare le tasse, avere assistenza sanitaria. L’asilo per i bambini.
Qui in battaglia non funziona così, non sei tu che scegli. Qui va che quello che trovi, prendi. Che devi sottostare alla regola dello sfruttamento e della malavita locale, alle fregole del primo cliente che ha deciso di menare le mani.
Io l’opportunità credevo di averla trovata, o forse soltanto vista in sogno.
Mimma sarà felice quando leggerà dai giornali che le mie unghie saranno repertate. Poi chissà per quanto tempo non saprà più niente di me. Dubito frequenti i cimiteri. E poi, Campo di carne è già un cimitero. E una vita così è veramente un incubo. Una fine così, la mia faccia triste sul terreno di un’estate arida, il mio corpo seminudo e scomposto.
E lui sudava, ieri sera, sudava su di me mentre il sole si eclissava bellissimo dietro il cavalcavia. Ma non si è attardato in convenevoli dicendomi di questa estate afosa, non mi ha domandato come sopravvivo a queste temperature quando anche l’ombra del cavalcavia è latitante. È passato subito all’attacco, appena fermi pochi metri più in là. Doveva saperlo che a quell’ora non c’era più nessuno. Che alcune erano andate a mangiare un panino e altre stavano inguattate altrove. Forse ha studiato i nostri movimenti.
Poi ho pianto e basta. Pensavo ai miei bambini, alla loro condanna uguale alla mia, alla solitudine, unica eredità che lascio loro. Dopo che mi sono difesa, però, ho pianto, dopo aver usato denti e unghie per liberarmi, per ferirlo, dopo che lui mi ha rotto una costola, al quarto calcio nello stomaco.
O forse la costola me l’ha rotta prima, quando mi ha presa a pugni perché io non ce l’ho fatta a fingermi morta, e mentre urlavo inutilmente vedevo il piccolo che si ciucciava il pollice sul prato chimico del centro commerciale, e il grande in altalena, e tutte le estati che non passeremo assieme.
Mimma ha certe teorie sull’aldilà. Dice che per un po’ si galleggia qui, dove si è morti, attorno a chi amiamo. Poi perdiamo coscienza, ci allontaniamo un po’, come in una sala cinematografica anni ’70, quando la pellicola s’interrompeva e batteva sul proiettore formando un’aurora boreale di celluloide. Solo che io negli anni ’70 non ero nemmeno nei pensieri di mia madre.
Io so soltanto che mentre quello mi sbavava addosso, ieri sera, non c’era più nemmeno il cielo. E sicuramente nemmeno Dio. Poi ho visto la mia guerra, fotogramma per fotogramma, dalla prima all’ultima battaglia, e lui sopra di me che rideva e s’incupiva, bestemmiava, mentre con la mano fetida, grande e libera, ora che era riuscito a penetrarmi, cercava di cancellarmi la faccia.
Poi ho visto i soldati, la piccola delegazione che era lì ad accogliermi, e il mio corpo: gambe e braccia troppo magre, la scarpa sfuggita al piede ora nudo e immobile, il cinturino spezzato poco più in là, la mia solita faccia triste, seppure con gli occhi sbarrati, tra gli scarti della civiltà moderna. Poi ho visto dei fari, poi in lontananza le volanti della polizia, gli uomini in divisa che si affaccendavano attorno al mio corpo, il telo pietoso steso su di esso che già non era più mio.
Siamo fatti di riflessi condizionati, dice Mimma, la nostra esistenza è un insieme di abitudini che ci tranquillizzano anche quando siamo nel baratro. Infatti, stamattina mi sembra di sentirlo fin qui il profumo del caffè.
Mimma oggi non è venuta, ma qui a Campo di carne c’è sempre movimento, pure con trentotto gradi all’ombra.
È un’estate impossibile come quella del 2003, sempre stando a quello che dice Mimma, eppure, io sto gelando.
*****
Questo racconto si è classificato al secondo posto al premio letterario “Short Story” promosso da Enrico Damiani editore.
In copertina: frame da Roma (1972) di Federico Fellini.



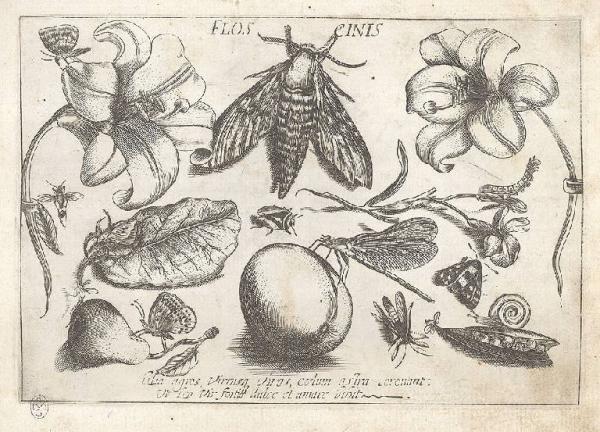
Quanta poesia in questo racconto drammatico, perchè volevo scrivere che è un bel racconto, ma non mi sembrava l’aggettivo appropriato. Letto tutto d’un fiato, grazie Elena.
Grazie, Silvana. Chissà perché si è persa l’abitudine a commentare. Qunidi doppiamente grazie.
No,ft questo racconto non si legge in un fiato , no questo racconto ti fa sentire dentro la storia, ti fa sentire il dolore di quei calci di quei pugni, delle unghie che si spezzano. Tu ti senti Lei in quel cavalvavia di campo di carne.
.
Grazie, Elvira, era ciò che desideravo, sebbene vorrei che la realtà mi offrisse storie meno cruente da raccontare.
Frase dopo frase, parola dopo parola, un cammino lacerante .
Ho pianto “sentendo” il racconto di una donna che resta umana anche nel momento di una morte così disumana.
Grazie, Annalisa, quel dolore e quella umanità sono patrimonio di tutti. non ho conosciuto personalmente la donna di cui parlo, che è realmente esistita e realmente morta lo scorso anno, ma ho la sua foto sul desktop, sorridente con i suoi bambini, ed è per me il simbolo di una grande perdita. Grazie.
Si può dire che è bellissimo un racconto così intensamente triste? Si può, pur sapendo come finirà, non voler smettere di leggere?Si può voler comunque arrivare in fondo,malgrado la gola ti si chiuda ad ogni sillaba inghiottita? Non lo so se si può, ma io lo fatto. Grazie Elena
Grazie a te, Nino, nella speranza che ogni parola inghiottita dia levità a G.P., la donna assassinata, e ai suoi due bambini, i suoi angeli. Grazie pere lettura e commento.