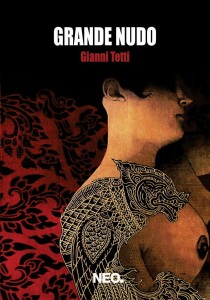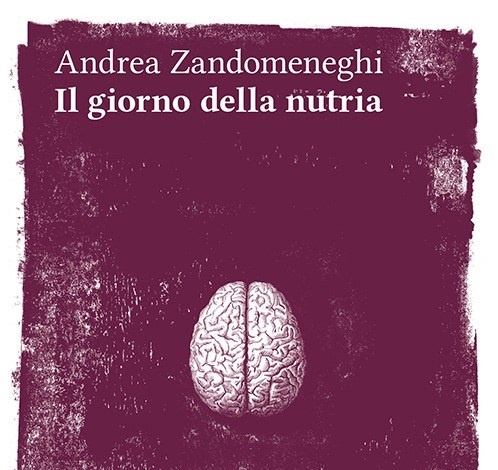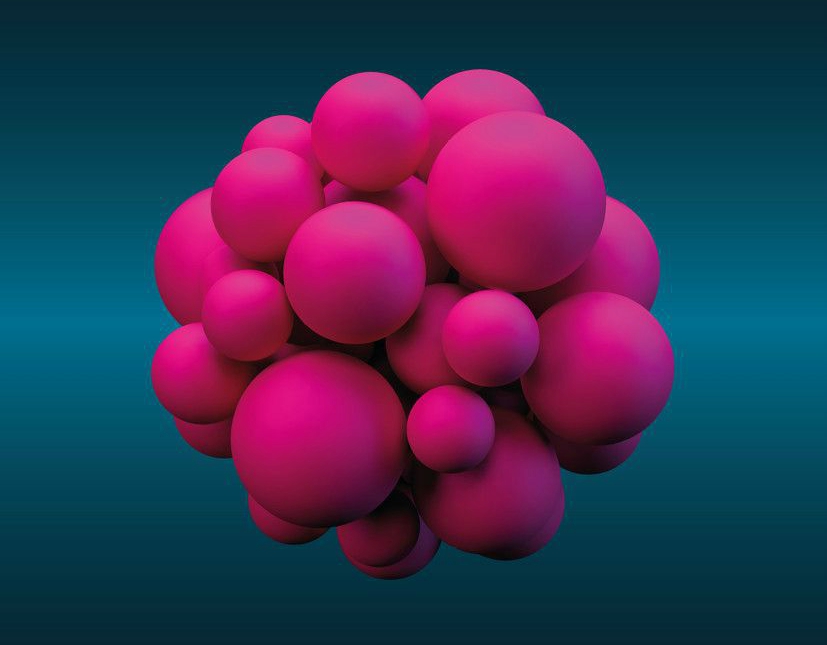Grande nudo è un romanzo interessante. Grande nudo è un romanzo intelligente. Grande nudo è un romanzo antipatico e non di rado irritante. Grande nudo è un romanzo grottesco, dove ogni cosa è esagerata e non sempre è riuscita. Grande nudo non è un libro per tutti, né vuole esserlo. Avevo deciso di leggerlo ben prima che fosse candidato allo Strega. E questa è stata una fortuna. La candidatura m’avrebbe dissuaso dall’occuparmene. Ognuno ha le proprie idiosincrasie. Quantomeno io ho le mie. E anche se sono stupide ci sono affezionato.
 L’ingegno – acutissimo: quello che mette a fuoco e seleziona lo esaurisce; tecnica impervia e pericolosa (dominata da Tetti, che invece talvolta scivola quando se ne allontana), funzionale alla poetica (che tende di base all’asciutta crudeltà del piano sequenza[i] di Haneke[ii] ma che se ne discosta in continuazione, contorcendosi nel surrealismo dell’incubo, inturgidendosi nell’autocompiacimento umido alla Larry Clark, ghignando strafottente nel baratro più sordido dei bifolchi disumanizzati dalla miseria e dai loro sfruttatori papponi, ritirandosi nel cinico minimalismo alla Ellis, fluendo distesa e allucinata nel post-esotismo pseudo-lirico paesaggistico di Terminus radioso, rispetto al quale non mancano altre analogie, volute e consapevoli o meno è indifferente, come la costruzione del muro che isola la città, le campagne contaminate e necrofore oltre il muro et coetera), e alla struttura (che ricorda molto Elephant di Gus Van Sant) del libro che si fa tentacolare e centrifugo solo per poi convergere al centro con brusche virate – vivace permea il testo dalla prima pagina: l’elencazione sagace dei personaggi (tripartita in PERSONAGGI PRINCIPALI, PERSONAGGI LORO MALGRADO, PERSONAGGI CHE SI NASCONDONO), all’ultima: NOTE, alcune delle quali particolarmente curiose e aneddotiche (l’aneddoto e la leggenda metropolitana son dispositivi narrativi utilizzati di frequente ed efficacemente dall’autore), come Filuferru, l’undicesima: «[…] è l’acquavite. La storia del filuferru è questa: durante la seconda guerra mondiale i contadini producevano, dalle vinacce, clandestinamente, una bevanda molto alcolica, gradazione sopra i quaranta gradi. Poiché la produzione era clandestina, non potevano tenere in casa gli alambicchi e le bottiglie, per questo sotterravano tutto nelle campagne e, al fine di ricordare il punto esatto in cui li avevano nascosti, mettevano dei fil di ferro che spuntavano da sottoterra, da qui il nome».
L’ingegno – acutissimo: quello che mette a fuoco e seleziona lo esaurisce; tecnica impervia e pericolosa (dominata da Tetti, che invece talvolta scivola quando se ne allontana), funzionale alla poetica (che tende di base all’asciutta crudeltà del piano sequenza[i] di Haneke[ii] ma che se ne discosta in continuazione, contorcendosi nel surrealismo dell’incubo, inturgidendosi nell’autocompiacimento umido alla Larry Clark, ghignando strafottente nel baratro più sordido dei bifolchi disumanizzati dalla miseria e dai loro sfruttatori papponi, ritirandosi nel cinico minimalismo alla Ellis, fluendo distesa e allucinata nel post-esotismo pseudo-lirico paesaggistico di Terminus radioso, rispetto al quale non mancano altre analogie, volute e consapevoli o meno è indifferente, come la costruzione del muro che isola la città, le campagne contaminate e necrofore oltre il muro et coetera), e alla struttura (che ricorda molto Elephant di Gus Van Sant) del libro che si fa tentacolare e centrifugo solo per poi convergere al centro con brusche virate – vivace permea il testo dalla prima pagina: l’elencazione sagace dei personaggi (tripartita in PERSONAGGI PRINCIPALI, PERSONAGGI LORO MALGRADO, PERSONAGGI CHE SI NASCONDONO), all’ultima: NOTE, alcune delle quali particolarmente curiose e aneddotiche (l’aneddoto e la leggenda metropolitana son dispositivi narrativi utilizzati di frequente ed efficacemente dall’autore), come Filuferru, l’undicesima: «[…] è l’acquavite. La storia del filuferru è questa: durante la seconda guerra mondiale i contadini producevano, dalle vinacce, clandestinamente, una bevanda molto alcolica, gradazione sopra i quaranta gradi. Poiché la produzione era clandestina, non potevano tenere in casa gli alambicchi e le bottiglie, per questo sotterravano tutto nelle campagne e, al fine di ricordare il punto esatto in cui li avevano nascosti, mettevano dei fil di ferro che spuntavano da sottoterra, da qui il nome».
 Ho scritto volutamente i due paragrafi precedenti in modo diversissimo tra di loro – agli antipodi: paratassi e giustapposizione spezzettata esasperata (l’anafora è un mio vezzo e non ci interessa) nel primo, ipotassi parentetica iperbolica nel secondo – per un motivo molto semplice: provare a rappresentare in modo plastico l’andamento microstrutturale della scrittura di Grande nudo, che è spiccatamente del primo tipo: periodi brevi – 5/8 parole spesso – connessi asindeticamente da punti fermi; di tanto in tanto una virgola o una relativa. I paragrafi tendono a loro volta alla frammentarietà, 3/10 righe di media, favorendo passaggi simil-aforistici e simil-gnomici.
Ho scritto volutamente i due paragrafi precedenti in modo diversissimo tra di loro – agli antipodi: paratassi e giustapposizione spezzettata esasperata (l’anafora è un mio vezzo e non ci interessa) nel primo, ipotassi parentetica iperbolica nel secondo – per un motivo molto semplice: provare a rappresentare in modo plastico l’andamento microstrutturale della scrittura di Grande nudo, che è spiccatamente del primo tipo: periodi brevi – 5/8 parole spesso – connessi asindeticamente da punti fermi; di tanto in tanto una virgola o una relativa. I paragrafi tendono a loro volta alla frammentarietà, 3/10 righe di media, favorendo passaggi simil-aforistici e simil-gnomici.
La soluzione adottata è coerente con gli intenti dell’autore che scolpisce come un certosino rancoroso e psicotico i mattoncini duri e spigolosi con cui costruisce l’edificio del romanzo in modo tale da renderlo altamente fruibile – a livello stilistico – e soprattutto diretto: i colpi che assesta – e ci sono colpi acri, colpi feroci, colpi morbosi, colpi adrenalinici, colpi di scena e poi colpi tremendi che investendoti senza filtri e orpelli paiono frontali con un camion lanciato in autostrada per il lettore che va in bicicletta, e questi ultimi son passaggi da far impallidire de Sade, Octave Mirabeu e Patrick Beteman di American Psycho, roba che traumatizzerebbe anche un tipo con la «bibliografia»[iii] erotico-sadica intellettualmente smaliziata del Pelletier di 2666 (e non sto esagerando) – a volte vanno a segno, a volte no.
 Non vanno mai a segno e producono scene inefficaci, inutili e sciatte ad esempio quando oggetto della scrittura è il «grande monologo» di un «grande»: l’anziano superiore con il bastone del seminario frequentato da Don Casu («l’amore è un dolore. È l’ascia arrugginita che ti si pianta in mezzo al petto. L’amore è un vizio. L’amore è una condanna. È debolezza. Per il desiderio abbiamo perso il paradiso») e il primo colonnello («se siete qui, vuol dire che siete i migliori. E, tra i migliori, dovete sapere, non ci sono seconde possibilità. Al primo errore sarete mandati nei cessi. E dai cessi non si esce più») tra tutti.
Non vanno mai a segno e producono scene inefficaci, inutili e sciatte ad esempio quando oggetto della scrittura è il «grande monologo» di un «grande»: l’anziano superiore con il bastone del seminario frequentato da Don Casu («l’amore è un dolore. È l’ascia arrugginita che ti si pianta in mezzo al petto. L’amore è un vizio. L’amore è una condanna. È debolezza. Per il desiderio abbiamo perso il paradiso») e il primo colonnello («se siete qui, vuol dire che siete i migliori. E, tra i migliori, dovete sapere, non ci sono seconde possibilità. Al primo errore sarete mandati nei cessi. E dai cessi non si esce più») tra tutti.
Funzionano abbastanza bene in relazione a signor Mario. Funzionano bene con il ragazzo dai capelli neri. Funzionano molto bene con Don Casu. Funzionano straordinariamente bene nella catabasi di Maria. Funzionano malino con l’uomo dagli occhi verdi.
Questa distinzione secca che opero dipende dal fatto che i capitoli si alternano, trattando e seguendo un personaggio, per poi passare a un altro – spesso con variazione anche del narratore – andando progressivamente a far intrecciare le varie storie.
 Signor Mario è una guardia forestale, apparentemente tranquilla e comune, che chiacchiera un po’ troppo e sbruffoneggia al bar; ha orari regolari ed è in terza persona presente – in realtà è un mostro, volendo: il mostro («poi s’era stufato di tirare calci in pancia e di buttare feti morti. E quindi ha deciso, la sterilizzo. Si può far sterilizzare? Aveva chiesto signor Mario» – lo chiede perché è di un essere umano che sta parlando e non è sicuro che sia fattibile). Il ragazzo dai capelli neri – in prima persona presente – si guadagna da vivere offrendo piccoli servizi alle persone in difficoltà e soprattutto scopando per soldi Candida, una ragazza affetta da distrofia muscolare, relegata in casa, che si sposta accompagnata in sedie a rotelle, che rabbiosa («Candida dice che vorrebbe contagiare tutti. Anche con lo sguardo. Anche te vorrei contagiare, mi dice Candida») e tirannica è incline al turpiloquio («porco schifoso sbatti più forte»), che viene spesso portata a Lourdes dalla madre (il tema dei miracoli e della superstizione è molto presente, anche in altre linee narrative, soprattutto in riferimento al malocchio e a Padre Pio; ma anche per esempio al morso di biscia: «il morso di biscia porta male. Quel morso ti segna. Due buchetti sulla pelle. Tu pensi che dopo un po’ non si vedano più, e invece c’è chi li vede. Li vedono e ti stanno lontano. E fanno bene. Perché a starti vicino si prende il tuo odore. E ci si prende la tua sfortuna. E allora ti fai una vita da solo. Poi passa il buon Dio, e se ti vede segnato non ti vuole più. Poi passa il diavolo con la faccia di legno e le corna di capro, e se ti vede segnato ti prende. E tu non ci sei più, e nessuno ti rimpiange») dove però cerca soprattutto di spompinare baristi; puntualmente il ragazzo prostituto dai capelli neri s’innamora di lei e viene scaricato. L’uomo dagli occhi verdi è il personaggio più enigmatico e delirante («ci sarà da aspettare, dice. Tu, quando aspetti, cosa fai? Non lo so, risponde l’uomo. Di solito quando aspetto il pesce, fumo. Io quando aspetto, fornico, dice il cane nero. […] La grotta pulsa di corpi. I corpi si aggrovigliano. Sono almeno un migliaio. Il cane nero incede in mezzo a questi cani ammassati al buio. Si avvicina a una cagnetta, le salta sulla schiena, se la scopa. Intorno è pieno di cani che scopano e di cagne che partoriscono, e di altre cagne che allattano. Intorno ringhiano altri cani ancora e si azzannano. C’è chi muore e i vivi se lo mangiano. […] Il cane nero monta una cagna gigantesca. Si volta verso l’uomo. Dobbiamo aspettare, trovarti qualche da fare. L’uomo si distende nello stesso punto di prima. Chiude gli occhi. S’addormenta. Sogna il vento. Il vento sussurra, Maria. Maria arriva, è nuda e fa la danza del ventre. Un ventre gonfio di cuccioli. I cuccioli escono fuori dalla sua fica come vermi da una carcassa. Maria è una donna gigante. Le gambe aperte su una scena piena di luci. La città è fatta di carne. I suoi vermi si mangiano la città. Maria è fragile, crolla»), viene da una famiglia-clan di pescatori diseredati sopravvissuti a un diluvio; è in terza persona presente, il vento gli parla, come parla a Maria, che lui sogna; le sue vicende prendono l’abbrivio quando in alto mare, su una barca da pesca, uccide il proprio fratello perché per tutta la vita gl’ha detto cosa fare e cosa non fare. Don Casu è un prete puttaniere e senza fede, che truffa i parrocchiani e li vessa con tartassanti benedizioni delle abitazioni per ricevere/estorcere elemosine/offerte e con la vendita di biglietti di finte lotterie di beneficenza per racimolare soldi, ha bisogno di denaro per comprarsi una bambola gonfiabile molto costosa; è frustrato e angosciato, insoddisfatto della propria vita e se non crede in dio, crede però nel potere liberatorio delle catastrofi («speri che arrivi una guerra o un terremoto […]. O le mosche, ondate di mosche che s’infilano dappertutto. E mangiano. Si succhiano tutto finché non resta più nulla. Il mondo si fermerebbe per qualche settimana. E chi vuol scappare scappa, chi vuol cambiare cambia, chi si vuol nascondere si nasconde, chi si vuole innamorare. Quando c’è confusione è più facile farsi gli affari propri»); la sua particolarità è che viene seguito con il narratore in seconda singolare presente, soluzione quanto mai felice per metterne in luce la pochezza degradata e disperata umana e spirituale, ma che raggiunge l’apice della qualità narratologica e dell’intensità espressivo-formale dell’intero testo quando – nello snodo cruciale del libro – emerge a sorpresa l’io – che parrebbe Dio, ma che potrebbe essere il vento, senza dimenticare che una cosa non esclude l’altra, ma non sta a me giudicare questo, né anticipare valutazioni e sviluppi successivi – del soggetto che sta raccontando le vicende del parroco e gli si rivolge direttamente dandogli del tu: «sei sulle scale. Scendi il primo gradino. Ti fermo e sussurro al tuo orecchio. Se c’è qualcosa che puoi fare per non sentirti inutile, è aiutare quella poveretta». Anche a Maria parla il vento, come all’uomo con gli occhi verdi. Ma la storia del personaggio di Maria e della sua catabasi è bene che ognuno se la legga per conto proprio, perché non intendo né svilirla, né sintetizzarla, né attenuarla, né mediarla; perché probabilmente non sarei neppure in grado di renderla, perché è tanto magistrale, quanto terribile, un orrore indicibile: a questo mi riferivo parlando di colpi che traumatizzano e che farebbero impallidire l’autore delle Centoventi giornate di Sodoma e quello del Giardino dei supplizi. Perché è l’osceno e oscuro cuore pulsate del libro: capitolo 21, pagg. 205-223 – questa l’ubicazione. Chi leggerà, saprà.
Signor Mario è una guardia forestale, apparentemente tranquilla e comune, che chiacchiera un po’ troppo e sbruffoneggia al bar; ha orari regolari ed è in terza persona presente – in realtà è un mostro, volendo: il mostro («poi s’era stufato di tirare calci in pancia e di buttare feti morti. E quindi ha deciso, la sterilizzo. Si può far sterilizzare? Aveva chiesto signor Mario» – lo chiede perché è di un essere umano che sta parlando e non è sicuro che sia fattibile). Il ragazzo dai capelli neri – in prima persona presente – si guadagna da vivere offrendo piccoli servizi alle persone in difficoltà e soprattutto scopando per soldi Candida, una ragazza affetta da distrofia muscolare, relegata in casa, che si sposta accompagnata in sedie a rotelle, che rabbiosa («Candida dice che vorrebbe contagiare tutti. Anche con lo sguardo. Anche te vorrei contagiare, mi dice Candida») e tirannica è incline al turpiloquio («porco schifoso sbatti più forte»), che viene spesso portata a Lourdes dalla madre (il tema dei miracoli e della superstizione è molto presente, anche in altre linee narrative, soprattutto in riferimento al malocchio e a Padre Pio; ma anche per esempio al morso di biscia: «il morso di biscia porta male. Quel morso ti segna. Due buchetti sulla pelle. Tu pensi che dopo un po’ non si vedano più, e invece c’è chi li vede. Li vedono e ti stanno lontano. E fanno bene. Perché a starti vicino si prende il tuo odore. E ci si prende la tua sfortuna. E allora ti fai una vita da solo. Poi passa il buon Dio, e se ti vede segnato non ti vuole più. Poi passa il diavolo con la faccia di legno e le corna di capro, e se ti vede segnato ti prende. E tu non ci sei più, e nessuno ti rimpiange») dove però cerca soprattutto di spompinare baristi; puntualmente il ragazzo prostituto dai capelli neri s’innamora di lei e viene scaricato. L’uomo dagli occhi verdi è il personaggio più enigmatico e delirante («ci sarà da aspettare, dice. Tu, quando aspetti, cosa fai? Non lo so, risponde l’uomo. Di solito quando aspetto il pesce, fumo. Io quando aspetto, fornico, dice il cane nero. […] La grotta pulsa di corpi. I corpi si aggrovigliano. Sono almeno un migliaio. Il cane nero incede in mezzo a questi cani ammassati al buio. Si avvicina a una cagnetta, le salta sulla schiena, se la scopa. Intorno è pieno di cani che scopano e di cagne che partoriscono, e di altre cagne che allattano. Intorno ringhiano altri cani ancora e si azzannano. C’è chi muore e i vivi se lo mangiano. […] Il cane nero monta una cagna gigantesca. Si volta verso l’uomo. Dobbiamo aspettare, trovarti qualche da fare. L’uomo si distende nello stesso punto di prima. Chiude gli occhi. S’addormenta. Sogna il vento. Il vento sussurra, Maria. Maria arriva, è nuda e fa la danza del ventre. Un ventre gonfio di cuccioli. I cuccioli escono fuori dalla sua fica come vermi da una carcassa. Maria è una donna gigante. Le gambe aperte su una scena piena di luci. La città è fatta di carne. I suoi vermi si mangiano la città. Maria è fragile, crolla»), viene da una famiglia-clan di pescatori diseredati sopravvissuti a un diluvio; è in terza persona presente, il vento gli parla, come parla a Maria, che lui sogna; le sue vicende prendono l’abbrivio quando in alto mare, su una barca da pesca, uccide il proprio fratello perché per tutta la vita gl’ha detto cosa fare e cosa non fare. Don Casu è un prete puttaniere e senza fede, che truffa i parrocchiani e li vessa con tartassanti benedizioni delle abitazioni per ricevere/estorcere elemosine/offerte e con la vendita di biglietti di finte lotterie di beneficenza per racimolare soldi, ha bisogno di denaro per comprarsi una bambola gonfiabile molto costosa; è frustrato e angosciato, insoddisfatto della propria vita e se non crede in dio, crede però nel potere liberatorio delle catastrofi («speri che arrivi una guerra o un terremoto […]. O le mosche, ondate di mosche che s’infilano dappertutto. E mangiano. Si succhiano tutto finché non resta più nulla. Il mondo si fermerebbe per qualche settimana. E chi vuol scappare scappa, chi vuol cambiare cambia, chi si vuol nascondere si nasconde, chi si vuole innamorare. Quando c’è confusione è più facile farsi gli affari propri»); la sua particolarità è che viene seguito con il narratore in seconda singolare presente, soluzione quanto mai felice per metterne in luce la pochezza degradata e disperata umana e spirituale, ma che raggiunge l’apice della qualità narratologica e dell’intensità espressivo-formale dell’intero testo quando – nello snodo cruciale del libro – emerge a sorpresa l’io – che parrebbe Dio, ma che potrebbe essere il vento, senza dimenticare che una cosa non esclude l’altra, ma non sta a me giudicare questo, né anticipare valutazioni e sviluppi successivi – del soggetto che sta raccontando le vicende del parroco e gli si rivolge direttamente dandogli del tu: «sei sulle scale. Scendi il primo gradino. Ti fermo e sussurro al tuo orecchio. Se c’è qualcosa che puoi fare per non sentirti inutile, è aiutare quella poveretta». Anche a Maria parla il vento, come all’uomo con gli occhi verdi. Ma la storia del personaggio di Maria e della sua catabasi è bene che ognuno se la legga per conto proprio, perché non intendo né svilirla, né sintetizzarla, né attenuarla, né mediarla; perché probabilmente non sarei neppure in grado di renderla, perché è tanto magistrale, quanto terribile, un orrore indicibile: a questo mi riferivo parlando di colpi che traumatizzano e che farebbero impallidire l’autore delle Centoventi giornate di Sodoma e quello del Giardino dei supplizi. Perché è l’osceno e oscuro cuore pulsate del libro: capitolo 21, pagg. 205-223 – questa l’ubicazione. Chi leggerà, saprà.
 I personaggi si muovono (o stanno immobili, segregati e ridotti in turpe schiavitù) in una Sardegna che presenta se stessa come post-apocalittica («la terra che vivono questi disperati è un luogo inospitale, aperto alle bombe, inquinato dalle polveri di queste bombe, decimato dai tumori. Il mare che navigano questi disperati è una tomba») e i suoi abitanti come reduci dell’apocalisse («siamo i superstiti. Siamo quello che è rimasto. Dopo le guerre, dopo gli attentati. Dopo i virus. Dopo la Grande depressione. Dopo la ripresa che ne ha ammazzati più di tutti»). In una tale situazione sembra montare poi un’ulteriore successiva apocalisse di cui s’intravedono i primi germi: altri attentati, sempre più gravi, i cani che sbranano i padroni e fuggono in massa per poi assaltare e saccheggiare di notte la città, le turbe isteriche di persone che nel caos inarginabile e violento tappezzano furiosamente la città di manifesti nell’intento di ritrovare i propri cani, la proscrizione coatta e militare dei villici presidiata da una muraglia e da torrette, gli incubi ricorrenti, la follia che esplode nella mente del colonnello in diretta tv, un palloncino rosso che vaga per aria in cui per qualche motivo tutti s’imbattono, le epifanie del cane nero con gli occhi gialli, il vento che parla e che pare condurre a un messia ed esortarlo.
I personaggi si muovono (o stanno immobili, segregati e ridotti in turpe schiavitù) in una Sardegna che presenta se stessa come post-apocalittica («la terra che vivono questi disperati è un luogo inospitale, aperto alle bombe, inquinato dalle polveri di queste bombe, decimato dai tumori. Il mare che navigano questi disperati è una tomba») e i suoi abitanti come reduci dell’apocalisse («siamo i superstiti. Siamo quello che è rimasto. Dopo le guerre, dopo gli attentati. Dopo i virus. Dopo la Grande depressione. Dopo la ripresa che ne ha ammazzati più di tutti»). In una tale situazione sembra montare poi un’ulteriore successiva apocalisse di cui s’intravedono i primi germi: altri attentati, sempre più gravi, i cani che sbranano i padroni e fuggono in massa per poi assaltare e saccheggiare di notte la città, le turbe isteriche di persone che nel caos inarginabile e violento tappezzano furiosamente la città di manifesti nell’intento di ritrovare i propri cani, la proscrizione coatta e militare dei villici presidiata da una muraglia e da torrette, gli incubi ricorrenti, la follia che esplode nella mente del colonnello in diretta tv, un palloncino rosso che vaga per aria in cui per qualche motivo tutti s’imbattono, le epifanie del cane nero con gli occhi gialli, il vento che parla e che pare condurre a un messia ed esortarlo.
 Il romanzo però strumentalizza ai suoi fini semplicemente topos e delle suggestioni – certo molto marcate – apocalittiche e post-apocalittiche e mente: «sono rimasti solo i cattivi e i vigliacchi. I cattivi hanno ucciso. I vigliacchi si sono nascosti e hanno lasciato morire i figli pur di scamparla». Un’altra asserzione è: «se qualcuno è convinto che da una crisi nasca un mondo migliore, sbaglia. Siamo gli stessi di prima, solo più soli, più impauriti» – e qui troviamo una chiave: quale è in realtà la crisi? Il cataclisma pregresso? L’apocalisse imminente? No, è crisi interiore dilagante dell’uomo occidentale annichilito dalla modernità, sradicato dalla propria terra, privato del senso dell’esistere, inabilitato a costruire un nuovo significato per la propria vita, senza più punti di riferimento, atomizzato nel proprio individualismo consumistico-globalista che ha reciso i legami con le ramificazioni rizomatiche sociali, comunitarie e familiari che lo nutrivano di linfa salubre e lo disintossicavano, e che ora si trova di fronte al nulla, al vuoto: gli rimangono solo la proprie pulsioni più bieche e immonde – «nessuna creatura è più squallida ripugnante dell’uomo che è sfuggito al suo genio», scrive Nietzsche in Schopenhauer come educatore – e in quelle ad libitum (volo, ergo possum, con l’unico limite dei soldi e della forza bruta che possiede, nudi limiti esterni; limiti labili, limiti pre-morali, pre-civici, pre-politici) si produce aberrante, mostruoso, morboso, sub-umano.
Il romanzo però strumentalizza ai suoi fini semplicemente topos e delle suggestioni – certo molto marcate – apocalittiche e post-apocalittiche e mente: «sono rimasti solo i cattivi e i vigliacchi. I cattivi hanno ucciso. I vigliacchi si sono nascosti e hanno lasciato morire i figli pur di scamparla». Un’altra asserzione è: «se qualcuno è convinto che da una crisi nasca un mondo migliore, sbaglia. Siamo gli stessi di prima, solo più soli, più impauriti» – e qui troviamo una chiave: quale è in realtà la crisi? Il cataclisma pregresso? L’apocalisse imminente? No, è crisi interiore dilagante dell’uomo occidentale annichilito dalla modernità, sradicato dalla propria terra, privato del senso dell’esistere, inabilitato a costruire un nuovo significato per la propria vita, senza più punti di riferimento, atomizzato nel proprio individualismo consumistico-globalista che ha reciso i legami con le ramificazioni rizomatiche sociali, comunitarie e familiari che lo nutrivano di linfa salubre e lo disintossicavano, e che ora si trova di fronte al nulla, al vuoto: gli rimangono solo la proprie pulsioni più bieche e immonde – «nessuna creatura è più squallida ripugnante dell’uomo che è sfuggito al suo genio», scrive Nietzsche in Schopenhauer come educatore – e in quelle ad libitum (volo, ergo possum, con l’unico limite dei soldi e della forza bruta che possiede, nudi limiti esterni; limiti labili, limiti pre-morali, pre-civici, pre-politici) si produce aberrante, mostruoso, morboso, sub-umano.
 I cattivi e vigliacchi e i crudeli siamo noi.
I cattivi e vigliacchi e i crudeli siamo noi.
 Tetti, quindi, in verità parla appunto di noi tutti; inscena la nostra libido insaziabile, cieca, egocentrica e corrotta, disvela le creature obbrobriose che ci abitano e che proliferano nel corpo sociale e nell’immaginario condiviso. A partire dal razzismo e dal segregazionismo dei movimenti populistico-sovranisti che imperversano nell’occidente, da «noi per primi», da «city first» (interpolando Trump), per arrivare al più abissale sadismo psicopatico – quello che io non ho voluto riferire.
Tetti, quindi, in verità parla appunto di noi tutti; inscena la nostra libido insaziabile, cieca, egocentrica e corrotta, disvela le creature obbrobriose che ci abitano e che proliferano nel corpo sociale e nell’immaginario condiviso. A partire dal razzismo e dal segregazionismo dei movimenti populistico-sovranisti che imperversano nell’occidente, da «noi per primi», da «city first» (interpolando Trump), per arrivare al più abissale sadismo psicopatico – quello che io non ho voluto riferire.
 Grande nudo è respingente fin dal Prologo e non perché ti piazza scomposto e infantile all’ottava riga «ma la fica della troia puzza abbastanza. Sì, di pesce marcio, marcio, marcio, settimane che gliela impiastro» e neppure perché nella seconda pagina cita con la banalità di uno scolaretto delle medie la più abusata e inflazionata delle frasette-slogan-icona di Hannah Arendt (cosa che comunque si sarebbe potuto risparmiare). No, è respingente perché non vuol farti entrare, ti lascia sospeso, spaesato e innervosito a chiederti cosa cavolo possano significare quelle cinque paginette con le loro frasette affastellate e srelate.
Grande nudo è respingente fin dal Prologo e non perché ti piazza scomposto e infantile all’ottava riga «ma la fica della troia puzza abbastanza. Sì, di pesce marcio, marcio, marcio, settimane che gliela impiastro» e neppure perché nella seconda pagina cita con la banalità di uno scolaretto delle medie la più abusata e inflazionata delle frasette-slogan-icona di Hannah Arendt (cosa che comunque si sarebbe potuto risparmiare). No, è respingente perché non vuol farti entrare, ti lascia sospeso, spaesato e innervosito a chiederti cosa cavolo possano significare quelle cinque paginette con le loro frasette affastellate e srelate.
 Dopo cambia e inizia a raccontare e Tetti quando racconta è bravo – una bravura che gli viene soprattutto dall’intelligenza e non dalla sontuosa prosa evocativa: la sua è piana e scarna, spesso perfetta per questo testo – e lo segui che è una meraviglia nelle polimorfe variazioni di registro, a volte si fa addirittura comico e ti strappa una risata: «La checca chiude gli occhi, gonfia la bocca, raccoglie le forze. Dita sulle tempie, si isola: tu sei un super saiyan, tu sei forte, sei una checca fortissima, il mondo è ai tuoi piedi, puoi affrontare tutto».
Dopo cambia e inizia a raccontare e Tetti quando racconta è bravo – una bravura che gli viene soprattutto dall’intelligenza e non dalla sontuosa prosa evocativa: la sua è piana e scarna, spesso perfetta per questo testo – e lo segui che è una meraviglia nelle polimorfe variazioni di registro, a volte si fa addirittura comico e ti strappa una risata: «La checca chiude gli occhi, gonfia la bocca, raccoglie le forze. Dita sulle tempie, si isola: tu sei un super saiyan, tu sei forte, sei una checca fortissima, il mondo è ai tuoi piedi, puoi affrontare tutto».
 All’inizio il romanzo fa di tutto per rimanerti antipatico – Tetti è uno degli autori meno paraculi e accomodanti che mi sia capitato di leggere – e cade in una serie di errori e sbavature (il fatto che l’autore ne sia consapevole e lo faccia apposta, in questo caso, non muta la natura errata e sbavata di ciò che segue, al massimo si tratta di un’aggravante), mi limiterò a due esempi situati nelle prime pagine che seguono il Prologo e aprono la Prima parte: «si profumano come baldracche perché devono nascondere l’odore di marcio che esce dai denti e l’odore di vecchio che viene dalle ascelle e l’odore di piscio da mezzo alle gambe» – un palese e ingiustificato errore di registro, che con la sua sciocca volgarità fuori luogo da dilettante, produce un fastidio estetico-stilistico e peraltro deturpa, svia e indebolisce l’introduzione della scena dell’autobus, molto bella. Poco dopo: «questa è la prima cosa che dicono: caspita quanto puzzano i negri, soprattutto quando c’è caldo. Signor Antonello pensa all’odore delle troie negre di viale Porto Torres. Signora Assuntina pensa al figlio, eroico, con il fucile, con le bombe, che spara ai negri. E tutti e due indicano il tipo negro con i bustoni e tutto che fa finta di nulla o pensa. I negri non si lavano, dice Signora Assuntina. Signor Antonello dice che i negri puzzano anche se si lavano» – l’intero dialogo non ha alcuna funziona narrativa, non avrà alcuna ripercussione o conseguenza, gli interlocutori poco dopo spariscono: questo bombardamento è un errore di registro borioso, strafottente, facile, scontato e insipido che va a discapito del discorso sugli zingari che introduce e che al contrario è scritto molto bene – e non certo perché sia meno volgare o più politicamente corretto. Qui bisogna capirsi: il problema – la critica che muovo – è la fallacia stilistico-formale, non certo il discorso sul politicamente corretto o sul non politicamente corretto ormai diventato mainstream, di cui non potrebbe fregarmene meno.
All’inizio il romanzo fa di tutto per rimanerti antipatico – Tetti è uno degli autori meno paraculi e accomodanti che mi sia capitato di leggere – e cade in una serie di errori e sbavature (il fatto che l’autore ne sia consapevole e lo faccia apposta, in questo caso, non muta la natura errata e sbavata di ciò che segue, al massimo si tratta di un’aggravante), mi limiterò a due esempi situati nelle prime pagine che seguono il Prologo e aprono la Prima parte: «si profumano come baldracche perché devono nascondere l’odore di marcio che esce dai denti e l’odore di vecchio che viene dalle ascelle e l’odore di piscio da mezzo alle gambe» – un palese e ingiustificato errore di registro, che con la sua sciocca volgarità fuori luogo da dilettante, produce un fastidio estetico-stilistico e peraltro deturpa, svia e indebolisce l’introduzione della scena dell’autobus, molto bella. Poco dopo: «questa è la prima cosa che dicono: caspita quanto puzzano i negri, soprattutto quando c’è caldo. Signor Antonello pensa all’odore delle troie negre di viale Porto Torres. Signora Assuntina pensa al figlio, eroico, con il fucile, con le bombe, che spara ai negri. E tutti e due indicano il tipo negro con i bustoni e tutto che fa finta di nulla o pensa. I negri non si lavano, dice Signora Assuntina. Signor Antonello dice che i negri puzzano anche se si lavano» – l’intero dialogo non ha alcuna funziona narrativa, non avrà alcuna ripercussione o conseguenza, gli interlocutori poco dopo spariscono: questo bombardamento è un errore di registro borioso, strafottente, facile, scontato e insipido che va a discapito del discorso sugli zingari che introduce e che al contrario è scritto molto bene – e non certo perché sia meno volgare o più politicamente corretto. Qui bisogna capirsi: il problema – la critica che muovo – è la fallacia stilistico-formale, non certo il discorso sul politicamente corretto o sul non politicamente corretto ormai diventato mainstream, di cui non potrebbe fregarmene meno.
 Tutto questo è spiegabile – ma non giustificabile: sono errori – con una cosa più personale e raffinata del politicamente scorretto: la volontà di antipatia programmatica dell’autore, che si sostanzia anche nella questione del patto con il lettore, Tetti tra le righe sembra dire: «sappi che io faccio tutto come cazzo mi pare a livello tanto micro quanto macro, se vuoi fare un patto vai a leggere altro, di te me sbatto. Dal momento che però mi stai leggendo, perché questo è un libro e quindi è fatto per essere letto, allora non posso sbattermene del tutto e così ti faccio le smorfie». Altro procedimento impervio e pericoloso: lo sguardo del lettore, la piena coscienza dell’autore di quello sguardo, l’eccessivo lavorio sulla consapevolezza di quest’ultimo e le conseguenti reazioni affabulatorie, deformano la scrittura, la infiltrano e la penetrano (Bachtin) ben oltre le intenzioni dell’autore che si trova a giocare la parte dell’apprendista stregone che evoca potenze che non è in grado di controllare. Tutto sommato va però detto che Tetti se la cava abbastanza bene e inciampa solo di tanto in tanto.
Tutto questo è spiegabile – ma non giustificabile: sono errori – con una cosa più personale e raffinata del politicamente scorretto: la volontà di antipatia programmatica dell’autore, che si sostanzia anche nella questione del patto con il lettore, Tetti tra le righe sembra dire: «sappi che io faccio tutto come cazzo mi pare a livello tanto micro quanto macro, se vuoi fare un patto vai a leggere altro, di te me sbatto. Dal momento che però mi stai leggendo, perché questo è un libro e quindi è fatto per essere letto, allora non posso sbattermene del tutto e così ti faccio le smorfie». Altro procedimento impervio e pericoloso: lo sguardo del lettore, la piena coscienza dell’autore di quello sguardo, l’eccessivo lavorio sulla consapevolezza di quest’ultimo e le conseguenti reazioni affabulatorie, deformano la scrittura, la infiltrano e la penetrano (Bachtin) ben oltre le intenzioni dell’autore che si trova a giocare la parte dell’apprendista stregone che evoca potenze che non è in grado di controllare. Tutto sommato va però detto che Tetti se la cava abbastanza bene e inciampa solo di tanto in tanto.
 I romanzi non devono essere simpatici e paraculi; come lettori ci siamo rammolliti e accomodati. Gli scrittori non fanno altro che ammiccare al pubblico. I testi sono piallati, indorati, zuccherati e resi altamente digeribili dall’editing, che troppo spesso altro non è che una branca minore del marketing. Questo non sarebbe ancora un grave problema, il peggio è che il meccanismo de quo è stato interiorizzato dagli autori che si castrano da soli, preventivamente, senza aspettare l’editing/marketing. Ecco un bel modo per ottundersi e tarparsi le ali a priori.
I romanzi non devono essere simpatici e paraculi; come lettori ci siamo rammolliti e accomodati. Gli scrittori non fanno altro che ammiccare al pubblico. I testi sono piallati, indorati, zuccherati e resi altamente digeribili dall’editing, che troppo spesso altro non è che una branca minore del marketing. Questo non sarebbe ancora un grave problema, il peggio è che il meccanismo de quo è stato interiorizzato dagli autori che si castrano da soli, preventivamente, senza aspettare l’editing/marketing. Ecco un bel modo per ottundersi e tarparsi le ali a priori.
 Gianni Tetti, va riconosciuto, non è castrato e, anche se non ho amato il suo romanzo, Neo – cosa strana e quasi paradossale a dirsi di una casa editrice in questi tempi – ha fatto del bene alla letteratura italiana a pubblicarlo.
Gianni Tetti, va riconosciuto, non è castrato e, anche se non ho amato il suo romanzo, Neo – cosa strana e quasi paradossale a dirsi di una casa editrice in questi tempi – ha fatto del bene alla letteratura italiana a pubblicarlo.
* * * * *
Gianni tetti
Grande nudo
Neo Edizioni, 2016
Castel di Sangro (AQ)
pp. 678
[i] Più Benny’s video e Il settimo continente che La pianista e Funny games o addirittura il distintissimo Amour.
[ii] Il primo capitolo, in cui è riportata la conversazione in tram tra due personaggi xenofobi e razzisti di nessun rilievo, abbandonati poi a loro stessi per seguire «signor Mario» (sistematicamente «signor» e «signora» non sono preceduti dall’articolo determinativo) pare proprio una citazione – parodiata, perché c’innesta sovrabbondante la più becera e sbrodolante grettezza della c.d. «pancia del paese» – di 71 frammenti di una cronologia del caso.
[iii] L’espressione è di Bolaño ne La parte dei critici, non mia.