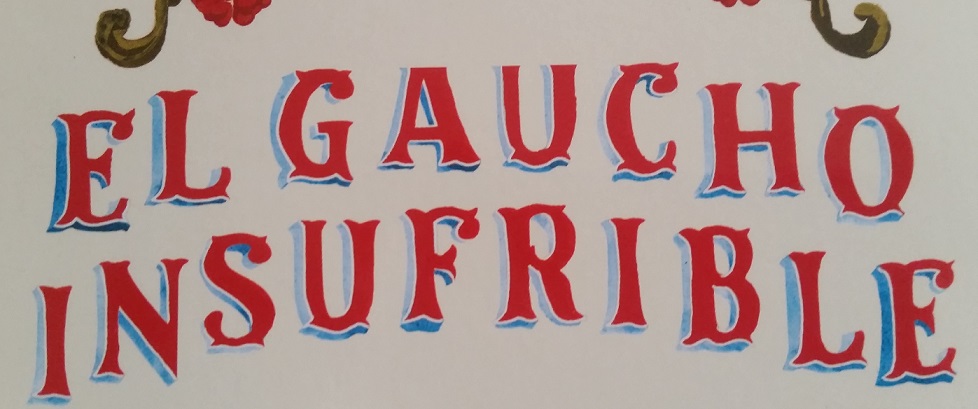C’eravamo solo io e Arturo. La dispersione, il risparmio di fiato e la fame. La notte. C’è sempre la notte, anche quando non c’è, uno se la inventa e dice “c’è la notte”. Arturo era uno che inventava, io volevo essere Arturo ma ero un altro, e stavo con lui per essere lui, non come lui, perché Arturo non accettava paragoni.
(La discendenza – sarebbe questo il metro della similitudine, che si assottiglia nella metafora?)
C’eravamo solo Arturo e io, che non ho un nome letterario come Arturo, il quale aveva cambiato nome per essere letterario, per stornare da sé il segno della discendenza che aveva usato nomi propri dietro i quali trincerarsi.
Arturo disse: «La poesia, sì, ho misconosciuto anche quella. Non ho dimenticato i passi e le orme dei passi. La poesia ha creato il mio stesso feticcio, che ho accettato solo in questo nome, con cui ho scritto, mentre l’altro…»
Io risposi: «E la devozione per la parola? Non viene la parola dalla poesia?»
E Arturo: «Viene e se ne va. Si allontana.»
E io ancora – avevo sonno, ma Arturo voleva parlare sempre e diceva che c’era questa cosa dell’anonimato finto, che se ti scoprono devi continuare a fingere, a inventare – gli chiedevo: «E tu te ne sei andato, così, senza lasciare una scia?»
E Arturo, come se stesse dimenticando nel momento stesso in cui parlava: «Ho fame, è questo un altro problema da risolvere adesso. Trovare soluzioni è più importante che scrivere, perché trovata la soluzione, a stomaco pieno, viene tutto fuori. E poi devo fuggire, sono braccato, l’anonimato, il sequestro di persona, le riunioni nelle celle frigorifero, dove vedi la morte e la morte non ti vede (o almeno credo)… ho fame e non riesco a saziarmi come una volta, quando avevo le idee, quando avevo tutto, insomma.»
Così restammo a lungo, seduti l’uno di fronte all’altro, nella notte, parlando di poesia.
E io gli chiedevo: «E il verso libero, Artù, come te lo immagini?»
E Arturo: «Libero.»
E io: «Che significa?»
E Arturo: «Che fugge, ti sta bene come definizione?»
E io: «Mi va stretta.»
E Arturo: «Non posso dire più di questo, mi sentirebbero. Anche in fondo alla notte, amico, ci sono orecchie pronte a tutto, e sarei costretto a ripensare il mio carattere o quella cosa che si chiama così. Carattere, ci pensi? Carattere è la forma visibile della parola, dentro il quale chiudiamo il carattere che è la forma invisibile che ci fa uomini.»
Non capivo sempre quello che diceva, e forse Arturo non diceva niente, era l’altro, senza nome (o dimenticato, nascosto), che diceva qualcosa.
La notte, la fame, il silenzio. Scrivere, pensare e inventare. Tutto è come cercare queste cose, cercare è come mettere insieme tutto il silenzio, la notte e la fame in un solo crogiolo e rimestare. Rimestare finché non si ha paura di ciò che sta accadendo nel calderone, finché il calderone stesso non si confonde con la scrittura.
E io dissi: «Ho scritto poesie fino alla nausea, fino a dimenticare perché andavo a capo. Il crogiolo si era spaccato, Artù, e tutta la poesia era colata fuori, eppure io giravo e rimestavo a vuoto il vuoto. Era troppo tardi, non mi restavano che le croste da staccare lungo il profilo curvo del calderone, dal fondo. Tutta quella poesia sprecata, Artù, tutto quel lavoro notturno! Per che cosa? Per qualche frammento di merda!»
Lo vidi che mi osservava, come facevo a capirlo con la notte che ci era piombata addosso non saprei dirlo. E la fame, ricordo, e la dispersione e il risparmio del fiato. Eravamo disperati. Eravamo come tutti i poeti dovrebbero essere, come ci avevano insegnato a essere per diventare poeti. E poi? E quando l’illusione era finita, non ci restò che la realtà e il desiderio di fuggirla, di nasconderci nella notte, in fondo al buio, alla luce che fa il buio nella notte.
E io chiesi: «E la realtà?»
E Arturo rispose: «Chi sa che cosa mangiano adesso gli uomini. Chi sa… c’è qualcuno che sa? E l’esistenza, amico, non è esitare e cadere e aggrapparsi? Non è essere più forti degli altri a mantenersi alla roccia, finché la roccia ci regge?»
E io: «Vuoi dire che è la roccia a farci ciò che siamo?»
Arturo, ridendo nella notte: «Che cazzo dici! È la presa ciò che ci distingue. Devi tenerti, amico, e quando stai per cedere… ci sentono anche qui dentro o qui sotto, è così buio che si vede anche troppo.»
Era fatto così Arturo, gli piaceva sospendere la risposta, mescolare il mistero e tenerti per le palle. Poi diceva “addio” come si dice in quei film dove c’è il buono di turno che uccide il cattivo di turno. E non c’è nient’altro che ti resta del film, nessun’altra scena dico, se non quella parola “addio”.
Poi, ci fu silenzio. E la notte. E di notte, tutti dormono.