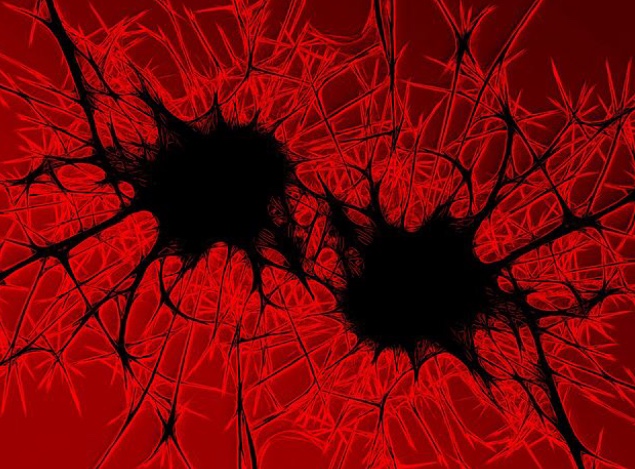Quando le ossa della schiena lo svegliavano, s’alzava dal letto e sedeva a notte fonda alla tavola già apparecchiata dove c’era sempre una bottiglia di vino nero ad aspettarlo per dividere il silenzio. Lì capiva che la bottiglia esprime sempre la malinconia universale dell’essere uomo e solo successivamente quella soggettiva dell’essere vecchio. Eppure se l’essere vecchi è una dimensione pubblica, l’essere ubriachi per lui era un fatto privato, così viveva con discrezione quella condizione da alcolizzato, tanto che nessuno l’avrebbe considerato tale.
In silenzio aspettava che le bestie del suo pollaio si svegliassero, mentre Quirinale, il gallo nero, l’unico che potesse girare libero nel giardino della sua casa, cantava ogni giorno da duemila anni all’arrivo del sole, e sempre prima che la bottiglia di vino fosse terminata. Questa era la salvezza del nonno e anche di Quirinale. Dopo il suo chicchirichì, il nonno accendeva finalmente il fornello a gas e aspettava, mentre il caffè gorgogliava, una sigaretta dopo l’altra, che la sbornia passasse.
Se ogni tanto qualcuno varcava la soglia del suo giardino per scambiare qualche parola, offriva la bottiglia e ricominciava in compagnia da dove s’era interrotto la notte prima. Era talmente discreto nel filare bugie che la verità si sarebbe ritrovata con poco sforzo, ma in seguito. E questo lo faceva sogghignare. Come quando numerava in ordine d’importanza i personaggi appartenuti alla nostra famiglia e che s’erano distinti nel tempo: un barbiere, tale Stochino, che aveva attaccato la sifilide attraverso un rasoio sporco al viceré aragonese Jean François de Bette (Bruxelles, dicembre 1672 – Madrid, gennaio 1725); il Santo Francisco Galiñanes Gallén, il cui motto era no necesita de nada; Cesello e Camerino, fondatori di Torres nell’anno 2118 dalla creazione del mondo. Il suo preferito era però tziu Eligio, suo nonno, il primo sindaco del paese per decreto regio dei Savoia; nell’atto di donazione, dove comparivano anche le seicentoventitré case disposte in maniera irregolare attorno alla chiesa di San Sebastiano, era menzionato come Eli… (illeggibile) Birdano. Si chiamava Eligio, come suo padre. (Era il nome di battesimo? Non so).
Nel tempo il suo nome era cambiato e lo si ritrovava come Elias, Eligio, Remigio, Ezio. Così il suo cognome da Birdano a Virdano, poi Virdis (come il nostro), Piris, Piras, e persino in una variante aragonese, Ruju. L’incendio degli archivi vescovili del 1906 ne disperse la data di nascita così come la provenienza che oscillava col passare del prestigio e degli eventi da Isili a Silius, e viceversa. Per nostro nonno non vi erano incertezze: tziu Eligio era un muratore di Isili, così ricordava. Fu chiamato da così lontano per ristrutturare la canonica di San Sebastiano assieme al cugino, anch’egli di Isili, perché la segretezza di una canonica era faccenda delicata e quindi, roba da forestieri. Dopo aver buttato giù un tramezzo trovarono tra i calcinacci dei piccoli lingotti d’oro. Li nascosero tra gli attrezzi del lavoro senza informare nessuno del ritrovamento.
••
C’era tutt’intorno a Eligio e al cugino, l’enigma degli uccelli che fischiavano. Si lanciavano segnali così acuti che tra loro s’instaurava latente un dialogo che nominava i due. Avevano messo al mondo parecchie uova, che s’erano fatte pulcini e poi predatori d’insetti, d’uva, di fichi e di pere selvatiche. Avrebbero formato quegli stormi che inchiostrano i cieli di novembre. A uno a uno, questi piccoli cuori sarebbero tornati d’inverno nel bosco, senza che le persone del paese ne prendessero visione, se non per lo scempio che portavano tra le vigne.
I contadini in passato accettavano con pacatezza questa razzia. Ma a fine settembre, soprattutto gli ultimi contadini che s’accorgevano di non avere trasmesso ai figli il possesso della terra (perché il vento quei figli glieli aveva portati a Cagliari o addirittura oltre il Tirreno), quei pochi contadini, comprendevano la misura del male attraverso quelle bestie: se ne trovavano qualcuna intrappolata ai lacci, la schiacciavano col calcio del fucile. Altre volte quella stessa misura veniva tradotta in un altro linguaggio: la volontà di esistere del fucile era ferrea e non solo conferiva la forza di schiacciare le bestie, ma spiegava al padrone le possibilità che ha l’uomo di presentare la morte all’uomo. E quando il padrone si mostrava indeciso non sapendo scegliere tra uomo e delitto, era il fucile a indicargli quell’ipotesi e, quindi la forza di quella giurisprudenza maligna.
•••
I due cugini non vollero dividersi il tesoro, forse litigarono (anche se in realtà uno dei due non seppe riconoscere l’oro tra i calcinacci). Così uno si fece ricco e poi sindaco, mentre l’altro cugino s’impiccò appena rientrato a Isili. Una variante della storia descrive invece questo cugino d’Eligio più scaltro: seppe riconoscere perfettamente l’oro, tant’è che Eligio gli sparò a tradimento dentro al bosco. Entrambe le versioni concordano su una cosa: l’assenza di testimoni. L’immensa ricchezza di Eligio si consolidò in ventisette cavalli, dodici case con loggiato, nei terreni di Pran’e sanguini, Funtana Miana e Mont’e Cannoni. Si sposò quattro volte, con donne molto più giovani di lui che si consolavano pensando: dopo il bianco arriva sempre il nero. Inutile dire che tziu Eligio invece sopravvisse a tutte le sue mogli. L’ultima donna, la sua preferita, era bionda e si chiamava Anna. Era la piccola serva venuta da Silius che non sposò mai. In punto di morte le ordinò di mettere dentro una piccola botte gli ultimi resti dell’oro ritrovato nella canonica di San Sebastiano e di sotterrarlo giù nella vigna. Quando la piccola serva sarebbe entrata nel bosco che circondava il paese, di lei non sarebbe stato più. Lì dentro, uno dei cavalli di tziu Eligio l’aspettava per riportarla a Silius, o sulla luna, o sul fondo del mare che fa galleggiare Cagliari.
Bambino sognavo di salvarla: avrei preso quella direzione, la stessa dove nasce lo scirocco, oltre quella barriera di viti, lungo le atroci strade che portavano verso la pianura. Ma il vento ovviamente non nasce, anche se qualcosa di simile al vento alita scavando solchi, raschiando la corteccia alle piante, mettendo a nudo il fondo di un piccolo lago o d’una pozza preistorica, erodendo l’acqua e fortificando le strade che percorre fin dal tempo in cui ancora non distingueva differenze tra soffiare e camminare. Poi non ha più pensato alla serva bionda se non per cupidigia.
••••
Pare fosse sempre l’ultimo a svegliarsi la mattina, perché invece di metterlo all’ospizio lo prese mio padre. Qualcuno gli dava il suo quarto di vino e l’amato quotidiano sul tavolo della cucina. Lo trovavano sempre lì quando rientravano a casa per pranzo, col viso schiacciato al foglio, intento a decifrare quelle parole che ormai dovevano sembrargli blocchi d’asfalto nella nebbia. In casa teneva la televisione accesa, e contemporaneamente lasciava la radio a cantare, in un vociare dissonante da giostraio.
Una mattina, mio padre scese sotto casa a comprargli il giornale e, come al solito, rientrando lo aveva chiamato dall’ingresso. Nessuna risposta. Aveva provato a chiedergli come si sentiva quella mattina, e quando di nuovo non rispose, chiamò l’ambulanza. Quando fu passato il lutto qualcuno buttò il portacenere all’immondizia e non ci fu più nulla di suo per casa.
Questo mi ricorda l’ultima telefonata che feci con lui appena due settimane prima. Lo ricordo perché si festeggiava quell’anno il centenario della radio. Abbiamo urlato tra le pause di una canzone. Poi lo speaker ricapitolando il palinsesto inserì una curiosità, disse qualcosa delle onde radio, che superata la ionosfera viaggiano in linea retta nel vuoto: hanno calcolato che le prime trasmissioni hanno ormai raggiunto la Grande Nube di Magellano. Se qualcuno oggi lì accendesse un apparecchio sentirebbe arrivare da lontano la voce di Alexander Graham Bell, quella di Enrique Telémaco Susini, poi quella di Maria Luisa Boncompagni, l’armonica di Little Walter, le rullate di Gene Krupa, Mal’anema d’a palla di Roberto Ciaramella. Tra novantacinque anni, in quel posto senza orecchie, anche io e mio nonno che parliamo d’oro e vino.