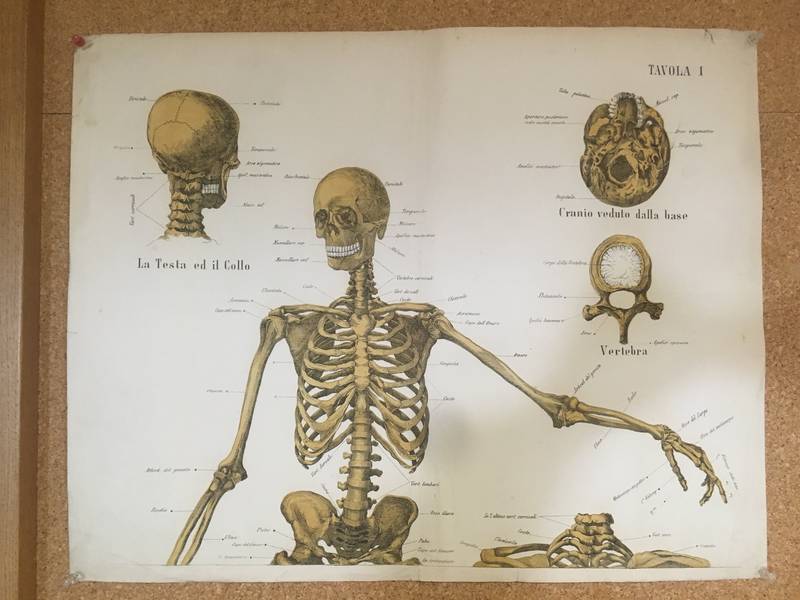Sono diventato entomologo perché insetto nella mia lingua è un sinonimo debole di infimo e ogni volta che lo senti detto – insetto – suona come qualcosa che devi condannare.
Non lo sapevo da bambino, quando rubavo le pinzette dalla borsa di mia madre, eppure ciò che amavo tanto dei campioni di formiche sottratti al prato ammalato di terriccio davanti alla mia scuola elementare era il fango morbido del giorno dopo che aveva piovuto, pioveva sempre quando avevo sette otto o nove anni e il fango gli incrostava le zampe e gli addomi alle formiche che sapevano di dolce amaro.
Adesso piove solo quattro o cinque volte all’anno e sulla cupola di vetro bassa del mio settore gli acidi che colano infiltrandosi nella terra esanime si lasciano dietro nastri oleosi e questi nastri sembrano la superficie magica delle bolle di sapone. Quando succede, il rovescio picchietta e rimbomba nell’aria di plastica del settore; in quelle sere per noi secche come sempre, come sempre né calde né fredde, io mi lascio mormorare nelle orecchie l’esercizio organico degli intervalli di pressione, aperta la finestra della camera che fu dei genitori, così l’insonnia diventa un silenzio più lontano.
Da un po’ di tempo poi scopro che i miei sogni, i rari sogni e tenui che si fanno più assidui con l’età, vanno per associazione: è morta mamma circa un anno fa e da allora sogno il prato della scuola elementare, è muffa, è la psoriasi che mi smozzica la pelle delle braccia e del viso, e il fango è il sangue che esce quando la gratto via con le dita, ci passo le unghie e intere ore a odiarla, crosta per crosta, questa è tutta la mia vita sociale; intanto fisso un punto vuoto artificiale in una delle teche mie e forse è un punto sempre diverso, sempre a caso.
La mia ricerca invece no, non va più a caso; sono agli sgoccioli, sono ormai praticamente, finalmente alla soluzione.
E se ripenso ai miei vent’anni, al giorno della mia laurea, a come nella tesi credetti d’essere vicino a questa soluzione, a quanta ingenuità, quanto vigore dissipato nell’aspettativa asettica di aver raggiunto una collocazione; e quella Sonia tanto pianta e amata, avventatamente, come solo amano i molto giovani e insensatamente affogando nell’inerzia il suo rifiuto, invece di votarmi alle mie formiche, la sua partenza indifferente con la prima ondata di migrazioni, come un affondo, e mio padre che diceva smettila, reagisci, ce ne stanno tante di meglio per te là fuori, e io che mi incazzavo con lui che non aveva fatto niente e che dicevo di non essere abbastanza e che di tutta risposta tornavo finalmente alle formiche. Le mie formiche; oh, papà, non ti ho mai detto quanto t’ho amato.
Noto che adesso, all’alba grigio cenere della mia vecchiaia comincio a vivere di certe concrezioni, di certe statue calcaree nei filtri della memoria: consumo sulla scrivania di plexiglas il mio pasto serale, mix di vegetali reidratati e pane sei percento d’alcol ai tre cereali, altissima conservazione; quando mi ostacola l’odore d’erba sfatta e crema di peperoni, mi blocco. E come un fiotto gastrico risale all’esofago, rielabora la base della lingua sulla punta della gola il sapore acidulo di questo ricordo, di questa sera bioluminescente nella nera cavità dei tempi del razionamento preliminare, la cena velata di rassegnazione, la mamma che piange per la fine dell’età della pasta al pomodoro e mio fratello, le erezioni incontrollabili dei sedici anni, gli occhi severi di mio padre e l’irruzione nella camera che ora è un magazzino, le sue accuse di passività totale, la difesa colpevole delle mie grida e la sua pelle fredda sui miei zigomi, mani di operaio, di uomo concreto, un impatto che mi sento addosso come allora. E penso, mentre nella mia testa si sovrappongono gli schemi, che a quell’età erano un’idea remota soltanto, dei movimenti di formiche che tenevo in un terriccio steso nelle scatole di scarpe, nascoste sotto il letto, e ora sono le mie migliaia di adorate inquiline, penso che tutto dev’essere nato dal movimento algoritmico dei pesci nell’acquario digitale del dentista di quand’ero bambino, io ero un bambino predisposto alle carie, e che è solo per questo scopo più importante, per queste carie, che non ho toccato un’ultima volta la mano di papà, che è vissuto sessant’anni in questa Terra ed è andato a morire su un altro pianeta.
In fondo, il mio destino di entomologo, non sono stato davvero io ad averlo deciso; è successo, ero un ragazzino timido, spaventato dal giudizio umano: mi piaceva la parola insetto perché sospendeva il giudizio sulla mia persona.
Presumo che sul baratro di questa nostra sacca amniotica nell’Universo a qualcuno dovesse spettare la missione; ho raccolto l’importante compito con entusiasmo, di chi sarà ricordato mi sono fatto carico dei necessari dolori. Ho rifiutato di partire quando hanno montato le cupole, con mio fratello, che ci va a fare un entomologo su un pianeta senza formiche?, ho rifiutato di partire con i miei genitori, ho pianto disperato perché non riuscivano a capire l’importanza di questa mia futura scoperta, li ho allontanati con tutto l’odio di cui era capace il mio cuore.
Li ho guardati in silenzio partire per il matrimonio di Paulo, quando era arrivato il momento di vedere la loro nipote. Ho rifiutato quando l’università di Mars Seven mi offriva una cattedra, non potevo lasciare allora, ero così vicino. Ho glissato tanto sulle preghiere di Silvia, l’ultima dottoranda, ci andavo a letto e forse l’ho amata davvero; prima di salire sulla nave traghetto mi ha detto finirai per essere come le tue maledette formiche. Io lo speravo molto; non capivo ancora cosa volessero dirmi, però lo sentivo che era così vicino.
Tre giorni fa ho ricevuto una chiamata ed era proprio Silvia, con il ritardo di quattro minuti le comunicazioni sono strazianti, eppure quanto piacere da quell’impressione che non si sarebbe mai arresa. Però questa volta, mi sposo, mi ha detto, non posso più aspettarti, lui è un brav’uomo, non provare più a chiamarmi, addio.
Ho fatto tutto ciò perché qualcuno doveva avere questo privilegio, perché qualcuno doveva fare questa scoperta, l’ho fatto perché ora io potessi esserci così vicino; l’ho fatto anche non solo per me, ma per le mie formiche, mi dico mentre nella stanza attraverso le ottanta teche le guardo, gli incroci genetici, le nuove numerose strane specie prelevate nelle escursioni ad alta e folle esposizione radioattiva, nel mondo che ci è scivolato via di mano, e quelle originali, le discendenti del prato della scuola che sono adesso l’unica famiglia ad essermi rimasta, le varietà sottratte a un’estinzione ineluttabile, quella scomparsa mai definitiva che è progresso evolutivo, la fuga inarrestabile dell’adattamento, la cieca corsa alla vita. L’ho fatto per l’indispensabile messaggio, tutte che si muovono con uguale esatto disegno di misura: questi rettili di insetti laboriosi, tutte che mi vogliono, tutte che ci vogliono, a noi umanità, dire qualcosa. Per le mie maledettissime formiche, l’ho fatto per loro.
Resterà qualcuno su questa Terra, per qualche momento questo qualcuno vivrà come se fosse un superstite, poi comincerà il tempo in cui sarà come se niente fosse stato; le notizie di qualcun altro che si sposa, di qualcun altro che viene eletto Presidente, di qualcun altro che invece ha ucciso, le notizie di qualcun altro che vive: arrivano smorzate sotto le nostre cupole, come le confidenze che fanno i parenti sulle tombe dei propri cari deceduti; avrebbe sposato te la bella Silvia, Marchino, avrebbe sposato te se tu fossi qui con noi ancora.
E invece non ci siamo più, noi, siamo gli ultimi sepolti nel grande cimitero malconcio del Primo Uomo. Ma io sono un uomo di scienza e per me i morti non parlano, e se non ci siamo più il mio messaggio non può essere per l’uomo – ecco la luce! Ci sono, lo sento, ecco la chiave: questo messaggio non è mai stato per loro, bensì era loro.
Ma certo, sto delirando, ho sempre avuto tutto innanzi agli occhi e non ci ho mai veramente pensato: sono io il messaggio, sono io questa carne fatta parola.
Vi sento, finalmente, vi sento mie amate formiche: voi mi stavate dicendo che siete per mezzo di me o non sareste state, che doveva restare qualcuno su questa Terra, una lapide per voi se questa Terra deve diventare un cimitero.
E io vi accontento: da questa cupola che è una teca come la vostra, da questa mia bocca che è una bocca come la vostra, la bocca di una cavia rinchiusa, mi lascio guardare da voi, da fuori: e non rimpiango di aver dedicato l’intera esistenza, questa esistenza di fine umanità terrestre, a dire il vostro nome.