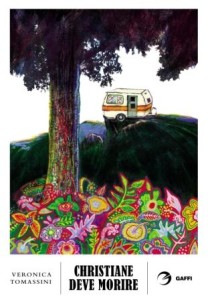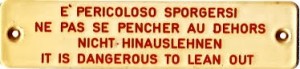Qui dialogo con Veronica Tomassini, scrittrice a suo dire incollocabile, a mio dire tra le maggiori delle ultime generazioni. Ne ho seguito e ne seguo l’opera: ne apprezzo oltremodo la capacità di fare “narrazione vera” senza ricorrere a quell’elemento che permette a molti di tenersi a distanza di sicurezza dalla verità che duole: il cinismo. Racconta le vite ai margini come se avesse baciato i lebbrosi, con pietà e senza pudore, e questo, per me, è qualcosa di raro; considero cioè raro essere pietosi e impudichi al cospetto del lato stigmatizzato del mondo, non da uomini, ma da scrittori e testimoni.
Cominciamo dal libro pubblicato da poco, L’altro addio (Marsilio, 2017). Riprendi la storia di Sangue di cane (Laurana, 2010) spostando il focus da lei a lui, seppur in entrambi i libri chi narra sia lei, giovane giornalista innamorata di un clochard polacco dipendente dall’alcol.
Perché hai scelto, a distanza di anni, di tornare sulla stessa storia? Cosa sentivi di dover aggiungere a quanto già scritto?
In Sangue di cane mi sembrava di non aver detto abbastanza, di aver chiuso quel romanzo quasi sbrigativamente, nella fretta di raccontare quanto di straordinario avesse attraversato la mia vita. Il piano era essenzialmente sentimentale, ma in realtà dentro c’era molto altro, era un fenomeno epocale che stava accadendo o era appena accaduto, una specie di guerra intestina, con i suoi morti, di alcol, di solitudine, nello spregio condiviso di un mondo perbene che tutto sommato se ne fotteva. Avevo scoperchiato un tombino, ci ero finita dentro, forse non ne sarei uscita mai, se non raccontando. Dunque Sangue di cane non bastava, quell’elegia era parziale, il movimento di uomini proveniente dall’Est Europa, in special modo dopo la caduta del muro, aveva già assunto i connotati di una trasformazione antropologica e sociale. Riferivo di quegli anni e di un post ancora più interessante. Ma era una guerra, l’Occidente doveva espiare le sue colpe, la sua èpa molle, impigrita dal più spregiudicato capitalismo, era antitetica e insieme patetica e offensiva dinanzi al fallimento storico dell’ideologia e di tutte le millantate e franate rivoluzioni socialiste; il pingue Occidente avrebbe dovuto rispondere delle sue responsabilità distratte. Quindi dovevo chiudere (ma forse non riuscirò mai veramente?) una vicenda spaventosa: il senso apocalittico che ingeneravano quegli uomini barcollanti ne dava la misura. Io ero una testimone. Non so perché, anzi lo so, ed è una spiegazione cristiana. Io ero lì perché dovevo raccontare. Ero testimone di come e quanto il dolore fosse potente e trasformasse lo sguardo e lo restituisse all’altro sotto la forma della pietà. Ero lì per raccogliere le loro commoventi speranze, ottenebrate dall’alcol, queste sostentavano – simili a Medee – creature mostruose e pietose insieme, il tremendismo di quelle vite, come la più sporca delle risacche nelle nostre strade, nei nostri parchi, chiedeva ancora qualcosa, altre parole. Non era finita ancora.
Torniamo indietro, al primo libro, Sangue di cane. Mi ha impressionato per l’incipit, crudo fino a essere quasi indigeribile, splendido per ritmo e stile. Il libro, poi, mantiene le premesse: uno stile a tratti lirico al servizio di un realismo potente e non facile da sostenere per il lettore, in cui credo convergano la tua esperienza di giornalista e anche la tua stessa vita.
Soprattutto, leggendolo, sentivo – come non mi capita quasi mai – di affrontare una storia vera, questo a prescindere di quanto di biografico ci fosse. Come se la storia o fosse realmente accaduta o comunque avesse altissime possibilità di accadere, in qualsiasi momento.
Ti chiedo: ci sono una necessità, un’urgenza dietro la scrittura di questo libro? Una storia del genere comporta anche costi emotivi? Dopo aver scritto un libro come questo, quanto occorre a trovare voglia e forza per scriverne un altro?
Scrivo solo quel che mi succede. Vorrei dire la verità. Raccontare solo la verità. Ma è il mio sguardo sul mondo, non la verità. O una parte di essa. Ho avuto una vita segnata dalla fragilità degli altri. Posso spiegarla così. Ho incontrato la fragilità dell’uomo, la sua miseria. In quel momento o a distanza di anni, ho realizzato quanto commovente e concreta fosse la risorsa dello spirito che risorge, ma risorge solo dopo la morte morale, la caduta appunto. Chiamiamola defezione, debolezza, empietà. Per me è stato un cammino di conversione ed è avvenuto in luoghi innominabili, non tra i banchi puliti di una chiesa; piuttosto seduta su una panca dietro cui un barbone dava di stomaco e magari quel barbone che strisciava come un verme era l’uomo che amavi. O che conoscevi e che sarebbe morto prima. Ho incontrato il misticismo nel fango, nell’innominabile, nelle retrovie dove la decenza si sarebbe fermata bruscamente e in tempo; tra gli uomini che tutti davano per spacciati, per i quali c’era solo il suono di campane, un Requiem. Nell’indecenza, nell’imperdonabile, ho incontrato il misticismo, una dimensione superiore a volte così forte e imprimente da procurarti le lacrime. Ho incontrato Dio, questo Padre dolcissimo e rivoluzionario, quel Padre avrebbe sollevato le braccia di un ubriaco sepolto dai suoi escrementi? Sì. Quindi il prezzo emotivo da pagare è alto, sì, certo è alto. Ma non mi è mai venuta meno la certezza che lo avrei fatto, che sarebbe stato così, che era già scritto, ogni lacrima raccolta nella grande otre, ogni nostro passo contato, biblicamente. Scrivere ancora sarebbe stato sopravvivervi. Era un modo per sopravvivere all’eccezionalità di un destino, il mio, anche se solo riflesso. La mia piccola storia precipitata dentro il magistero di una storia più grande.
Dopo Sangue di cane, Christiane deve morire (Gaffi, 2014). Cambia la storia – qui una donna sola di trent’anni si concentra sul lavoro da giornalista, e per lavoro si lascia coinvolgere dal mondo dei rom; emerge anche il suo passato in periferia tra ragazzi tossicodipendenti – ma verità e urgenza sono i medesimi. Resta forte l’impressione di una convergenza tra vita e finzione romanzesca.
Cosa rappresenta per te la periferia?
La periferia è la mia vita, ancora una volta. Metaforicamente, ma non solo. La periferia è stata la mia giovinezza. La giovinezza erano deserti, erano i casermoni, anonimi, un tripudio di ottusità, di bestialità; la periferia è una induzione preconcetta al suicidio. Il nuovo romanzo inedito racconta proprio quel tempo. Il tempo della giovinezza che coincide per me con la periferia, con gli amici che chiamavo compagni, perlopiù eroinomani. Sono indifendibile, ma è andata così, ho incontrato solo questo tipo di umanità, per una ragione o l’altra, gente sul filo, gente la cui esistenza era una scommessa, una promessa non mantenuta. Il mio abbecedario è quello del tossico, lo appresi dai libri e poi dalla vita e dalla periferia. Dovevano rinchiudermi, mi sarei salvata, invece mi sono salvata a modo mio: scrivendo. O era quella periferia, il mio personalissimo deserto, a essere già la scrittura che si metteva di traverso tra me e le cose. Il fallimento viene così nobilitato, la vita di un’imperdonabile assume il rigore elegiaco della trama di un libro. Altrimenti sarei stata una disadattata, sempre in cerca di guai suo malgrado.
In questi due libri affronti, con pietas e al contempo con una sorta di “sguardo denudante” (nel senso di sguardo che tutto vede, che non cede alla paura o al pudore), la dipendenza da sostanze devastanti (l’alcol, nel primo; l’eroina, nel secondo).
Cosa è per te questo male – la dipendenza – più comune di quanto si pensi (che poi il concetto, volendo, può essere allargato; in tutti i tuoi tre libri viene fuori anche la dipendenza emotiva)? Si può sopravvivere a una dipendenza?
La dipendenza è stato il fil rouge che ha governato ogni vicenda della mia vita, ha segnato la mia vita, nel bene e nel male. Si può sopravvivere “con” la dipendenza. Forse. Non ad essa.
Si crede che scrivere dell’amore sia insidioso, che il rischio di cadere nel melodramma sia sempre alle porte, eppure l’amore, alla fine, è il grande tema della tua opera.
Mi permetto di dire: c’è del sentimentalismo, nel senso di eccesso di sentimento, e anche qui uno “sguardo denudante” tende a mostrare tutto.
Non hai paura di scrivere d’amore? Non temi di volgerti troppo dalla parte del sentimento, come abbandonandoti a un sentire tardoromantico?
No, non ho paura di parlare d’amore. Cosa saremmo senza l’amore? L’amore guarisce, salva, io racconto l’amore, trovo in esso la mia identità, posso solo riconoscermi negli occhi di chi mi ama. Eppure sembrerebbe il contrario. Il sentimentalismo non ha una determinazione negativa. Io sono una sentimentale, non so quanto lo siano i miei libri (all’apparenza molto poco), nelle intenzioni però sono i libri di una sentimentale.
Ora vorrei volgermi al punto più discutibile/discusso della tua opera: il racconto dei marginali.
Ho l’impressione che un eccesso di empatia innanzitutto, e poi di certo qualcos’altro, spinga le donne protagoniste dei tuoi libri a “mimetizzarsi” nei luoghi ai margini (quello dei clochard, dei rom, dei tossicodipendenti). Una mimesi incompleta, perché riescono a mantenere quel minimo di distanza necessaria a non annegare, a non soccombere ai pericoli anche letali con cui si misurano.
È l’amore/passione a spingerle a oltrepassare i confini della società per “vivere” (e non “esperire”, come riescono a fare ad esempio giornalisti, o scienziati) i margini, le periferie, tra gli ultimi della terra.
Io ci vedo una “santità materna”, intesa come sentimento di pietà e volontà di salvezza o almeno di protezione, al di là del bene e del male (e qui c’è del religioso, del sentimento cristiano); tu che ne pensi? Cosa ti spinge a narrare gli ultimi? E come li narri?
Potrei avere un paio di risposte, ma non sono sicura che siano le risposte. Qualcuno forse un giorno dovrà spiegarlo a me perché sia finita nei luoghi da cui gli altri tolgono lo sguardo. Il mio di sguardo vede la “luce” dove per molti ripara “ombra”. È uno sguardo che deraglia, indolente, guidato male. Una risposta potrebbe essere: il mio problema con la noia; non mi basta quel che vedo; mi disturba la ripetitività ossessiva, io che ne sono la perfetta esecutrice, come leggere le scritte dei treni all’infinito fino a perderne il significato: ne pas se pencher au dehors, nicht hinauslehnen, it is dangerous to lean out e così via, un gioco che facevo da ragazzina, il mio modo per affrontare la noia dei lunghi viaggi in treno. La noia mi ha procurato un sacco di guai. Un giorno lessi una dedica su un libro, non era per me: “Accontentati di essere l’infinito”. La noia è il sintomo di una tentazione benevola: tornare al fulcro, da chi eravamo, da sempre, per sempre. Le letture fatte da bambina non mi hanno certo aiutato. Ho letto Christiane F. Noi i ragazzi dello zoo di Berlino a otto anni. Lo trovai in una libreria del centro storico di Terni, erano le vacanze di Natale, sfuggii alla mano di mio padre e mi infilai in questa libreria. Vidi la copertina gialla, in una vetrinetta girevole alla mia portata. C’era una ragazza, aveva un rossetto scuro, i capelli lisci lunghi, il chiodo nero, dietro il buio di un sottopassaggio. Era il Kurfürstendamm. Per me è cambiato tutto ovviamente da allora. Mi è calato sul viso il tedio di qualcosa che non mi apparteneva, una sofferenza estranea, le luci psichedeliche della Haus der Mitte, il sapore metallico dell’eroina e quello dolciastro di un succo di ciliegia per far calare il trip, un acido. Avevo solo otto anni. Ed ero già stata con la mia piccola testolina a Gropiusstadt. Avevo già la scimmia, conoscevo le piste, le dosi, i quartini, il prezzo di una stagnola di Sugar Brown, l’equivalente in marchi. Era troppo per una bambina, no? Indosso da sempre un rossetto scuro, come Christiane, ora che ci penso.
Torniamo all’ultimo libro, L’altro addio: qui, dopo Sangue di cane, percorri ulteriori passi verso la Polonia, uno Stato che nel Novecento ha patito vicissitudini storiche di vasta portata anche tragica. Cosa rappresenta la tua Polonia, cioè la Polonia filtrata da te – non è scontato precisarlo?
La Polonia filtrata da me sono solo le origini di mio figlio, un luogo letterario che ho amato leggendo Hłasko e il destino di qualcun altro, la nostalgia di qualcun altro. Un amore che mi è stato restituito perché lo tenessi al riparo per un po’, non ne ero la destinataria. Ma ho amato moltissimo i luoghi musicali, letterari, cinematografici, che arrivano da lì, tra il Baltico e i Balcani, già da ragazza, inspiegabilmente.
Veronica Tomassini, da scrittrice, nel panorama letterario italiano, come si colloca?
Cosa vorresti riuscire a raccontare? Quale altra “periferia” narreresti a modo tuo, cioè immergendoti in esso fino all’estremo limite che ti consenta, poi, di riemergere? La scrittura, per te, è pericolosa?
Sono una incollocabile. Come un brano di lana che ho lavorato agli aghi di recente, troppo corto per essere una coperta, troppo lungo per essere una mantellina. Non so cosa io possa raccontare fino al punto di, devo essere trascinata, devo trovare il centro, il significato, un’invocazione, la sensazione del tutto che si completa, il vuoto che mi assedia comunque; i miei fantasmi sono sempre gli stessi. La scrittura può essere pericolosa perché è un destino.