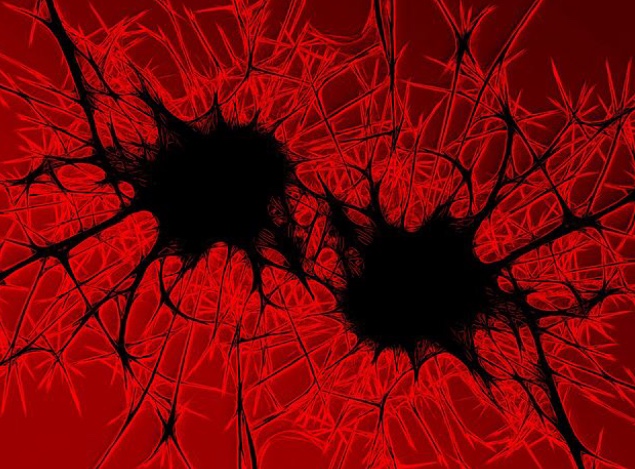“Gli scrittori di storie brevi si vantano spesso di aver letto Pétrus Borel. Infatti, molti scrittori tentano di imitarlo. Che grande sbaglio! Dovrebbero, invece, imitare il modo in cui Borel si veste. Ma la verità è che loro non sanno proprio niente di lui o di Théophile Gautier o di Gérard De Nerval”.
Roberto Bolaño Ávalos
All’interno del movimento chiamato genericamente “romanticismo francese” crebbe un ristretto gruppo di “minori”, designati con ogni sorta di epiteto (“petits romantiques”, “bousingos”, “Jeune-France”), che ne affrontarono la frontiera. Mentre la scuola ufficiale stilava comodamente il suo manifesto, la piccola fazione lo esasperava. Mentre la prima esortava alla libertà del genio sregolato e tormentato, cedendo ‒ che dico… elevandosi! ‒ a una saggezza disciplinata liricamente classicheggiante, l’altra la traduceva in una frenesia disorientata contro una realtà cupa e intollerabile. Mentre quella innalzava a urgenza il culto dell’io, inaugurando un perfetto intimismo confidenziale, questa lo inacerbiva in esternazione solipsistica, violenta e allucinata. Mentre i (R)omantici descrivevano mirabilmente malinconie affettive, i (r)omantici bruciavano, uccidevano e morivano per amore. E mentre gli integrati si accomodavano in un confortevole ma prolifico borghesismo cittadino, i reietti se ne allontanavano.
Ho dimenticato un appellativo per questo gruppo di estremi, “Frénétiques”; e la letteratura ce ne dona puntualmente la guida: Joseph-Pierre Borel d’Hauterive, o meglio Pétrus Borel, detto il licantropo, padre del “Frenetismo”.
Il solo l’appellativo fa emergere immediatamente i due elementi distintivi della persona e dell’opera di Borel: la facezia, perché il titolo nobiliare è preso a prestito, inventato di sana pianta, e la selvaggia istintività, ovvero la Licantropia.
Facezia? Troppo blando e carezzevole. Qui ci troviamo di fronte a un’ironia macabra e feroce propria di un «dandy stile Terrore»[1] intento a svelare le fragilità di chi si pone al limite per poi necessariamente avvertire ciò che subito lo perseguita: un senso di infinito che si fa vertigine presso lo strapiombo. Il tema è padre di quell’ironia ottocentesca teorizzata da Schlegel come anelito necessario per l’espressione dell’angosciante sproporzione tra concluso e incommensurabile, tra vincolato e incondizionato. Certo la dottrina dei saggi impone che il movimento ironico tra gli estremi risolva il dualismo in una sintesi ragionevole di autosuperamento pedagogico. Ma l’armonica sinfonia dell’accademia cede sul campo, e nell’opera dei “bousingos” rimane solo un frastuono stonato e una deludente duplicità. Di fatto le coppie di contrasti si presentano irresolubili ne Le Croque-mort: i riferimenti letterari alla dicotomia anima/bestia da M. Xavier de Maistre, la citazione del Momus albertiano, satirico mito sulla doppiezza umana; il ritratto di madame, amazzone e bucolica insieme; ancora l’orgia finale animata da macabri festeggiamenti che termina in un elegante e raffinato locale sul viale del fashion. L’affossatore, con vigore crescente ‒ che filosofo! ‒ ci carica di dissonanze ed eccezioni, contraddizioni e calembours, sorprendendoci, lemme lemme, a osservare ancora col sorriso il dissidio inaudito tra vita e morte.
Involontariamente, ma solo dopo, ne comprendiamo l’essenza insanabile[2].
Dell’ironia accademica precedentemente teorizzata ci rimane “soltanto” una buffoneria serissima, una tragicità spassosa e infine una splendida e irriducibile incoerenza.
Un piccolo consiglio quindi: non prendete mai sul serio Borel, ma con tutta la vostra serietà!
La natura della Licantropia è assai più limpida di quanto si possa pensare: è un’assoluta dedizione alla più erompente libertà che non ammette alcun argine né impedimento; se Borel accetta regole e abitudini civili lo fa costretto dalla contingenza storica di uomo gettato nell’Ottocento francese. In tale condizione, per sua indole, abbraccia le correnti culturali e politiche rivoluzionarie, perlomeno progressiste, del suo tempo condividendo la poetica romantica e l’intenzione repubblicana. Nel suo unico pamphlet, L’Obélisque de Louqsor, si propone di destare la coscienza popolare affinché prenda coscienza degli oltraggi della civiltà e del progresso. Se prende parte a tendenze letterarie e sociali di un certo tipo è perché provvisoriamente le ritiene le più tollerabili, i più passabili indumenti dove, oppresso, si scomoda. Nella prefazione alle Rhapsodies dichiara:
Sì! sono repubblicano, ma non è il sole di luglio che ha fatto sbocciare in me questo alto pensiero, lo sono dall’infanzia, ‒ ma non repubblicano dalla fascia rossa e blu della carmagnola, peroratore da capannone e piantatore di pioppi; il mio repubblicanesimo è la licantropia! ‒ Se parlo di Repubblica è perché questa parola mi suggerisce la più ampia indipendenza che possano permettere la società e la civilizzazione. Sono repubblicano perché non posso essere caraibico. Ho bisogno di una quantità enorme di libertà: la Repubblica saprà darmela? Non posso saperlo. Ma quando questa speranza cadrà come tante altre illusioni, mi resterà il Missouri!…[3]
Forse proprio tale precarietà è uno dei tratti essenziali del frenetismo di Borel: si cala nei panni del colto e a tratti impegnato cittadino francese come in un ruolo caro ma mai pienamente suo; il senso di dolente inadeguatezza, un inappagamento che sfiora il cronicismo fanno però da contraltare a un profondo convincimento: quello di chi è certo che, come ogni altra illusione, anche la repubblica e il manifesto romantico svaniranno insieme all’inganno che le pervade. Inganni effimeri come le azioni di Borel, ideate, attuate, ma presto smarrite. È l’idea stessa, prima del fatto, che perisce nel partorirne una più giovane che immancabilmente viene realizzata per stemperare la percezione di ristrettezza e vanità di quella precedente. L’esito è quello di una mobilità lacerante e di una smania penosa che donano alla sua vita e opera una volontaria dimensione iterinale.
Perciò la rivoluzione politica e letteraria affiorano unicamente come circostanze di un diverso profondo sentire, quello più ampio della pura e semplice rivolta. Condivisibili le parole di Daniel Marc:
Pétrus Borel fu prima di tutto un rivoltoso che un rivoluzionario… le poesie rivoluzionarie di Petrus Borel, per quanto sincere, non sono che delle declamazioni senza veritiera passione[4].
La rivoluzione è utile ma accidentale, la dottrina un canovaccio notevole ma naïf che, seguito alla lettera, diventa occasione per una sedizione serissima disposta a travolgere tutto e tutti. La rivolta è totale e selvaggia, la licantropia è vorace e anela ad annientare ogni autorità costituita; inevitabilmente l’impronunciabile pugnale della rivoluzione sarà anche lui sbriciolato, se non nei fatti, almeno nella poesia, con l’ironia, anche per sciogliere il tedio:
Dal momento che attraversava la place de Grève improvvisamente si trovò nei pressi della g… No, mai la mia penna saprà scrivere questa parola orrenda… Indietreggiò sgomento… Era nell’impeto del Terrore. A quel tempo l’orribile strumento era in pianta stabile e il sangue più puro e più innocente grondava continuamente sul patibolo[5].
Un vero e proprio testo di poetica è poi Champavert il Licantropo[6]: qui il climax invettivo del protagonista assume piano piano il profilo di autobiografia; la lotta appare in principio sociale, atta a denunciare ogni simulazione con una fratellanza dalla voce furente e scandalizzata:
Non parlerò della pena di morte sbiaditasi, dopo Beccaria, sotto molteplici ed eloquenti voci, me ne allontanerò indirizzando l’infamia sul testimone d’accusa, lo coprirò di onta! come si può concepire un testimone d’accusa? che orrore! Solo l’umanità riesce a dare tali esempi di mostruosità. Esiste una barbarie più raffinata, più civilizzata della testimonianza d’accusa?[7]
Borel sospende il giudizio generico sulla pena di morte (lascia ad altri più autorevoli le definizioni della dottrina e della superiorità morale) ma inveisce indignato contro il testimone d’accusa, tutto tronfio nel ruolo del cittadino coscienzioso che a cuor leggero manda a morte un suo simile. Non si tratta di una barbarie? Se il testimone d’accusa d’emblée venisse scaraventato nei panni del suo contraddittore, nel ruolo dell’imputato per essere soppesato da un più alto tribunale, la sua raffinata civiltà verrebbe liquidata come debole attenuante: la crudeltà sussisterebbe feroce. La polemica è sincera ma non è un punto di arrivo: non ci sono un traguardo dove finalmente trovare una soluzione accettabile, una mediazione, un’autorità capace di appagare le esigenze umane. Anche l’eccellente civiltà guidata dalla più perfetta conduzione e la più sensibile umanità sono ipocrisie raffazzonate e sbiadite che nascondono intimamente il germe del male e della violenza. Le nuove istituzioni si arrogano il diritto di nascere per il bene, ma sguazzano ancora nel male.
Mi ritrovo ogni volta stupito nello scoprire come l’evocazione letteraria dell’efferato, che apparentemente palesa una vocazione al negativo e all’annientamento, veli una tenera umanità, quella sincera. Borel allude a una più certa negatività ‒ la sconfessione del male e della morte ‒, a un più profondo scandalo ‒ la definizione e la banalizzazione dell’emotività ‒ e non è forse pienamente romantico come intento? Persino il classicheggiante canto amoroso placido ed epidermico è disonesto:
Cantare l’amore!… Per me l’amore è odio, gemiti, grida, vergogna, lutto, arma, lacrime, sangue, cadaveri, ossa, rimorsi, non ho mai conosciuto altro!… Avanti rosei pastorelli, cantate dunque l’amore! Che ridicolaggine! Che amara pagliacciata![8]
E se caso mai si placa in una dolce quiete, diventa subito seccatura; il potere e l’incanto della felicità nella loro immobilità, nel loro esserci, risultano addirittura grevi:
Nella mia gioia annoiata io la trovavo arida,
Ero stanco d’un bel cielo e d’un letto amoroso.
La felicità è pesante e assopisce gli animi.
Trattiene il nostro cuore entro uno stretto cerchio di ferro[9].
Una volta essersi inabissati nelle più virtuose ed educate abitudini urbane e aver però poi scoperto come le sue strade e i suoi palazzi, ad esempio il Palazzo della Borsa o il Palazzo di Giustizia[10], fondino la struttura di quel perbenismo vomitante atrocità disumane, ci aspetteremmo che un tale indignato cerchi ossigeno pacificandosi nel seno dell’antipode cittadino; Jean-Louis si perde nella vita campestre accordando la sua con gli almanacchi pagani; saprà fare altrettanto l’irrequieto Champavert/Borel? Se per un solo istante dovesse immergersi nella visione di una possibile realtà rurale emergerebbe l’immagine di un selvaggio incapace di uniformarsi alla natura ma deciso a viverla, o meglio punirla, con licantropia, cioè con azioni dissonanti, con violazioni sfrontate: barbaro, massacrerebbe animali, penetrerebbe i più vergini e coriacei terreni, ghigliottinerebbe alberi.
Ma prima del castigo, la natura è dichiarata rea del più grave delitto, quello di annoiare:
Niente è più noioso di una fissità, di un modo costante, di un perpetuo almanacco. Tutti gli anni gli alberi inverdiscono e senza sosta gli alberi rinverdiscono; Fontainebleu! Chi ci libererà dagli alberi verdi? Tutto questo mi inebetisce!… Perché non un po’ più di varietà? Perché le foglie non prendono di volta in volta i colori dell’arcobaleno? Fontainebleu! Tutta questa vegetazione è stupida![11]
È colpevole di non mutare, di non differire cioè di spietata indifferenza: la rabbia e il tedio sottendono una richiesta di cambiamento, implicitamente bramano una riforma della sua fisiologia capace di vendicare il male di cui è spettatrice. Con la dovuta riserva dettata dalle diverse poetiche e sfumature, Borel colloca il suo dipinto nella ricca pinacoteca che ha come tema gli algidi ritratti della natura maligna nella sua imperturbabilità: dalla matrigna o Arimane di Leopardi, alla garce e grande putain di Sade, a certi paesaggi di Apollinaire[12].
Passereau[13] prima di vendicarsi della presunta infedeltà di Philogène spingendola crudelmente in un pozzo, la accompagna in un viale di tigli «in mezzo a questa funerea e indifferente natura» per «stringere nelle braccia un essere pieno di fuoco…»[14].
Vessato dal disprezzo comune, il canto penoso della gravida Apolline torturata dall’inedia e dall’onta dello stupro suona:
Carnefici, arrestate la mia tortura!
Il male ha reso il mio cuore malvagio:
Tutto il mio odio a te Dio, mondo, natura,
Odio a tutto quello che sognavo!
Prima del mio corpo, su questa ruota
Dove la sorte mi tiene stretta,
Spira la mia anima, e io la voto
a Satana, per l’eternità!…[15]
Nel chiedere ai suoi carnefici di porre fine alle sue torture, l’anima della giovane, esacerbata dalla sofferenza, si dà al maligno, una sorta di Arimane leopardiano; e proprio Champavert nel suo furioso monologo prende le sembianze morali di un demone satanico. Certo in Borel vi è solo la voluttà della bestemmia, il compiacimento dell’affronto, mentre in Leopardi, con spossata calma, vi è quasi una riduzione filosofica e religiosa del tutto a un solo principio; ma l’approccio, sebbene diverso anche nei toni, è accomunato dalla polemica e dalla tragicità.
Davanti alla constatazione della radicazione del male e dell’indifferenza in ogni essere, le reazioni saranno poi diverse: Leopardi invocherà le speranze, gli ameni inganni, Sade, riscontrando la Natura del Male o il Male della Natura, vi si adatterà alimentandolo per esorcizzarlo. Il lettore non si stupirà invece nell’osservare un Champavert vagare, incapace come Borel di placarsi in una scelta tediosa, tra un pessimismo storico e uno cosmico senza mai addentrarsi pienamente in alcuno, o meglio vivendoli, da instancabile soldato di confine, repentinamente e con tale forza fino a sfibrarli entrambi per annullarli. La soluzione latita, l’angoscia, inadatta a essere convogliata in una concezione unitaria, trova sfogo nella sola condotta scoordinata e cieca. La tragicità, priva anche di una parvenza di equilibrio, porta quasi ottusamente alla sola opposizione convulsa. Del resto Borel non ci ha abituato, come ormai sappiamo, a una capacità sintetica rischiarante, lasciando incompiuti i più aspri dissidi. L’opera esige, dopo la tempesta sensoriale, un equilibrio che Borel non saprà o non vorrà mai elargire; sebbene l’opera d’arte si spogli infatti dell’attributo imitativo per assumere quello evocativo, brama comunque una fissità sempre meno autorizzata e sempre più arbitraria, capace di svincolare l’oggetto per aprirvi all’interno un mondo. Ma con tali premesse è pensabile aspettarci un tale frenetico intento a elargire fissità?
Come è facile immaginare, la rivolta contro la natura e il mondo non può prescindere da una eclatante vessazione di Dio; questa però, sebbene sfrontata nel tono, è timida e infantile nei contenuti:
Se esistesse un Dio pronto a scagliarmi il suo fulmine, lo sfiderei! Che vomiti tutto il suo livore, questo Dio possente che intende tutto, io lo sfido!… Ecco, io sputo contro il cielo! Guarda là in basso, vedi quel povero tuono che si perde all’orizzonte? Si direbbe che mi tema. Ah! Francamente il tuo Dio non è suscettibile in fatto di onore: se fossi Dio, se avessi delle saette per le mani, non mi lascerei insultare e sfidare da un insetto, da un lombrico. Del resto, voi altri cristiani avete impiccato il vostro Dio, e ben avete fatto, perché, se ci fosse un Dio, bisognerebbe impiccarlo[16].
E ancora in Rêveries, annunciata da un lapidario «Il mondo è un baro…»[17], rivolgendosi agli ingenui: «Un orco chiamato Dio vi riserba un altro destino»[18]. La bestemmia e il confronto sono vigorosi, ma di una forza solo gravitazionale che scade vuota nella pesantezza. A ragione Armand Hoog parla anche lui di una rivolta da cui nasce spontaneo solo un grido di protesta contro qualcosa che ancora sussiste[19]; «ma chi dice rivincita non dice rinuncia»[20].
E ancora: rivolta – come ha sottolineato Camus – contro ostacoli divinizzati che Borel non è certo di potere superare[21].
La furia di bastonare è incontenibile e rivolgendosi disordinatamente a tutto assume anche la forma di un autolesionismo grottesco e beffardo che investe la propria persona per colpire insieme l’autorità: Passereau prima reca visita al boia rivolgendogli tale supplica: «Desidererei che mi ghigliottinaste»[22]; poi, dopo aver perso la propria vita al gioco del domino, rivolge spensierato e leggiadro queste parole al suo rivale amoroso: «Fatemi saltare il cranio»[23]. Altre volte il suicidio è finalmente cupo e risolutore: Champavert si uccide accoltellandosi al cuore nel bel mezzo di un mattattoio equino, il lettore riconoscerà in lui lo stesso l’autore con la barba nera. E Borel, effettivamente, decretò la sua fine: quando anche il contrasto continuo assunse la parvenza di regola, se ne liberò adagiandosi nella natura prima osteggiata, cioè abbandonandosi al sole della colonia algerina in attesa di una morte per insolazione[24]. Solo lui poté escogitare una così stravagante fine!
Borel, come le croque-mort, si pavoneggia nel ruolo di figlio e sacerdote del già citato Momus, il dio della doppiezza, del sarcasmo, del biasimo, del ridicolo scandaloso. Non guasterebbe godersi l’irrequieto e insoddisfatto Borel criticare lo scricchiolio dei sandali di Afrodite, incaponirsi nel trovare il difetto anche nella perfezione della dea. Così si narra di Momus, il dio minore che, nelle favole di Esopo, fu chiamato come giudice in una disputa fra Atena, Zeus e Prometeo per decretare chi dei tre avesse compiuto l’opera più perfetta. Purtroppo il Toro di Zeus portava corna mal poste e la Casa di Atena non era trasportabile. A Prometeo – e qui emerge la tenerezza di Momus/Borel – contestò poi di aver celato all’interno dell’uomo il suo cuore, di averlo nascosto a una profondità a cui la coscienza non può attingere e in cui la compassione non può che annegare. Sarà poi Leon Battista Alberti a raccontare le vicissitudini terrene di Momus, “il Dio in rivolta” cacciato dall’Olimpo e intento sulla Terra a sobillare gli uomini contro il dominio celeste. La disputa e il giudice esopici verranno ripresi da Leopardi nelle Operette Morali[25] dove Momus accetta la “perfezione” umana a condizione che il titano ammetta che l’eccellenza comprende anche tutti i mali possibili. La versione leopardiana è pertanto una spina nel fianco della visione titanica romantica che innalzava Prometeo ‒ προµήϑειος, “colui che riflette prima” ‒ a simbolo di deificazione della capacità umana di attingere una saggezza molto vicina, se non identica, alla perfezione divina. Prometeo plasma dal fango l’uomo animandolo con la scintilla divina del fuoco rischiaratore capace, attraverso i doni dell’arte ‒ o meglio dell’artigianato ‒ e delle tecniche, di lenire e curare la piaga scandalosa della sofferenza, del male e della morte. Ma con quali risultati? La ragione riflettente e l’abilità tecnica si sono fatte carico della più ardua incombenza, illudere l’uomo di poter controllare la natura, dominarne le leggi, gestire e dirigere il progresso umano verso la non così distante perfezione divina. La presunta chiarificazione illuminante si è mutata in un velamento, la supposta pienezza in mancanza, il vanto divino nella morte del mito secondo il quale gli uomini un tempo banchettavano alla stessa tavola di Zeus; Leopardi ci ha donato un Prometeo costretto a riconoscere la sua disfatta davanti al beffardo Momus, screditando insieme lo streben romantico anglo-tedesco che saggiamente si quietava inverandosi nell’autoappartenenza allo Spirito. La presunta perfezione divina, il Dio convenzionale, si presenta retaggio di una metafisica tecnicistica incarnata dal titano, una falsa immaginazione occultante l’altra e forse unica divina verità del sentire umano che Prometeo vuole adombrare. Chi pensa che la natura umana e l’essenza dell’uomo siano appunto divine, non può sottrarsi dal misurarsi con la perfetta fiamma prometeica talmente luminosa da abbagliare lo sguardo dell’uomo sul divino, ovvero lo sguardo dell’uomo allo specchio.
Ma non c’è da disperare, il mito ci mostra anche l’aspetto più affettuoso di Zeus che, furioso di passione, rivendica il connubio con l’uomo e vendica la protervia prometeica offrendo “tutti i doni” ‒ πανδώρα ‒, ovvero Pandora. La donna mortale non dispenserà la riflessione ponderante, proposta alla sconfitta di ogni male violentemente camuffandolo. No, la sensibilità femminile recherà in dono ogni singola infamia, ogni allucinante angoscia, ogni sgangherata mostruosità, ogni insensata contraddizione, il liber monstrorum de diversis generibus sepolto nell’animo umano. Crudeltà? Affatto; disvelamento assoluto, quindi verità pervasa che fa rivivere il divino vendicato e l’umano costretto da Prometeo, come Esopo ricorda, a nascondere il proprio cuore invece che svelarlo pulsante alla luce. Ed è oltremodo curioso scoprire nella celebrazione, priva di imperio, di ogni aspetto, anche il più sordido, una consapevolezza amorevole, vivacizzata da un’autenticità sempre distante dal paternalismo profilattico titanico.
Accanto al titanismo nordico si profila allora un diverso sguardo nel quale un certo surrealismo[26] ha visto l’inizio del pensiero moderno. Avance tutta francese ‒ o quasi ‒ che viene alla luce col sommo marchese per proseguire con Nerval e Borel, poi Baudelaire e Apollinaire, e aprirsi nel dimenticato Isidore Ducasse, solo per citarne alcuni, senza alcuna intenzione di completezza.
Rincuora più semplicemente la completezza del mito, ovvero Pandora intenta a liberare anche il più bel male, la speranza, il motore immobile dell’affaccendarsi umano; la parzialità di Borel lo costringe invece a tener ben sigillata entro il suo pithos quell’ultima entità, piegandolo inevitabilmente a un desolante, infernale, estremo deserto africano.
***
Opere di Petrus Borel menzionate:
Rhapsodies, 1832.
Champavert, contes immoraux, 1833.
L’Obélisque de Louqsor, 1836.
Le Croque-mort, 1840.
Gottfried Wolfgang, 1841.
Bibliografia
Leon Battista Alberti, Momus.
Guillaume Apollinaire, Les Onze Mille Verges.
Albert Camus, L’Homme révolté.
Esopo, Fabulae.
Armand Hoog, La Revolte metaphysique et religieuse des petits romantiques in Les Petits Romantiques Français.
Pierre Klossowski, Sade mon prochain.
Giacomo Leopardi, Bruto Minore in Canzoni e La scommessa di Prometeo in Operette Morali.
Daniel Marc, Pétrus Borel le Bousingo in Les Petits Romantiques Français.
Marcel Jean e Mezei Árpád, Genèse de la Pensée Moderne.
Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica.
[1] Definizione che Mario Praz dà di Borel ne La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica.
[2] Insanabile per la metafisica occidentale.
[3] Oui! je suis républicain, mais ce n’est pas le soleil de juillet qui a fait éclore on moi cette haute pensée, je le suis d’enfance, ‒ mais non pas républicain à jarretière rouge ou bleue à ma carmagnole, pérorateur de hangar et planteur de peupliers; je suis républicain comme l’entendrait un loup-cervier: mon républicanisme, c’est de la lycanthropie! ‒ Si je parle de République, c’est parce que ce mot me représente la plus large indépendance que puisse laisser l’association et la civilisation. Je suis républicain parce que je ne puis pas être Caraïbe; j’ai besoin d’une somme énorme de liberté: la République me la donnera-t-elle? je n’ai pas l’expérience pour moi. Mais quand cet espoir sera déçu comme tant d’autres illusions, il me restera le Missouri!…
[4] Pétrus Borel était davantage un révolté qu’un révolutionnaire… les poèmes révolutionnaires de Pétrus Borel, quoique sincères, ne sont que des déclamations sans véritable passion. Pétrus Borel le Bousingo, Daniel Marc in Les Petits Romantiques Français.
[5] Gottfried Wolfang, racconto di Borel.
[6] Ultimo scritto dei Contes Immoraux, testamento autobiografico dell’autore.
[7] Je ne dirai rien de la peine de mort, assez de voix éloquentes depuis Beccaria l’ont flétrie: mais je m’élèverai, mais j’appellerai l’infamie sur le témoin à charge, je le couvrirai de honte! Conçoit-on être témoin à charge?… quelle horreur! il n’y a que l’humanité qui donne de pareils exemples de monstruosité ! Est-il une barbarie plus raffinée, plus civilisée, que le témoignage à charge?… Tratto dalla Notice che introduce Champavert, Contes Immoraux.
[8] Champavert, il Licantropo.
[9] De ma joie ennuyé la trouvais aride,
J’étais las d’un beau ciel et d’un lit amoureux.
Le bonheur est pesant; il assoupit notre âme.
Il éntreint notre coeur d’un cercle étroit de fer.
Heur et Malheur, poesia tratta dalla raccolta Rapsodies (1832) e dedicata al poeta Philadelphe O’Neddy.
[10] «Dans Paris, il y a deux cavernes, l’une de voleurs, l’autre de meurtriers; celle des voleurs c,est la Bourse, celle de meurtriers c’est le Palais-de- Justice». | «A Parigi esistono due caverne, una dei ladri, l’altra degli assassini; quella dei ladri è la Borsa, quella degli assassini è il Palazzo di Giustizia». Così si conclude Notice sur Champavert, il prologo ai Contes Immoraux.
[11] Champavert, il Licantropo.
[12] Bruto minore, per esempio, desolato: «Né scolorò le stelle umana cura», Leopardi.
Juliette sorpresa dall’alba nelle sue sfrenatezze notturne: «L’ astro del giorno, lungi dallo stupire dei nostri eccessi, mai si era, credo, levato più bello dal giorno che rischiarava il mondo», Juliette, Sade.
E il principe Mony dopo un’orgia di sventrati, escrementi e sperma getta mollemente il suo sguardo attraverso il finestrino del treno: «…per contemplare il romantico paesaggio del Reno che dispiegava i suoi splendori verdeggianti…» mentre «…alcune vacche pascolavano nei prati, e dei bimbi già danzavano sotto tigli germanici», Le undicimila verghe, Apollinaire.
[13] Protagonista di Passereau, l’écolier, novella dei Contes immoraux.
[14] «au milieu de toute cette morne et indifférente nature, presser dans ses bras un être tout de feu…».
[15] Bourreaux, arrêtez ma torture!
Le mal a fait mon cœur mauvais:
Haine à toi Dieu, monde, nature,
Haine à tout ce que je rêvais!…
Avant mon corps, sur cette roue
Où le sort le tient garrotté,
Mon âme expire, et je la voue
À Satan, pour l’éternité!…
Monsieur de l’Argentière, l’accusateur, sempre nei Contes Immoraux.
[16] Champavert, il Licantropo.
[17] «Le monde est un pipeur…», dall’Imitation de Jésus-Christ di Pierre Corneille.
[18] «Un ogre appelé Dieu vous garde un autre sort!», Rêveries, tratta dalle Rapsodies.
[19] Su destino, disgrazia, erroneità, effettività, limite, sguardo, evocazione, lascito di tale sussistenza occorrerebbe ben altra dissertazione.
[20] «Mais qui dit revanche ne dit pas renoncement», A. Hoog, La révolte métaphysique et religieuse des Petits Romantiques in Les Petits Romantiques français.
Ancora un piccolo spunto dal dialogo tratto dall’epigrafe del Sade prossimo mio di Pierre Klossowski: «…Il perverso insulta Dio per farlo esistere, dunque ci crede, dunque l’ama teneramente in segreto! Si crede così di poter disgustare il miscredente, di stornarlo dai suoi sani convincimenti».
[21] «“Sentivo la mia potenza, e sentivo dei ceppi” (Pétrus Borel). Ma questi ceppi sono amati. Senza di essi, bisognerebbe provare, o esercitare la potenza che dopo tutto non si è certi d’avere», L’uomo in rivolta, Albert Camus.
[22] «Je désirerais que vous me guillotinassiez».
Philothée O’Neddy, altro frenetico, strepitava: «A noi la ghigliottina!».
[23] «Faites-moi sauter le caisson».
[24] «Je ne me couvrirai pas la tête, la nature fait bien ce qu’elle fait, et ce n’est pas à nous de la corriger. Si mes cheveux tombent, c’est que mon front est fait à présent pour rester nu». | «Non mi coprirò la testa, la natura è sempre nel giusto in ogni sua azione, e non è a noi correggerla. Se i miei capelli si staccano è perché, ora, la mia fronte è fatta per rimanere nuda». L’ultima nota di Borel.
[25] La scommessa di Prometeo in Operette Morali, Giacomo Leopardi.
[26] Genèse de la Pensée Moderne, M. Jean e A. Mezei.