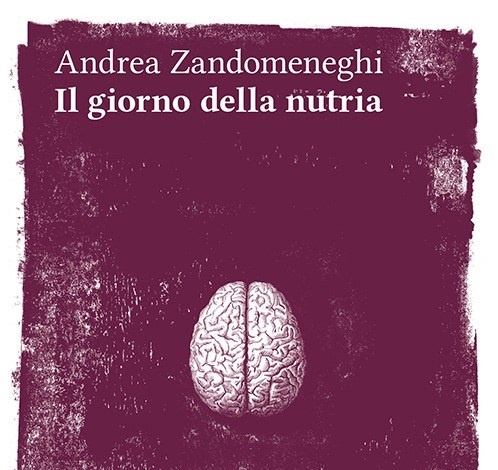Una sera, al ritorno dai campi, troviamo due uomini sulla piazza del villaggio. Il che è assurdo. Noi abbiamo il nostro e ci siamo completamente dimenticate che ne esistono altri.
Violette Ailhaud si presenta come una donna morta nel 1925 che nel suo diario racconta la storia: in epoca napoleonica, gli uomini di un villaggio vengono portati via dall’esercito e uccisi; le donne proseguono in maniera relativamente serena la loro vita comunitaria senza maschi fino a quando un nuovo uomo, Jean, compare all’orizzonte.
Jean è un personaggio cui mancano i contorni, è pura superficie nella quale si adagiano perfettamente le esigenze della protagonista e delle sue compaesane. Il rapporto speciale, amoroso, che l’uomo instaura fin da subito con Violette non compromette il lavoro che è chiamato a svolgere all’interno del villaggio: inseminare e soddisfare tutte le sue abitanti. Si potrebbe dire in effetti che l’unico tratto distintivo di Jean, oltre all’amore per la lettura, sia la piena consapevolezza della sua travolgente mascolinità e dei doveri che questa comporta. Eppure il trasporto emotivo cortocircuita con la necessità utilitaristica insita nel rapporto fisico tra i sessi.
L’uomo resterà nel villaggio senza averlo deciso insieme. Non sapremo mai se fuggisse da qualcosa o se fosse a caccia di qualcosa. Con Jean, la felicità ha fatto il suo nido nella nostra disgrazia e il resto non interessa a nessuna di noi.
Le donne formano un gruppo perfettamente organizzato, con un preciso piano d’azione da portare avanti (la prima a essere toccata dall’uomo ha la precedenza su di lui, per poi condividerlo con le altre), indipendenti nel loro sostentamento e bisognose del maschio soltanto in certi ambiti (mentre lui viene presentato come creatura da accudire e nutrire, in cambio dei suoi servigi) e tuttavia inquiete e insoddisfatte della loro vita, dominata da un soffocante senso d’immanenza e dal ripetersi dei lavori quotidiani. L’arrivo di Jean, il maschio, non è solamente avvertito come uno strappo alla routine o un’occasione per soddisfare le necessità fisiche delle sue ospiti, ma anche come un evento che conferisce un senso a vite vuote, trascorse tra doveri meccanici e privi di amore. Jean è tutto ciò che alle donne manca: le braccia perdute fatte per stringerci e rovesciare la pecora durante la tosatura, ma anche qualcuno capace di ristabilire un equilibrio perduto, necessario non solo per il perpetuarsi della specie, ma anche per definire meglio la propria identità.
Il racconto di Ailhaud sembra speculare alla mitologia erotico-bucolica di David Herbert Lawrence: è un’opera in cui la mascolinità è vista come altro da sé, come meraviglioso mezzo atto a portare vita, benessere e un felice sconvolgimento di cui godere per dare un po’ di fuoco (e di senso) allo scorrere dei giorni.
Ho sorriso e ho approfittato del mio uomo, fino all’alba, come la prima volta. La vita girava. Era stata dura e bella con noi. E lo sarebbe stata ancora.
L’uomo seme è una storia meravigliosa perché pura e carnale, priva di morale e solida come una parabola, in cui niente viene calato dall’alto, e dove si riesce a compiere il miracolo di dare ricchezza e spessore a personaggi che sono pure istanze limpide e complementari; e questo senza mai giudicarli, ma presentandoli nella loro transitorietà e nella loro intima e primitiva bellezza.
Il racconto sprigiona un fascino duraturo, in quanto capace di superare il momento della lettura per insinuarsi nello sguardo e nel cuore del lettore.
Violette Ailhaud
L’uomo seme (2006)
Trad. it. di Monica Capuani
Roma, Playground, 2014
pp. 58