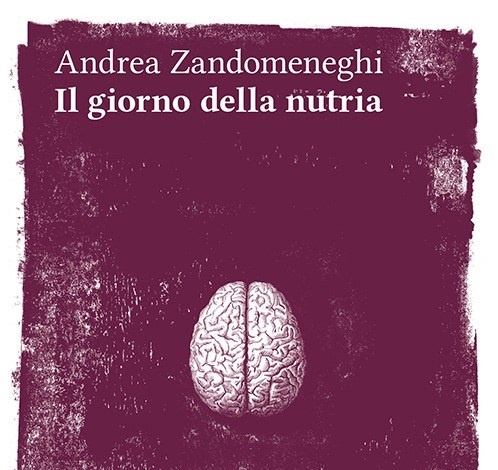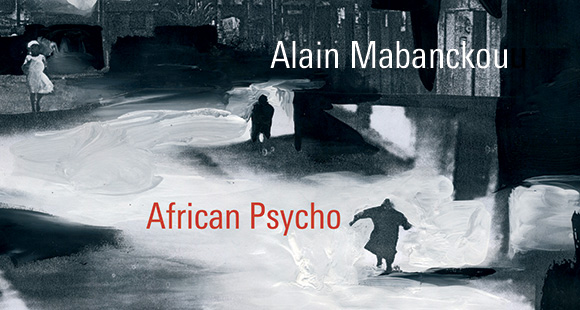
La gente comincia ad accorgersi che, per comporre un bell’assassinio, ci vuole qualcosa di più di due sciocchi, uno che ammazzi, l’altro che resti ammazzato, un coltello, una borsa e un vicolo buio. Un piano, signori, armonia scenica, luce e ombra, poesia, sentimento, sono ora reputati indispensabili a prove di questo genere.
(L’assassinio come arte, p. 15)
L’elemento più stimolante di questo saggio umoristico di Thomas De Quincey, che nel complesso potrebbe apparire un po’ datato al lettore contemporaneo, è la descrizione della dinamica in cui l’atto omicida, nel momento in cui diventa oggetto estetico, esiste quasi a prescindere da chi quell’atto lo compie, ovvero l’assassino: l’assassinio perde qualsiasi connotazione assertiva e ribelle, diventa una questione di etichetta, sminuendosi in asettico oggetto di studio per l’appassionato. L’imposizione della trascendenza a un’azione che è il non plus ultra dell’immanenza è uno degli artifici letterari più divertenti in cui mi sia imbattuta, soprattutto considerando il fatto che ritengo la dinamica dell’omicidio una perfetta rappresentazione del meccanismo sociale e comunitario nel suo complesso, a prescindere dalla brutalità dell’atto in sé.
Una delle opinioni più interessanti quanto opinabili sull’arte dell’omicidio proviene da William Munny, il protagonista de Gli spietati, impersonato da Clint Eastwood: è una cosa grossa uccidere un uomo, perché gli togli tutto quello che ha… e tutto quello che sperava di avere.
In letteratura (ma non solo, almeno da quel che si può dedurre dalla cronaca), raramente si uccide per uccidere, o si uccide dando valore alla vittima: l’assassino (o aspirante tale) desidera un qualcosa, e si rende conto che per raggiungere questo qualcosa il prezzo da pagare è far fuori qualcuno; il punto della questione diventa allora quanto è forte il desiderio, e, nei casi più riusciti, quanto si sia consapevoli delle ripercussioni del proprio agire. La vittima diventa funzionale al raggiungimento di uno scopo.
Un altro elemento che trovo interessante nell’omicidio è che sembra che per ammazzare qualcuno sia inevitabile ammazzare in qualche modo se stessi, o almeno una parte di se stessi. Se la spersonalizzazione della vittima, il non considerarla più come essere umano ma solo come mezzo/ostacolo nel raggiungimento di un obiettivo, è la base di ogni atto omicida, bisogna anche tener presente che per spersonalizzare l’altro in maniera così netta da decidere in piena consapevolezza di eliminarlo fisicamente occorra sentirsi spersonalizzati noi per primi, o per lo meno privati di un qualcosa che avvertiamo come fondamentale.
Una delle caratteristiche più irritanti di molti degli assassini in narrativa (e non solo in narrativa, sempre in base alla cronaca) è la loro prepotenza morale: le cose devono essere in una determinata maniera, la vittima sconvolge il loro ordine, e gli omicidi uccidono per ristabilire il proprio equilibrio, uccidono perché si sentono vittime, uccidono per evitare di sentirsi vittime; non riescono a vedere la loro umanità come un sistema complesso composto da infinite variabili.
Poi toccherà a lei chiedermi cosa ho fatto durante la giornata. Non posso certo risponderle: Amore, ho dimenticato di dirti che proprio la settimana scorsa ho messo un coltellaccio nella fornace per ucciderti quella sera stessa, ma alla fine mi è sembrata una roba talmente ridicola che ci ho rinunciato, comunque presto o tardi, vedrai, ti gratificherò con una bella morte, che ti libererà dei tuoi affanni quotidiani, basta con la gente che chiamate «quello lì», basta con i vecchi dirigenti d’azienda a cui il coso non si rizza mai, basta con i controllori ferroviari con il pancione che ti dicono di abbaiare bau! bau! bau! come un pastore tedesco o un bulldog, sì, ti ucciderò, e non essere arrabbiata se finora non ho ancora messo in atto il mio piano, è difficile per tutti, si fa quel che si può…
(African psycho, p. 120)
Il problema di Grégoire Nakobomayo, protagonista e voce narrante di African psycho, è che nei suoi progetti omicidi ci mette troppo cuore, e che, come ogni artista improduttivo, tende alla perfezione: troppa cura nell’identificare la vittima (la prostituta Germaine) e troppo l’affetto per lei (anche se lui si ostina a negarlo), troppa ansia da prestazione, troppo l’affetto anche per il suo mentore, il defunto pluriomicida Angoualima; per certi versi, forse, troppo studio. Grégoire fallisce perché non si annulla nell’omicidio e neanche si distacca da esso, ma cerca l’affermazione del proprio io in un atto che immagina puro e ribelle ma che, alla prova dei fatti, pur essendo la forma più pura dell’annullamento dell’altro, è forse il gesto più conformista che si possa immaginare.
A dar retta alle chiacchiere, ci sarebbe da supporre che tutti gli svantaggi e le noie consistano nell’essere assassinato, e che non ce ne siano affatto nel non esserlo. Ma la gente ponderata la pensa altrimenti.
(L’assassinio come arte, p. 61)
Grégoire, alla luce della sua fallimentare esperienza, potrebbe sottoscrivere con assoluta convinzione questa asserzione di De Quincey; e Mabanckou, smitizzando la figura dell’omicida, sembra suggerirci che non è un male non possedere il carattere dell’assassino; in un mondo di opportunisti e caricature, è palese che Grégoire ha un senso dell’identità troppo marcato, troppo deciso e troppo umano per uccidere chicchessia.
E se fantasticare su un omicidio è un modo come un altro per uscire brevemente da se stessi, l’assassinio vero e proprio appare come un atto da servi, sfigati, sconfitti, repressi.
***
Alain Mabanckou
African psycho (2003)
Trad. it. di Daniele Petruccioli
Roma, 66thand2nd, 2015
pp. 160
Thomas De Quincey
L’assasinio come arte (1827)
Trad. it. di Matilde Rio
Milano, Modern Publishing, 2010
pp. 102