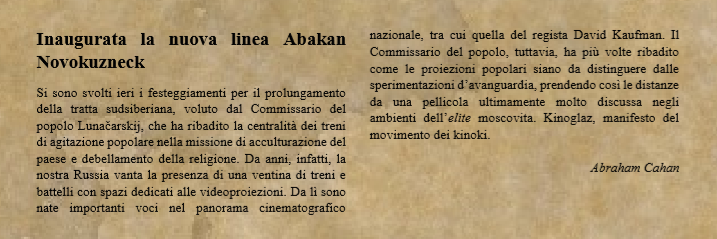Tutti sognano di volare, di macchiare con la loro piccola ombra le città e le campagne e festeggiare la fuga dalla schiavitù della terra; si innalzano verso le nuvole, le attraversano e proseguono la gloriosa ascensione, per superare i limiti come il famoso gabbiano di un vecchio romanzo.
Io invece affondo negli abissi. Mi immergo per centinaia di metri nelle buie profondità dove posso solo intuire le sagome dei pesci abissali, che nuotano indifferenti, mentre continuo a calare nell’oblio di una faglia sconfinata.
Apro gli occhi e ho la sensazione di essermi perso qualcosa di importante, come se fossi stato strappato alla verità nell’attimo in cui stavo per toccarla.
Dopo il sogno vorrei parlare subito con Giovanna, allora mi allungo su di lei per controllare. Dorme. Così rimango sveglio fino al mattino, quando Giovanna comincia a muoversi. Vado in cucina, preparo la colazione e aspetto che venga, per raccontarle del sogno, di come sembri reale. Giovanna dice che tutti abbiamo sogni ricorrenti e non bisogna farne un dramma. Lei sogna sempre di perdere il treno.
Ha la risposta pronta. Per questo è così brava a cucire: non esistono strappi che tengano per le sue dita. Semmai la realtà dovesse cominciare a smagliarsi, Giovanna con ago e filo ristabilirebbe l’ordine delle cose nel giro di un minuto.
Per me è colpa del magazzino. Da quando hanno unito i tre capannoni mi ritrovo a guidare il muletto in corridoi bui e isolati, lontani dal punto di consegna, dai colleghi, dalla civiltà esterna che prosegue la sua vita mentre io mi addentro negli angoli nascosti di un labirinto. È come calare nelle profondità oceaniche.
A volte mi fermo, scendo dal muletto e guardo indietro, nel silenzio degli scaffali. Ho bisogno di respirare. Se mi succedesse qualcosa? Un carico che crolla, un infortunio. Se mi allontanassi talmente dalla realtà da non potervi più tornare?
A Casagrande non accadrebbe. Casagrande ha le tasche piene di attrezzi, chiavi inglesi, cacciaviti, coltellini multiuso, taglierini, che subito avrebbe modo di usare per tirarsi fuori dai guai. E ha le mani enormi, degne estremità delle braccia che sono rami di quercia. Quando arriva in magazzino, col suo metro e novanta e il tintinnio degli oggetti che porta addosso, i colleghi lo ammirano come si farebbe con una divinità agghindata con gioielli e tesori ultraterreni. Si sentono al sicuro e lui dirige tutti da vero leader. Seguono la direzione indicata dalle sue braccia protese verso ogni settore, si dirigono verso gli scatoloni con fare appassionato, coltivano invano la speranza di diventare come lui.
Qui, da solo, in un disperso settore fuori dal mondo, non saprei cosa fare, e chiamare Casagrande, come un bimbo col papà, mi imbarazzerebbe.
Ho provato a portare pure io gli strumenti nelle tasche, per rassicurarmi, sorridendo amaramente a immaginarmi sul pavimento, schiacciato dal peso di un carico, senza possibilità né capacità di salvarmi.
Gli attrezzi mi ingombravano, mi sentivo un giocoliere da fiera. Gli altri mi guardavano e mormoravano tra loro:
«Vuole fare come il Casa!»
Ero un’imitazione fallita. La figura di operaio super organizzato non fa per me. Le tasche non fanno per me. Ci penso quando vado a prendere Giovanna al lavoro. Seduto in macchina osservo i passanti sul marciapiede. Scruto i rigonfiamenti dei pantaloni, le bozze sui lati delle giacche; riconosco le sagome dei cellulari, dei portafogli, dei mazzi di chiavi. Ma chi ha inventato le tasche? Basterebbe usare i borselli, e staccarsi un pochino dallo sfrenato contatto che abbiamo con gli oggetti.
Appena Giovanna entra in macchina glielo chiedo sempre. A cosa servono le tasche? Sorride con l’espressione dell’esperta, lei che ne cuce centinaia, migliaia.
«La gente ci mette i suoi problemi, nelle tasche», mi ha detto un giorno.
È una risposta che mi piace.
Stanotte sono entrato nella faglia. Capivo di essermi spinto oltre, di avere scoperto paesaggi nuovi, che seppure bui permettevano di distinguere gli anfratti, le spigolature, i dislivelli e le aree pianeggianti. Sono sceso in una gola abbastanza larga per le braccia aperte in una lenta planata nell’oblio. Sul fondo, se veramente fosse stato il fondo, ho cominciato a distinguere forme familiari. Gli scaffali del magazzino.
Non me la sentivo di raccontarlo a Giovanna. Sono giorni che parliamo poco o nulla. Le preparo la colazione ed esco, perché tanto si alza più tardi e non viene in cucina. Ho pure cambiato turni al lavoro, così non posso più andarla a prendere quando esce dall’officina.
È colpa del magazzino. Me lo ripeto di continuo, mentre guido il muletto lungo corridoi fuori dal tempo e dallo spazio e perdo contatto con il mondo reale.
Un giorno o l’altro comincerò a dissolvermi. Spariranno prima le mani, poi le gambe, rimarrà il tronco sospeso nell’aria e io terrorizzato a osservare il resto disgregarsi. Troveranno il muletto incustodito e nessuno si ricorderà di me, penseranno che qualcuno è tornato a piedi al punto di consegna. Una distrazione che può capitare.
Ieri Casagrande mi ha preso da parte per chiedermi se mi sentissi bene, mi vedeva strano. Gli ho detto che il lavoro va come al solito, forse non mi rendo conto della stanchezza reale. Mi ha messo la sua forte mano sulla spalla, senza aggiungere altro. Un gesto di sincero supporto, lo riconosco. L’avesse fatto con un collega, sarebbe stato come un rito magico per ricaricare le energie. La divinità che salva l’anima del devoto.
Ma con me è diverso. Non sopporto il suo modo di fare da padre protettore, da nume tutelare dell’inetto quale sono. Ma cosa vuole saperne lui, che ha le tasche piene!
In casa non riesco a riposare. Passo il tempo a pulire, a mettere a posto. Ho scoperto che ci si può dedicare alla cura di un appartamento con un impegno inimmaginabile. Per lavare per bene ogni angolo, per eliminare davvero la polvere, trascorro le giornate a smontare i mobili, passare lo straccio con l’acqua, annusare i detersivi agli agrumi e alla fine godermi l’opera seduto sul divano, con l’anima a sua volta ripulita dalle scorie.
Proprio mentre pulivo ho trovato un cacciavite dietro il mio comodino. Avendo smontato e rimontato ogni cosa doveva essermi caduto. Eppure non pareva mio.
Non è possibile infestare il mondo con tanti scatoloni. Ci sono giorni in cui penso che è tutta una messa in scena per creare lavoro. Gli ordini, le consegne, i camion che arrivano ogni mattina con la loro pestilenziale aura di nafta. Un meraviglioso e terribile teatro. I compratori sono attori assunti dalla ditta e io non faccio altro che caricare e scaricare tavoli, sedie, dondoli da giardino, gazebi, divani, poltrone, armadi, cassettiere, veri solo sulle bolle di consegna.
L’altra mattina ho provato a dirlo a Giovanna, volevo un suo parere. Ha fatto una muta alzata di spalle. Mentre speravo ancora che rispondesse, mi si è avvicinata per baciarmi la fronte ed è uscita per andare all’officina dove cuce cento, trecento, mille tasche e dentro ci nasconde le cose che non mi dice.
Nel pomeriggio ho guidato il muletto per corridoi e corridoi, fino al termine del terzo capannone. Chi mai avrebbe bisogno di lasciare merce utile così lontano? Negli imballaggi ci sono sassi. In questa organizzatissima farsa c’è qualcuno che passa il tempo a depredare le spiagge e riempire gli scatoloni di pietre.
Ho cominciato ad aprire gli involucri di cartone più facili da raggiungere, dovevo svelare l’inganno. In uno ho trovato le mie mani, nel secondo le mie gambe. Ne ho aperti altri. Ancora le mie mani e le mie gambe. Nell’ultimo un cacciavite. Il cacciavite trovato dietro il mio comodino.
Con le giornate che si allungano, le persone camminano più lentamente, si godono la luce. Posso osservare meglio le protuberanze delle loro tasche, così ingombranti, così goffe, sui leggeri vestiti quasi estivi.
La tasca interna della mia giacca è piena. Tocco il rigonfiamento che ho sul petto e mi sento soddisfatto. Ho capito. Le tasche sono utili quando si ha l’oggetto giusto da metterci dentro.
Dietro la porta a vetri dell’officina di Giovanna cominciano a muoversi delle sagome. Riconosco subito la sua. Minuta e leggera, sembra camminare sospesa a pochi centimetri dal terreno. Accanto a lei una sagoma imponente, con due grandi braccia che cadono lungo il tronco.
Poggio di nuovo la mano sulla mia tasca. Sento una forza mai avuta catalizzarsi nel contatto del mio palmo con il tessuto.
Le sagome hanno attraversato la porta e ora sono due persone sul marciapiede. Allora infilo la mano nella tasca interna fino a sentire il grilletto.