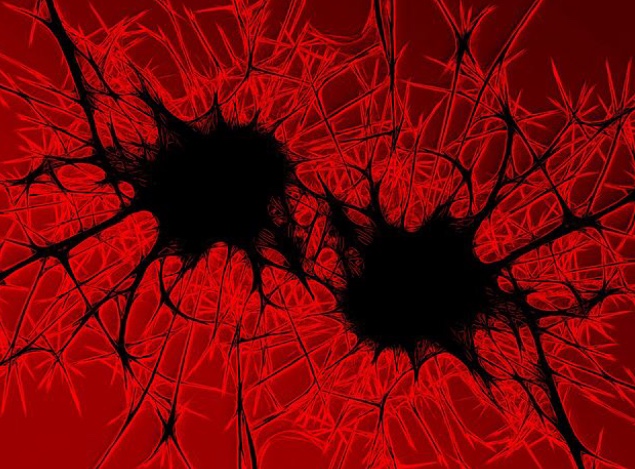Per tredici anni casa mia è stata la strada. Casa mia, di notte, prima di fare ritorno, in un viaggio lungo dieci minuti, alla casa vera. La strada si confonde spesso nell’immaginazione con il getto caldo di una malinconia. Risate, fumate, panico. Viaggi lunghi ore, viaggi nel silenzio, viaggi senza meta né ricerca. Viaggi per andare. «Andare è tornare a venire» dicevamo.
Tornato a casa tra le pareti. Quell’odore di famiglia, inconfondibile, più sacro del DNA e comunque meno oscuro, almeno interpretabile. L’odore che quasi promana come una nebbiolina dai corpi dormienti degli altri ospiti. La sensazione di vuoto che dà l’oscurità. L’orrore di vedere apparire una seconda faccia nello specchio grande. E sotto la faccia, un corpo che si mostra poco alla volta, seguendo la spigolosità delle ossa che neanche l’oscurità riesce a levigare. Preludio al dolce sonno o al collasso della droga. La notte – una cosa. Oggetto per eccellenza, eletto sopra ogni altro, mentale o sensoriale. Non più corpo mitico, ora che la viltà è un freno per andare fino in fondo. Poi il corpo dallo specchio, senza identità, viene fuori. Si mostra. La sua mano scabrosa per la magrezza, lo scricchiolio delle anche mentre prende posto in fondo al letto, e di nuovo la sua mano che mi stringe alla gola e mi apre ogni notte le porte della morte.
Lascia un commento