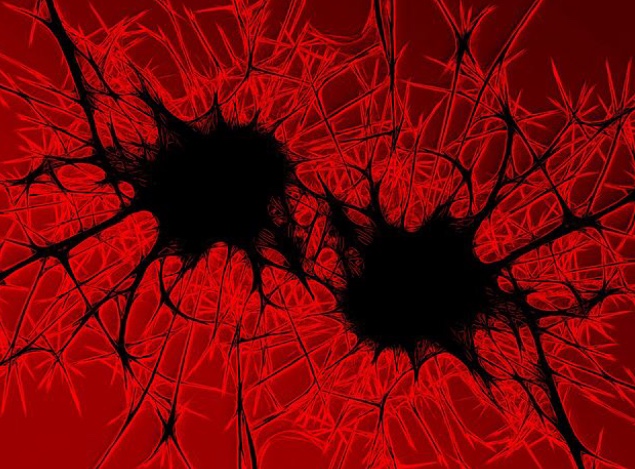La sovrapproduzione di grelina dovuta alla privazione di sonno in cui verso da giorni, deve aver alterato abbastanza significativamente la stimolazione del mio appetito, decisamente abbondante: sento lo stomaco rimpicciolirsi, fino quasi a scomparire nel centro del mio corpo, e questo mi induce a scrollarmi le coperte di dosso. Mi alzo con sorprendente agilità, anche se la tibia mi fa ancora un male cane, di quel dolore che raggiunge la sua effusione massima nel modo più subdolo possibile, espandendosi dapprima a chiazze, perdendosi in scariche puntiformi, e poi tramutandosi in un’unica e indifferenziabile superficie del dolore. Se non fosse per la luce emanata dallo schermo del computer, la stanza sarebbe completamente buia, mentre vuota lo è anche cosí.
Sto guardando quella che credo sia la quindicesima puntata di How I met your mother. Hanno trovato un ottimo intreccio per questa stagione, l’ultima, che pare essere incentrata integralmente sul matrimonio di Barney e Robin: si trovano tutti in un posto che non so nemmeno se esiste, in una locanda a Farhampton, e tutte le azioni significative, i racconti e le interazioni fra i personaggi, compresi i vari flashback e flashforward, si susseguono entro questa cornice. La puntata scorre, e fin dall’inizio è chiaro che il centro della narrazione dal Ted del futuro si è spostato a quella che era la vita della (futura) moglie prima di incontrarlo, a tutti gli incroci riusciti e mancati, ad ogni ineffabile scherzo del destino che ti cambia la vita se procedi con qualche minuto di ritardo o se invece arrivi con dieci minuti di anticipo ad un appuntamento importante: per anni, pare che Ted si sia pervicacemente esercitato nella straordinaria abilità di fallire la Storia per decimi di secondo, magari restando di spalle quando questa tizia gli passava dietro ecc. Tutto ben concertato visivamente, anche se una serie televisiva di questo tipo, quando si mette a giocare con le Moire, finisce sempre per cavarne una magra figura, giacché la necessità di rispondere ad una domanda di intrattenimento, in effetti, cioè l’esigenza di far sentire un congruo manipolo di ebeti, gli spettatori, come lettori di romanzi e di storie ecc., non fa che indirizzare preventivamente la risposta che una buona trama dovrebbe invece tenere nascosta, facendola emergere soltanto nel finale: bene, è bello che questa tizia abbia superato il trauma del fidanzato morto dopo anni di solitudine e amori posticci perché si imbatte in Ted, e che lui senta una versione de la Vie en rose suonata da lei all’ukulele per caso, in realtà ancor prima di incontrarla. Però si sposano, già me l’hai detto: voglio dire che, nonostante vi sia qualche notevolissima eccezione (penso a Mad Men, un vero e proprio Fitzgerald per lo schermo, o, per star piú sul moderno, uno Herzog dell’era digitale, una narrazione di altissimo livello), quella della fiction televisiva è letteratura posticcia, non brutta o bella, ma eticamente fallace ed inconsistente – anche se ammetto che di fronte all’amore disperato di Ted per Robin, e a tutto quel cercare il ciondolo e allo scavare sotto l’acquazzone, a lei che vola pacchianamente via come fosse una Madonna che ascende al cielo dopo le sue incredibili dichiarazioni e poi però la maturità che ha lui nel lasciarla andare, quel volare via, giustappunto, o la busta di plastica di American Beauty o la piuma di Forrest Gump, perché come si fa a non amare il tenero piccolo grande Forrest che ama la sua Jenny di un amore ingenuo e pertanto cosí sconfinatamente incommensurabile, cosí raccapricciantemente totale ed eterno, irrevocabile, tanto che ad una mia ex fidanzata parlavo, nei momenti di vera intimità, quelli in cui ci accingevamo a diventare «una cosa sola», come si sente dire in giro, quasi fossi la quarta di copertina di un libro posato sul dorso che aderisce alla superficie perfettamente piatta e suadentemente lignea di una scrivania svedese, senza che cioè geometricamente le due cose fossero piú distinguibili l’una dall’altra, ecco, a quella mia ex fidanzata parlavo imitando Forrest, che peraltro prima di stare con me non aveva mai visto, e allora io mi sentii in dovere di farle rimediare a questa penosa mancanza. Non che si tratti, è ovvio, di discutere del bene e del male: generalmente in un prodotto simile non accade mai nulla di eticamente rilevante, anche perché la morale è una stronzata, ma soprattutto poiché il racconto è teleologicamente orientato al lieto fine, anche se ci vogliono vent’anni, magari, e qualcosa mi dice che sarà cosí, per Ted e Robin, che con un pantagruelico colpo di scena torneranno insieme, me lo sento; però tornando a questa mia teoria del racconto o della narrazione, se il bene in quanto tale è posto come norma incondizionata, ovverosia se è il Bene, torniamo cosí piú o meno a Platone o peggio ci fermiamo dentro Kant, e insomma a Nietzsche non pensa mai nessuno. Perché a Nietzsche non vuole bene nessuno? A Nietzsche nessuno vuole bene perché era pazzo.
Per contro, anche se mi rendo conto che la cosa non è che c’entri moltissimo, ovverosia, non è che io sia tanto famoso o talmente importante da poter dire quello che sto per dire, ma lo dico lo stesso, nella mia idea di letteratura, che è un’idea del racconto, del raccontare, una cosa siffatta non dovrebbe mai accadere: è il raccontare, l’azione stessa, il parlare in atto, che deve prendere il sopravvento, in un elefantiaco vortice di corruzione e degenerazione, di fioritura e crescita, di vita e di morte, che coinvolga fino allo sfinimento e all’esasperazione, fino all’incubazione piú esaltante di ogni tormento o disperazione, anche di quelle disperazioni che si manifestano sotto forma della felicità piú inconsulta e debordante, indecente, sia chi parla e racconta sia chi ascolta. Bisogna amarsi e morirne insieme, non uno alla volta, e soprattutto non uno deve restare illeso a raccontare dall’esterno ciò che accade, a farmi credere che i fatti sono veramente andati così, e come sia stato bene che siano andati esattamente in questo modo, anche se ciò è avvenuto sempre al limite di circostanze che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi. È andato tutto bene, ma poteva andare anche tutto male. La trovo una presa in giro, questa, perché nella vita non è mai cosí: mi sembra che nella vita, se una cosa può andare male, lo fa, non è che sta lí ad allacciarsi ad un intreccio narrativo che piega quella determinata evenienza alla struttura teleologica che hai in testa secondo cui ti stai raccontando quello che ti sta succedendo, il che peraltro ci porterebbe a considerare quell’incredibile e fatale conseguenza che la nostra vita è nulla perché è soltanto la forma di ciò che ci stiamo raccontando vivendola, e tutti noi, credo, avremmo fatto esperienza di quella straniante sensazione distanziante, rispetto alla cosa che la parola dice, che è la presa di posizione del significato all’interno della parola medesima come suono che batte contro le corde vocali e diventa la parola fisica ecc. E per far questo, insomma, mi pare abbastanza scontato dover concludere con me stesso che dovrei allinearmi ad un tipo di narrazione che sia totalmente anti-etico, con venature nemmeno troppo sottili o raggrinzite di antiestiticismo – ecco, sono un critico letterario, ho creato un nuovo genere –, probabilmente un vilipendio alla vita, anche se una qualche forma di intrattenimento è talvolta necessario.
E poi mi metto a scrivere quanto state leggendo. Adesso sono io che vi ho in pugno, come se mi trovassi nella torre di controllo di un aeroporto e la vostra sopravvivenza nel bel mezzo di una bufera dipendesse dalle indicazioni precise ed inespugnabili che dovrò dare al vostro pilota. Ho sentito parlare di questo fidanzato morto. Questo è un lutto reale; io sono abbastanza giovane, sicché di lutti reali in amore non ne ho ancora affrontati. Ho sempre sostenuto, però, forte del mio caro Roland Barthes (cfr. Frammenti di un discorso amoroso), che il lutto amoroso fosse più ingombrante, e per certi versi piú insolubile di quello reale: se è vero in effetti quello che dice Barthes, io del lutto amoroso non posso liberarmi, dal momento che sarà destinato a imperversare nel mio immaginario, senza che io possa mai fare niente per porvi rimedio. Il lutto amoroso è un lutto senza fine, una morte continua: è come se viveste, per tutti i giorni della vostra vita, insomma tutti quelli che vi restano da vivere, anche se non sapete quanti precisamente, lo stesso e unico giorno, ed è come se quel giorno cominciasse facendo colazione con l’amore della vostra vita, e poi puf, gli vedete smettere di pulsare il cuore o l’anima accartocciarsi proprio lí davanti ai vostri stessi occhi, sempre ogni sera prima di andare a dormire, e ogni giorno sarebbe cosí, ogni mattino dovreste cominciare daccapo, magari certo gradualmente pensando che ogni giorno la sua presenza antimeridiana sia un po’ meno plausibile se deve scomparire ogni sera prima di coricarsi con voi, ma poi vai a capire cosa succede veramente nella vita. Ad ogni modo, mi sento abbastanza sicuro nell’affermare che il lutto reale è prima o poi ratificato dal convincimento razionale che l’altro corpo è non più fisicamente esistente: puoi parlare al cielo o al mare o al vento quanto vuoi, ma non otterrai nessuna risposta, e stai pur certo che nessun teschio scarnificato farà capolino dalla terra con gli occhi di un tempo al proprio posto. «Che la terra ti sia lieve» col cazzo, diciamo. Ecco, il dramma dello sguardo: se c’è una cosa che davvero ci restituisce l’intimità con un’altra persona, questa è esattamente l’espressione che ci rivolge con gli occhi, una sembianza che se cambia rischia di scompaginare l’intera esistenza, un evento al cospetto del quale la totalità delle cose è destinata ad impallidire e a battere in ritirata. Provate a diventare intimi con dei vermi che si trascinano lungo le ossa del cranio dell’amore della vostra vita. Ecco, proprio cosí.
In un certo senso, è anche vero però che nel lutto amoroso io sono prigioniero della letteratura, e va da sé che, se sono particolarmente sensibile ai racconti, liberarmi di una cosa del genere risulterà compito ancor piú gravoso e monopolizzante, sfiancante. Non vado avanti non perché non lo voglia o perché in verità non sia già successo, ma perché mi piace che sia cosí: traggo piacere estetico nella fruizione del racconto del mio dolore, che peraltro posso ogni volta reinventare, innescando un gioco senza fine. Dunque si tratta di una competizione non semplicemente masochistica, poiché non è il dolore in sé a costituire qui il principio di piacere, bensí il racconto. Ho bisogno di raccontarmi che sei tu quella persona, quell’unica persona la cui vista mi sferza le ginocchia, con gli occhi mutati, se una coincidenza ferroviaria riesce a tirare brutti scherzi, e ho bisogno di questa storia per giustificarmi di fronte ad una pretesa maturità emotiva, ad un nuovo corso, talché nella corte del mio immaginario rimanga sempre tu la mia regina piú viva e al contempo la piú inesistente summa di tutte le inesistenze.
Ma, per l’appunto, sei solo letteratura. Vali quanto una parola. Cioè niente.
La felicità e l’infelicità sono concetti sovrastimati.
Che cazzo me ne fotte, dico io.
***
Questo racconto è apparso su Ô Metis IV – Forme brevi.